
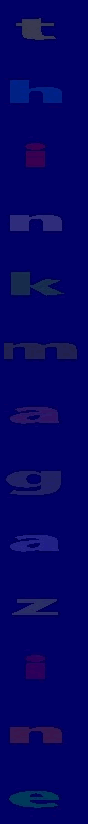
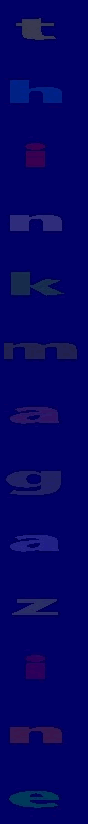
Al di qua del principio di piacere
(prolegomeni a una relativa metafisica, 1)
"Cosa ci faccio io qua? Cosa ci faccio io qua?"
(Uno spermatozoo negro, immerso in una folla di spermatozoi bianchi, in Tutto quello che avreste voluto sapere sul sesso, ma non avete mai osato chiedere di Woody Allen)
"La natura non sbaglia mai, se non per divertimento"
(Tristram Shandy in La vita e le opinioni di Tristram Shandy, gentiluomo di Laurence sterne)
Animato da un lucido spirito ludico, l'alogico ma organico corpus dei corposi Saggi di Montaigne sa renderci partecipi, tramite l'osmosi della lettura, del suo benevolo umore, inoculando nel nostro pensiero il germe - della soddisfazione. L'esperienza estetica, al tempo stesso analgesica e conoscitiva, del contatto e del gusto di simili pagine comporta però l'assimilazione di idee che non possono piacere a chi non ha la bocca fatta ai piaceri dell'Analogica. Che la Logica, infatti, sia solo cosa di trastullo è idea che, anche ad oggi, non incontrerà facili consensi. Eppure Montaigne proprio non si capacita che un saggio della levatura di Aristotele abbia vergato in tutta serietà le pagine e pagine del Dell'interpretazione dando per sicure e valevoli proposizioni dedicate a una così "vana materia"(Saggi, II,12); l'interpretazione di Montaigne è quella di Crisippo, e cioè che lo Stagirita ne avesse scritto "per gioco e per esercizio", amplificata poi fino a ipotizzare, piùin generale, che i filosofi siano i primi a non credere alle proprie filosofaggini, e che vi si consacrino, nel modo pił dissacrante possibile, come a una "occupazione propria alla naturale curiosità"; insomma quasi come espletando un banale bisogno fisiologico. Ed anche se bisogna chiedersi, poi, quanto lo stesso Montaigne credesse a questa sua filosofaggine, la vanità pragmatica, al di fuori del piacere che ne ricaviamo, di una disciplina come la Logica, è solare. A che serve, infatti, questa sedicente scienza della verità che impaccia la nostra dialettica e sa andare avanti solo per tautologie?
Oggi, entrando nell'ultimo quarto del ventottesimo secolo dell'era olimpica, abbiamo una risposta incontestabile: la Logica, linguaggio prebabelico restituitoci dallo spirito saggio pentecostale del piacere, si è incarnata nel seno della tecnologia ed ha dato alla luce l'informatica, un messia mediatico che ha cambiato anche il modo in cui io vi sto scrivendo, e in cui voi mi state leggendo. Ma cos'è stato a dare, nel corso dei millenni, ai profeti e agli adepti del principio di non contraddizione e del terzo escluso, la forza di perseverare nella loro fede? Io credo questo: che un segnale fisiologico afferente uno dei nostri tre o quattro istinti fondamentali, che il piacere - avesse detto loro: sì. Ma quanto ho appena detto non sarà per caso una tautologia? Non facciamo forse tutto quanto facciamo perché ci piace, o almeno per evitare il dolore?
La cosa non va senza contrasto. E non sono stati in pochi, nella storia dell'umanità, a precipitarsi verso l'abisso della sofferenza, quasi vincere così la coazione a buttarsi. 'E stato per ovviare a questa plateale falla del senso comune che il grande Sigmund è incorso nel più grande dei suoi errori. Aldiquà del principio di piacere Freud vedeva soprattutto (se non esclusivamente) Eros; e non è difficile capire come, nella società sessualmente repressa dei suoi tempi, la maggior parte delle nevrosi fosse effettivamente da Eros causata. Aldilà, esasperando un gioco di parole schopenaueriano che vedeva il senso (nel senso temporalmente geometrico e unidimensionale) della vita nella morte, per Freud c'è solo Thanatos, una alquanto misteriosa (e fumosa) pulsione l'autodistruzione in perpetua lotta e dialettica con la libidine e con la smania di vivere. Ma l'animale uomo, naturalmente, è non solo molto più complicato, ma anche essenzialmente diverso da quello descritto da Freud. In armonia con i metodi dell'etologia, possiamo facilmente notare come, nella schematica descrizione dei comportamenti animali, gli etologi segnalino sempre, oltre a una congerie fortemente specifica di istinti secondari, almeno tre o quattro istinti fondamentali ('istinto', per come io uso la parola, è un calco sull'inglese 'instinct' che traduce la parola tedesca usualmente traslata in italiano con 'pulsione', con un'indebita, ma a mio parere feconda, dislocazione del termine da un chiuso ambito di psicologia del profondo a uno multidisciplinare centrato sulla biologia). E non si vede perché l'homo sapiens, che Darwin ha opportunamente sloggiato dal centro della natura, dovrebbe averne di meno (di istinti), o di diversi, o di più nobili, o di più contorti e autodistruttivi. Ma, più dell'etologia, a darci una mano è l'antropologia (che mi interessa solo in quanto etologia culturale, e quindi essenzialmente umana). Lo sapevate che studi condotti su tribù polinesiane hanno confutato l'idea centrale del complesso di Edipo e la sua afferenza alla sfera sessuale? In queste tribù il capofamiglia non è il padre, bens˙ lo zio paterno (che con la madre, sia chiaro, non è solito copulare); ebbene: i bambini manifestano tutti i segni del freudiano complesso di Edipo, ma non nei confronti del padre (che, a regola, dovrebbe essere il loro rivale sessuale), bensì nei confronti di quello zio! E' solare, a questo punto, che codesto complesso (come lo si dovrà ribattezzare?) o modulo comportamentale non attiene all'istinto/pulsione sessuale, bensì ad un altro, di cui Freud non si perita di parlare, che è, evidentemente, l'istinto 'politico', 'sociale', 'gerarchico', quello che ci spinge a trovarci un posto nel gruppo a cui apparteniamo (possibilmente: il posto pił alto) e ad essere riconosciuti come facentine parte, come esseri umani; un istinto che vorrei chiamare di Vanitas, e che andrà accostato al pur esistente, e già in parte sviscerato, Eros freudiano, che a sua volta vorrei ribattezzare, non foss'altro che per far polemica, Amor.
Ma c'è, naturalmente, almeno un terzo istinto, importante quanto questi due, che deve qua occupare la nostra attenzione. Cos'ha spinto, infatti, il nostro Sigmund a indagare i territori posti aldilà del suo principio erotico? Una qualche insoddisfazione per la sua mappatura della psiche, è chiaro; ma afferente a quale bisogno profondo? L'Amor non parrebbe entrarci granché, e, se pure la Vanitas può essere stata un forte stimolo, anche lei non parrebbe essere semanticamente abbastanza affine a quanto stiamo cercando. Bisognerà tirare in ballo, insomma, una terza entità, che chiameremo Curiositas, che comprenda in sé, secondo il semi-espresso dettato montaignano, sia il gioco che il sapere, così come il gusto per la ricerca, per il nuovo, e, addirittura, per il bello. Freud si credeva uno scienziato, e se, oggi, lo si può considerare al massimo uno sciamano invasato da furor poeticus, è perché il suo estremo tentativo di varcare le frontiere del conoscibile e del piacere si è espresso in un libro (appunto, Aldilà del principio di piacere) con una valenza estetica fortissima, di una poesia indicibile; ma, scientificamente, nella sua pretesa di aderenza a una qualche realtà fattuale, un magnifico disastro. Freud, lo ha detto benissimo, e con la consueta possanza concettual-espressiva, Harold Bloom (in Il canone occidentale), sarà ricordato come un grande saggista, uno scrittore sapienziale come Montaigne e Nietzsche, e come il letterato che ha sfidato il rinunciatario Amleto di Shakespeare nel tentativo di mappatura dell' "undiscovered country" delle cause prime e dei moventi ultimi, nello sforzo di calcolare quel residuo di silenzio che è l'incombenza della nostra morte, nello strazio di dire il nulla, e l'ineffabile e infernale assenza, e nell'analisi di quelle prove generali del dramma dell'inesistenza che è il nostro sonno, i nostri brutti sogni. Ma se Freud indaga la morte, non è per rigirarsi masochisticamente il coltello nella piaga, bens˙ per tentare di risargirla, questa piaga; non si lavora per conto di un inconsistente Thanatos, ma a tutto giovamento della corposa dea Edonè. Ma, attenzione (e qua siamo al cuore della questione), ogni Edonè può facilmente degenerare in una inerte e al contempo bacchica Evoè, in un festino orgiastico (sia pure dell'dell'intelligenza) che in ogni senso rifiuta la misura e che non può non finire che con la fine di tutte le fini, col sacrificio di noi stessi su un altare che ci libererà, insieme, del nostro sangue e di ogni timore e tremore. "There's the rub!". Ecco lo scoglio su cui non infrangersi, il 'riguardo', la colonna d'Ercole da non oltrepassare, la sirena di Thanatos che ci attira verso il suo gorgo: ogni dolore troppo forte per essere palliato o sublimato, ogni volontà eccessiva di amare, potere o sapere che non si riesca a spogliare dell'angoscia dell'impotenza, ci chiede di essere gustata e assaporata per rendersi digeribile, ed è in questa empia alleanza col nemico che ha luogo il trionfo della morte.
Torniamo a Montaigne, vero maestro di euristica ignoranza, di incommensurabile misura, di gaia saggezza. Per lui è il piacere la guida, colui che ci porta a rilasciarci nelle braccia della natura; e seppure anche "le mal est bien à son tour", lo è solo "à son tour" e per indicarci di cambiare direzione; bisogna diffidare di qualsiasi autocompiacimento masochistico, che non potrà che condurre all'imbecillità, o, nel migliore dei casi, anche solo a un'inutile infelicità. E', questa di Montaigne, questa sua facilità alla felicità, non il risultato di una fede, ma, certo, almeno di una certa fiducia. E, se proprio la vogliamo chiamare fede, lo sarà un po' nel senso jamesian-nicciano della volontà di credere, del: che importa se mi stimo dieci volte più di quanto non valga se grazie a questo riesco a valere anche solo il doppio di quanto non varrei stimandomi realisticamente fin da principio! Dove però, attenzione, il 'valere' non va assolutamente inteso nel senso metafisico-letterario che Nietzsche gli attribuisce; Montaigne vuole essere, esistere, vivere "ailleurs qu'en papier", "altro che sulla carta!" traduco io; e se per lui, come per Nietzsche, la sofferenza non è un'obbiezione alla vita, per lui, al contrario che per Nietzsche, la sofferenza non è neanche la marca della memorabilità:
Je passe le temps, quand il est mauvais et incommode; quand il est commode, je ne le veux pas passer, je le retaste, je m'y tiens (Io passo il tempo, quando è cattivo o disagevole; quando è agevole, non lo voglio passare, lo
riassaporo, mi ci aggrappo; Saggi, III,13)
Quasi a dire, parodiando Faust in anticipo sui tempi: -Sosta un poco, attimo; non sei poi così male...-. La sofferenza, insomma, è solo un'obbiezione allo stato delle cose, un segnale, per di più negativo, e nulla di più. E se ne può banalmente inferire, utilizzando i miei termini postfreudiani, che, se Nietzsche avesse trombato un po' di più, il ridimensionamento del suo Amor fino ad allora represso e quindi ingigantito, avrebbe riportato anche la sua faustiana e ipertrofica Curiositas, fortemente contaminata di Vanitas, a un livello accettabile, evitandogli una decina d'anni di demenza e di degenza manicomiale. La fiducia montaignana, insomma, è, come la fede jamesiana, qualcosa di funzionale; funzionale come si è paradossalmente dimostrata l'astrattissima Logica aristotelica, funzionale come tutta quanta la tecnologia, in questo opponibile idealmente alle scienze che si vogliono pure, o, come se ne dice, esatte: la matematica in testa, con il suo rifiuto di soluzioni statistiche, e con la sua folle e stupenda pretesa di una inutile (inutile? lo dirà il tempo, o forse nessuno: che importa!) dimostrazione. La tecnologia progredisce obbedendo alla legge del minimo sforzo: ogni generazione dovrà faticare meno della precedente grazie a nuove acquisizioni (idea messa in forma narrativa in un delizioso raccontino di Heinlein: L'uomo che era troppo pigro per fallire); o, altrimenti detta, per la legge del massimo piacere. La tecnologia è edonista; le scienze esatte, spesso, tanto affascinanti da essere alienanti, e, per così dire, 'evoiste' (penso ai deliri del Godel della dimostrazione logico-ontologica dell'esistenza di Dio).
Ma, arrestando per un attimo quest'orgia di sproloqui assertivi che vi ho danzato finora, vorrei chiedere: cosa cazzo sono venuto dicendo? Questa, signori miei, è letteratura. Letteratura che, come nell'ars poetica di Sermonti (in Ho bevuto e visto il ragno), infilza, o tenta di infilzare, "sillabe belle di parole buone/(...) perseguendo l'espressione/ confacente al concetto e alla passione":
e cantileno e allìttero ed irrido;
ma se la rima non mi dà ragione,
io non mi fido.
Diceva Kubrick che, se riusciamo a fare un discorso brillante a proposito di qualcosa, abbiamo la sensazione di tenere quel qualcosa sotto controllo.
Illusione? Tutto sta a vedere se quel discorso, per quanto brillante, si rivelerà funzionale; ci penserà, ad eliminarlo, nel caso, una sorta di selezione naturale delle idee. Mentre, nel frattempo, io mi terrò la mia fiduciosa concezione estetica della vita, e della scienza, guardando a queste umane arti come ad un assenso della natura: una gratificazione dei vari sensi, che non ci distoglie affatto, anzi ci concentra, nei confronti del nostro sesto, e pił importante, senso, quello propriocettivo (Un termine, propriocezione, che vorrei astrarre dal ristretto ambito clinico, per usarlo in un senso più lato, al contempo però restando in un ambito neurologico, quello della neurologia narrativa, o addirittura drammatizzata, di Lurja, Oliver Sachs, nonché di Herbert George Wells, Beckett e Pinter). E' da questa posizione che invito chicchesia a rispondere per le rime a queste mie rime in prosa, scritte in lode di Edonè. Mi capita spesso di imbattermi in difettivi sillogismi di gente che temo troppo 'loica' (e in bilico verso l'adorazione di Evoè), col piacere, lo scetticismo e il turbamento con cui leggo certi aforismi di Nietzsche. "Io sono tutto corpo. Quando parlo di 'anima', parlo di qualcosa che è parte del mio corpo" diceva questi. E credo proprio che avesse ragione. Purché, contro Nietzsche, non si trascurino i segnali del corpo (cioè, a questo punto, del nostro sé inteso nella sua integralità), dei quali non èmai inopportuno riappuntare il promemoria:
dolore = cambiare, please
gonfiore di coglioni = trombare, please; curarsi dell'Amor
frustrazione = segnalarsi socialmente, please, o la Vanitas (anche lei) va a puttane
noia = stimolare la Curiositas, please
piacere = avanti così, ragazzo!
imbolsimento = basta, grazie
Purché non ci si scordi, insomma, che, se l'anima è corpo, allora il corpo è anima.
Giulio Braccini