
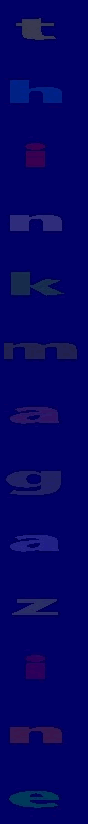
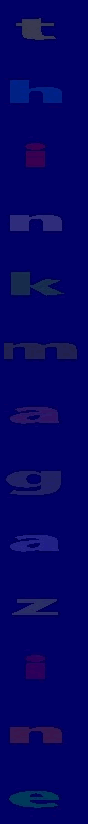
Panta rei: fluire é un po' fuggire
Riflessioni a proposito de L'Atalante di Jean Vigo
Acqua, amore e cinema: il senso dello sfuggire
Appare chiaro fin dalla prima sequenza che L'Atalante è un film d'amore, o meglio sull'amore.
Tema esplicito, praticamente dichiarato. Un matrimonio è l'inizio di tutto, il suggello legale di una storia d'amore, il suo riconoscimento sociale: sposarsi è un mettersi in regola, uscire dalla clandestinità della passione. Ma qui non c'è un banchetto di nozze e poi una casa; soltanto un misero corteo che accompagna gli sposi fino alla barca, sul fiume, e subito l'addio della sposa al paese, alla madre: fuggire quindi, o meglio sfuggire. Non è opportuno parlare di fuga per L'Atalante, la fuga è notturna, qui il gioco è più raffinato, si bara sotto gli occhi dell'altro, alla luce del sole.
Juliette, la sposa, cambia mondo, così, senza festa, per poco anche senza il bouquet di nozze, in cerca di qualcosa d'altro, qualcosa di diverso, l'amore appunto, un amore portato dal fiume, un amore da scoprire e per scoprire.
Partono quindi, e il film ci è già stato consegnato tutto, tutti i suoi elementi, o meglio i suoi umori (perché si tratta di un film essenzialmente di umori più che di fatti).
Elementi, o piuttosto l'elemento, l'unico materiale di costruzione del film, l'acqua, presenza costante, al di là della sua apparizione o meno, al di là dell'essere vista o meno; l'acqua sorregge il micromondo dell'Atalante, lo porta, lo accompagna e addirittura lo avvolge: l'Atalante è un mondo sottomarino, nel suo ventre i rumori sono smorzati, le cose sono vicine, tutte, e si confondono, i loro confini si fanno incerti innescando una sensazione, o meglio un'illusione di seduzione. Nasce una voglia di altro, l'altro che cova quieto dietro al lavoro duro, dietro a ciò che appare in genere.
C'è la seduzione di ciò che non si vede, la voglia di partire per cercare qualcosa che sappiamo esistere pur senza conoscerlo, lasciare tutto. Sfuggire, appunto, intenzione centrale, o meglio tensione che muove da dietro, che non si lascia guardare in faccia, non si dichiara ma più semplicemente e più efficacemente guida il gioco, si manifesta.
Juliette sfugge alla famiglia; sfugge anche all'abbraccio del marito, ha ancora l'abito da sposa indosso, non possiamo pensare ad una perdita di passione, forse è la naturale paura del nuovo, dell'incognita, forse nostalgia di ciò che ha appena perso. O forse è proprio quella tensione, quel senso dello sfuggire che da dietro, senza essere vista, senza ragione muove le carte in tavola, scombina i piani ancora una volta sotto gli occhi di tutti, conduce il gioco o meglio è il gioco, il gioco della seduzione.
Tutti sfuggono, prima o dopo, nell'Atalante: sfugge père Jules, infastidito dalla furia del capitano che gli ha distrutto la cabina-museo, ma soprattutto infastidito dalla nuova situazione, dalla presenza dell'elemento femminile, infastidito e attratto (e ancora una volta il movimento viene da dietro le quinte); sfugge Jean ferito dalla fuga in città della moglie: e qui è il massimo, è sfuggire dalla fuga dell'altro, è sfuggire allo sfuggire, quindi è desiderio di restare. L'elemento maschile emerge, opera in Jean. Tutti sfuggono, quindi, ma ognuno a suo modo, secondo la propria natura.
Ma l'Atalante è mondo sottomarino, abbiamo detto, e la voglia d'altro è illusione d'altro. Juliette ci svela il segreto, il segreto di questo film o forse il segreto di ogni film: aprire gli occhi nell'acqua per vedere ciò che non si può vedere ma che vorremmo vedere, che avremmo sempre voluto vedere.
La visione dell'amore è visione del cinema stesso, visione subacquea.
Visione o anche previsione; Juliette vede Jean prima di conoscerlo, ancora una volta nell'acqua, prevedendolo, quindi, in un modo tutto al femminile, dove la sensibilità quasi magica, quasi veggente si fa progetto, diventa forma di vita, realtà.
Ed anche Jean avrà la sua visione, nel momento della disperazione, quando pensa di aver perso la propria sposa per sempre, quando crede di avere spinto il gioco oltre il gioco, anche se è un errore di valutazione dovuto forse ad inesperienza, non capisce che il gioco non ha confini, né forme definite, è gioco acquatico. Ed è la disperazione appunto a dare la "vista" al capitano, a fargli perdere la testa, a farlo perdere; è un perdersi nell'immaginario della moglie, un perdersi nel suo elemento (l'acqua è l'elemento femminile per eccellenza), un penetrare nel suo intimo: la visione di Jean è atto sessuale, è realizzazione della masturbazione della notte precedente.
Dunque Juliette ha una visione, Jean ha una visione e noi abbiamo una visione: L'Atalante è il nostro secchio d'acqua o il nostro fiume dove aprire gli occhi, dove perdersi nella fluidità del cinema.
Scorrere della pellicola e scorrere del fiume, tra film e vita tra illusione e realtà; forse di più che un parallelismo (è difficile parlare di geometria o meglio parlare geometrico in un mondo fluido), forse un sovrapporsi di due scorrimenti, lo scorrere della vita e lo scorrere del film, lo scorrere dei desideri e lo scorrere degli impegni, della routine del lavoro, lo scorrere dell'amore e lo scorrere del tempo.
Amore e tempo, binomio difficile, accoppiata esplosiva: l'amore che non si basta, che non basta a se stesso (Juliette sogna Parigi) e il tempo che non basta, non basta agli altri, non basta all'amore appunto, gli mette fretta senza avere fretta lui stesso, lo eccita, lo spinge a sfuggire. Ma il tempo sa anche calmare, acquieta le passioni: père Jules parla di "problemi" che certe foto gli procurarono con Dorothy, l'amore della sua vita, probabilmente, e lo fa con una risata; un giorno anche Jean riderà della fuga della moglie.
Scorrere del tempo e scorrere della pellicola, scorrere infinito, in entrambe i casi, e L'Atalante ci offre un immagine di questo fluire, un fotogramma del tempo. La pellicola scorre come il fiume tra due rive, due mondi immobili e per questo illusori, quasi inesistenti, pretesti per la vita a bordo più che realtà vere e proprie, immagini da immaginare, da desiderare per poter fuggire e poi tornare; l'illusione diventa la realtà "vera", il cinema diventa vita, la nostra esperienza filmica diventa interiorità.
E' proprio questa l'impressione che Vigo ci lascia, l'impressione di aver visto l'interno, di essersi visti dall'interno (il mondo sottomarino appunto); un interno che non corrisponde a nessun immaginario preesistente, un interno che non è caldo o accogliente, né brutale e sconvolgente, ma piuttosto è mobile, è fluido, non è , diviene. Ed è proprio questo il senso dello sfuggire: il divenire.
Sfuggire dall'immobilità quindi, diffidarne perché priva di senso, priva di realtà. Immobilità a cui Vigo non fa nessuna concessione: l'ultima immagine del film è l'Atalante che continua a navigare, va. E non sappiamo se Juliette sarà soddisfatta per sempre, (non c'è un matrimonio finale a bloccare tutto, a cristallizzare una situazione, qui il matrimonio è un inizio, per Vigo il matrimonio non è la tomba dell'amore) probabilmente no, non sarà soddisfatta, sicuramente no. Scapperà di nuovo, tutti lo faranno ancora, ci proveranno ancora perché questo è vita, è amore, è cinema.
Père Jules, il venditore ambulante e Parigi: il meccanismo dello sfuggire.
La voglia d'altro che lavora nel fondo dell'animo di Juliette, nella sua sensibilità, in un primo momento è un elemento inconscio, percettibile nell'aria (o forse nell'acqua) dell'Atalante, e segue un percorso di emersione scandito da tre tappe fondamentali: l'esibizione di père Jules nella sua cabina, l'incontro con il venditore ambulante e la fuga a Parigi.
E' un escalation di un sentimento, di una tensione che alberga fin dal principio nella giovane sposa: Nella cabina del vecchio marinaio il processo di esternazione, o meglio di rivelazione, inizia. Rivelazione appunto, perché Juliette non è cosciente di quanto sta vivendo, non c'è consapevolezza, quindi il voler uscire dal mondo chiuso, interno, dell'Atalante, è un qualcosa che progressivamente si svela alla sua coscienza e contemporaneamente alle nostre.
Juliette entra nella cabina di père Jules per ordinare la biancheria ma subito è rapita da questo micromondo, finora sconosciuto, pieno do oggetti esotici, strani, diversi, di "altri" oggetti.
E parlare di oggetti, non appena vengono visti da Juliette (ma non solo da lei) non è più appropriato, immediatamente divengono sogni, o meglio si rivelano per quel che veramente sono, pezzi di immaginario, pezzi di una vita da immaginare, una vita condotta altrove, un altrove assoluto.
Il fascino di quella vita scatta subito come subito scatta l'impulso di conquista del pirata père Jules: immediatamente è spettacolo, è mostra, è l'esibizione di una vita, di una persona. Il vecchio marinaio inizia a far muovere quel mondo strano, mondo fatto di preziosi oggetti da pattumiera, lo anima, muovendo un burattino direttore d'orchestra, facendo funzionare scatole a sorpresa. Juliette risponde, risponde ridendo, partecipando al gioco; gioco della seduzione quindi che qui è gioco due volte perché la realizzazione, il finale di qualsiasi seduzione, la conquista, è impossibile; si gioca a giocare.
Père Jules si scatena, passa da un ricordo ad un altro, impertinentemente sbatte in faccia alla ragazza la sua vita e se stesso, e lo fa fisicamente mostrando il più intimo, il più personale degli oggetti della cabina: i suoi tatuaggi, il suo corpo. Il vecchio si mostra. Così com'è . Juliette ne è turbata. E' il momento del risveglio interiore, del primo passo verso l'emergere dei suoi desideri, del suo volere, del suo io. E' Juliette che turba Juliette, non père Jules: lo abbiamo già detto questo è un corteggiamento senza esito, si cammina sulla corda ma con la rete di protezione.
Il gioco, il sapersi lasciare andare all'altro, è la differenza fondamentale tra père Jules e Jean, tra il marinaio e il capitano, tra il vecchio e il giovane. Jean è rigido, non si sa muovere, è immobile, non ha ancora imparato a vedere i suoi sogni nell'acqua, non ha ancora aperto gli occhi.
E' quindi ancora una volta il movimento, la fluidità, ad essere il motore non visto della macchina Atalante. I desideri di Juliette trovano nella cabina del marinaio uno spazio in cui muoversi e conoscersi, père Jules si muove per creare quello spazio: è vecchio e conosce le donne, forse anche la vita.
Il divertimento finisce con l'arrivo di Jean: infuriato nel vedere la scena, rompe tutto. Anche il legame tra i due sposi esce incrinato dalla furia distruttiva del capitano; non si vede, non è ancora palese, ma un processo è iniziato.
Jean promette a Juliette di portarla in città ma père Jules complica tutto: esce, se ne va. Ancora sfuggire. Niente da fare per i due sposini, quindi; il vecchio ha davvero acceso una miccia.
L'Atalante ha salpato le ancore e si è allontanato della città ma Parigi è ancora vicina, spande intorno i suoi profumi, le sue luci brillano nell'immaginazione di Juliette, la sua forza magnetica si fa ancora più forte; è normale, è così per tutti da sempre, ciò che ci sfugge è ciò che vogliamo di più .
Non poteva quindi esserci situazione migliore, terreno più fertile dove gettare i semi della curiosità.
Il venditore ambulante. Il suo ingresso in scena ci propone subito una nuova dimensione, una nuova visione. Scende dall'argine del canale con la bicicletta a tutta velocità, un enorme baule legato dietro, si toglie il cappello in segno di saluto passando tra i due, Jean e Juliette, dividendoli, appunto. Il baule si apre. E' un passaggio magico il suo, veloce, delicato e preciso. La musica si fa magica, suoni di campanelle, suoni luccicanti. Per Juliette è la prima figura del mondo esterno, immagine spensierata, divertente, accattivante.
Lo ritroviamo subito al café - bal dove Jean porta la sua Juliette a divertirsi. Scoppia lo show: il venditore si fa pirotecnico, diviene simbolo di tutto ciò che è fantasia, che è sogno. Strabilia con giochi di prestigio, diverte cantando, ammalia parlando; il suo baule è stracolmo di oggetti che ancora una volta non sono altro che strumenti d'immaginazione. Come nella cabina di père Jules, Juliette è rapita dal gioco e dai giocattoli; il venditore lo capisce, è furbo lui, conosce il suo mestiere e forse anche le donne. Tira fuori un fazzoletto di seta (la seta appunto, la stoffa con cui sono tessuti i desideri) lo cinge al collo di Juliette e la "rapisce"; la trascina nel ballo, accosta il suo corpo, si muove. Jean rimane al tavolo a fumare, immobile, ancora una volta.
La scena si conclude con un gran parapiglia, il padrone del locale infuriato per la presenza del venditore lo caccia, lui esce di scena ancora recitando ed ancora insidiando il cuore (ma forse non proprio il cuore) di Juliette, spensierato, ancora cantando; anche la fuga è magica.
Ormai è fatta, il meccanismo è in moto, Juliette è sbocciata, sente che vuole altro. Jean è arrabbiato, forse ferito, probabilmente si sente escluso; e lo è . L'incrinatura nella cabina di père Jules si è fatta profonda, è un processo che non può essere arrestato, o almeno non con l'immobilità del capitano; tornano al battello. Lui esce.
Venditore ambulante secondo tempo. Serenata con orchestra a un componente. Abbordaggio riuscito, appena il tempo per insinuare nei pensieri di Juliette una sola esplosiva frase: "vieni a Parigi"; Jean torna e lo caccia per sempre, ma inutilmente: ormai il suo lavoro è finito.
L'entrata in scena dell'ambulante segna il momento del consumarsi del distacco tra i due sposi, il venditore ha tolto la rete, il gioco si è fatto serio, si può anche cadere, ora.
Juliette ha ormai realizzato il suo volere, sa con precisione ciò che vuol fare: andare a Parigi. E' nel letto e sente ancora le parole del venditore ambulante, ma potemmo dire meglio del mago, e più che parole formule magiche. Davanti a lei ora c'è la possibilità reale di sfuggire, ha visto la strada.
La forza dirompente del camelot è il suo essere elemento vagante, il non appartenere a niente se non a se stesso, o meglio alla sua immagine; così come ci appare entrando in scena in bicicletta, egli è . La sua figura è l'espressione compiuta di ciò che si muove dentro Juliette, è la destrutturazione del reale stesso: il venditore è mago, va contro le leggi del mondo, le cambia, le trasforma, e tutto nelle sue mani diventa gioco. Anche il tempo; il camelot non ha passato, non ha storia, è eterno presente, un presente fatto di gesti, di parole, di illusionismo: il venditore è l'antitesi di Jean. Non ha responsabilità, Jean invece è il capitano, responsabile per definizione; il venditore non ha appartenenza, Jean appartiene al suo battello (il capitano è l'ultimo ad abbandonare la nave); il venditore è fluido, Jean è solido.
Siamo quindi precipitati in piena crisi coniugale o forse esistenziale (probabilmente è la stessa cosa), Juliette aspetta solo il momento buono per fuggire, andare a Parigi, solo per vederla e poi tornare. Il momento arriva e lei lo fa. Ma le cose non vanno sempre come si vorrebbe, Jean scopre la fuga, quindi salpa le ancore e se ne va.
Viene da chiedersi: chi è fuggito, Jean o Juliette? Lei vuole solo vedere Parigi, lui non vuole più rivedere lei.
Sono in movimento, sia lui che lei, hanno iniziato due percorsi diversi. Paradossalmente nel momento in cui si dividono fisicamente, la loro separazione è già finita, di qui in poi è solo l'attesa del ricongiungimento. E' bastato che anche Jean entrasse nella logica del muoversi, dello sfuggire, che il ricongiungimento si fa scontato, inevitabile.
Juliette arriva quindi a Parigi: vetrine, automobili e tutto il resto, ma la città si mostra subito diversa, la città ha un'altra faccia. La città è anche scippo, miseria. Ancora una volta per paradosso quando lo sfuggire diviene reale, in quel momento finisce, si immobilizza.
Sfuggire è quindi illusione. Non si può , se non dentro ad un gioco, se non per gioco. E così per ribaltamento delle parti l'Atalante diviene il luogo desiderato, il luogo altro, la meta verso la quale ancora una volta sfuggire. Movimento, quindi, solo movimento.
Ed è ancora una volta père Jules a muoversi per primo, o meglio a muovere, è lui che riporta Juliette sulla barca, la riporta al suo Jean; un Jean cambiato, che ha attraversato i territori della follia e del sogno, che ha capito che giocare è cosa seria, che il gioco è il cuore dell'esistere, che si è finalmente mosso, anzi di più si è fluidificato, si è mutato ed ora è animale acquatico.
L'esperienza di Parigi ha cambiato Jean più che Juliette; lei vi è semplicemente andata e tornata, delusa forse, ma non cambiata nel profondo, lei era già, per natura, per sesso, fluida. Lui invece ha dovuto tuffarsi nell'altro, nell'opposto a se stesso, ha dovuto cambiarsi nel profondo, nella sua materia stessa , è dovuto sfuggire a se stesso.
L'Atalante ci propone quindi una visione della vita e del mondo diversa, alternativa; ci propone una dimensione non strutturabile, (non ci possono essere strutture senza elementi rigidi) potenzialmente eversiva. Un vivere alternativo, un vivere tra due sponde, in territorio di confine, soggetto a mutamento, votato al movimento. Territorio cinematografico, dove la realtà è apparenza che si lascia penetrare, dalla quale siamo penetrati, ci lasciamo penetrare; visione da bere, da assorbire, visione che entra dentro e cambia ciò che avvolge, o meglio spinge a cambiare, a sfuggire, sfuggire da noi stessi verso altre realtà così irreali come questa a cui solitamente crediamo.
L'immagine fluida: la visione dello sfuggire
La geometria euclidea non esiste a bordo de l'Atalante; siamo in un'altra dimensione, la dimensione della distorsione, della rotondizzazione; due rette all'infinito probabilmente si toccano in quel mondo, o meglio non ci sono rette.
L'occhio della cinepresa non è mai in posizione "regolamentare", non è mai a misura d'uomo, è piuttosto l'occhio di un gatto (niente di strano vista la numerosa presenza felina sul battello) rannicchiato sopra qualche mobile, sul minimo spessore di una parete, su ogni, a noi impercettibile, occasione d'appiglio.
Le riprese dall'alto sono molte, non panoramiche, anzi l'occhio si spinge dentro, forza le figure dentro il quadrato dello schermo, riprende tutto distorcendo il tutto, trasmettendoci un morbido senso di curvo, di promiscuità, di sensualità.
Le immagini dell'Atalante sono per i sensi non per la ragione, sono immagini che sfuggono, difficili da distinguersi, o meglio da geometrizzarsi; è il loro fluire che viene percepito immediatamente, il loro mutarsi quasi senza una scansione ritmica, un continuo suono ascendente e discendente, senza pause e senza intervalli: glissati ascendenti e discendenti.
Immagine liquida quindi, immagine che come acqua arriva si adatta alle cose e poi prende e scivola via; e del resto l'acqua si vede dappertutto: quella del canale, la nebbia, la pioggia. Immagini che scivolano via dicevamo, immagini che non si lasciano trattenere, che non si lasciano immobilizzare, anche loro fluiscono e sfuggono, come fluiscono e sfuggono i personaggi, le situazioni e il senso stesso del reale e della vita.
Tutto questo diviene esplicito nell'immagine simbolo del film (o forse diventata tale per vie televisive), la visione di Jean. Non c'è più un solo piano, una sola pellicola, le immagini si sovrappongono, come fantasmi, veramente imprendibili, momentanee. Anche lui stesso, non solo noi, lui che vive dentro al film, che è il film, è stordito, perso, dentro un immaginario di solo movimento, la sublimazione stessa del movimento. Non nuota nemmeno, rotola nell'acqua, gioca con l'acqua, si perde nell'acqua e si libera nell'acqua.
Questo è L'Atalante, gioco acquatico dove perdersi e liberarsi, dove confondere tutto per vedere tutto; è gioco senza strutture e senza regole, è gioco del sentirsi, del percepirsi. E' gioco anarchico.
Massimo Chiellini
L'Atalante
1934
Réalisation: Jean Vigo
Scénario: Jean Guinée, Albert Riéra et Jean Vigo
Photo: Jean-Paul Alphen, Louis Berger et Boris Kaufman
Musique: Maurice Juabert
Avec : Michel Simon (Pére Jules), Dita Parlo (Juliette), Jean Dasté (Jean)
Durée: 89 min.