
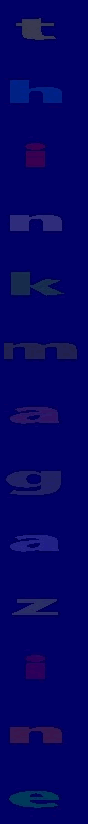
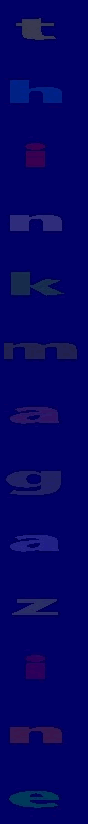
Bioetica e società
La fecondazione medicalmente assistita
Resoconto di una vicenda politica italiana
E' raro che in Italia le questioni bioetiche abbandonino l'universo delle discussioni tra tecnici (biologi, medici, filosofi, giuristi, teologi ecc.) per trasferirsi sui banchi dell'aula parlamentare: una sorte di questo tipo è però capitata al problema della fecondazione medicalmente assistita. L'introduzione di nuove tecnologie fecondative e il profilarsi di numerosi casi, che hanno suscitato clamori e polemiche, hanno fatto avvertire nel mondo politico l'esigenza di regolamentare giuridicamente le tecniche mediche di fecondazione artificiale e di fissare argini e puntelli nel mare magnum della questione, in modo da conferire stabilità e sicurezza alla spinosa materia. In quanto segue non intendiamo soffermarci sui meccanismi che governano la fecondazione medicalmente assistita, sulla liceità morale di queste tecniche oppure sull'opportunità e sulle modalità legittime di un passaggio dalla discussione bio-etica a quella bio-giuridica; tenteremo invece di ripercorrere il travagliato cammino della legge che fu presentata in Parlamento quasi un anno fa e di mettere in luce le ragioni etiche che hanno guidato la discussione politica. Il nostro intervento sarà dunque di natura esclusivamente descrittiva.
I Gli inizi
L'esigenza di una regolamentazione giuridica non è sorta improvvisamente ma è stata preparata da vari eventi. Non sono da sottovalutare i casi di cronaca, che hanno rivelato una pratica quasi selvaggia delle tecniche di fecondazione artificiale: un vero e proprio Far West di figli in provetta, maternità surrogate, inseminazioni "post-mortem". La frequenza incrementale di queste situazioni ha sicuramente spinto i politici italiani a legiferare in materia.
Già nel codice di deontologia medica approvato nel giugno 1995 (ma l'ultima versione approvata nel 1999 è sostanzialmente invariata circa questo punto) si faceva riferimento alla fecondazione assistita. In quel testo (articolo 41) si stabiliva che tali tecniche hanno lo scopo esclusivo di curare la sterilità "al fine legittimo della procreazione"; venivano inoltre vietate nell'interesse del nascituro la maternità surrogata, la fecondazione artificiale al di fuori del matrimonio, nei casi di menopausa non precoce e nei casi in cui sia morto il coniuge. Erano altresì vietate discriminazioni razziali, selezioni del seme a scopi eugenetici, sfruttamenti a fine di lucro o di pubblicità di gameti, embrioni e tessuti embrionali o fetali.
Nel 1996 il senatore del Ppi Severino Lavagnini presentò al Senato un disegno di legge sulla fecondazione assistita: nella relazione introduttiva si denunciava il vuoto legislativo esistente in Italia, al contrario di altri paesi europei come la Francia, e si specificava il principio che ispirava la proposta: la tutela assoluta dei diritti del nascituro "il quale fin dal concepimento è un essere umano a pari titolo del già nato".
Punto cardine, assente nel codice di deontologia medica, era la proibizione della fecondazione eterologa; essa infatti genera una doppia paternità, con ricadute pericolose di carattere sociale e psicologico: si trovano a rischio sia l'assetto del nucleo familiare tradizionale sia la futura personalità psichica del nascituro. La proposta di Lavagnini non ebbe fortuna.
La situazione giuridica rimase in sospeso per due anni, finché la Commissione Affari Sociali della Camera non licenziò nel 1998 una proposta di legge frutto di un intenso lavoro e di una faticosa mediazione tra valori laici e valori cattolici. Si approdava anche ad un orizzonte nuovo, come il titolo della proposta metteva già in luce: "Legge sulla procreazione medicalmente assistita" e non semplicemente "Legge sulla fecondazione medicalmente assistita".
Implicitamente l'accento si era spostato dall'esclusiva attenzione per i diritti e gli interessi del nascituro ad una considerazione più globale dei processi fecondativi assistiti, che toccava anche la parte della madre. Una novità consistente era anche insita nelle proposte effettive della legge: veniva permessa la fecondazione eterologa; veniva fissata l'età minima per i donatori e se ne tutelava la privacy; si riconosceva il diritto al disconoscimento della paternità; si vietavano la sperimentazione sugli embrioni (tranne nei casi in cui sia necessaria per motivi terapeutici e diagnostici) e la clonazione umana.
Oltre a ciò veniva ribadito il fine esclusivamente terapeutico delle tecniche a cui si permetteva l'accesso soltanto a "coppie di adulti maggiorenni di sesso diverso, coniugate o stabilmente legate da convivenza, in età potenzialmente fertile e comunque non superiore a 52 anni" (art. 5, comma 1).
Relatrice della legge per la Camera dei Deputati era Marida Bolognesi, deputata nelle file dei DS e presidentessa della Commissione Affari Sociali. La stessa Bolognesi, in un'intervista del 31 gennaio 1998, motivava alcune significative esclusioni dall'accesso alle tecniche riproduttive artificiali. Alle donne single veniva negato il diritto alla fecondazione assistita per l'assenza di un ampio consenso politico su questo punto e per la mancanza delle condizioni politico-culturali necessarie alla promozione di una maggiore autodeterminazione della donna in campo procreativo.
Inoltre, per ciò che riguarda il divieto di tecniche come la fecondazione post-mortem, la maternità surrogata e le sperimentazioni su embrioni, la loro proibizione era dettata dalla impossibilità, in questi casi, di tutelare la salute e i diritti etico-giuridici del nascituro. Oltre a cercare un equilibrio tra progresso della scienza ed esigenze della morale, la legge mirava a conciliare valori laici e valori cattolici.
II Alla camera dei deputati. La fecondazione medicalmente assistita eterologa
La discussione della proposta di legge e degli emendamenti proposti dai vari schieramenti occupò i lavori della Camera fino ai primi mesi del 1999. Il punto nevralgico della legge, su cui non si riusciva a trovare un accordo tra le varie parti, era rappresentato dal comma 3 dell'articolo 4:
"Il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo è consentito solo qualora non possa procedersi all'utilizzo di tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo omologo o qualora sia accertata la sussistenza di gravi malattie ereditarie o infettive trasmissibili [...]" Proprio queste righe vennero contestate dalle forze cattoliche e non: la votazione finale all'emendamento che rimuoveva il comma 3 vide infatti Lega Nord, Polo (con alcune eccezioni in Forza Italia), PPI, Cristiano-Sociali, UDR, minoranze linguistiche e componenti del gruppo misto schierarsi compatti contro l'apertura verso la fecondazione eterologa.
Oltre a ciò vennero anche rimossi gli articoli 8 e 9, sulla donazione dei gameti e la costituzione di centri di raccolta e conservazione degli stessi.
Le reazioni non tardarono ad arrivare. La Bolognesi affermò di vedere stravolta la sua proposta di legge e le parlamentari DS, in un comunicato stampa, usarono parole di fuoco, definendo la decisione della Camera l'espressione di una "cultura ostile e diffidente nei confronti delle donne che vede nella loro libertà, nella loro autonomia, nella loro responsabilità, nel loro diritto [...] a scegliere se e quando diventare madri, una minaccia [...] per tutta la società".
Veltroni intervenne sul Corriere della Sera (8/2/1999) manifestando la sua delusione anche in seno a considerazioni di principio: le modifiche alla legge imponevano codici etici e limitavano la libertà del singolo. La discussione, puntualizzava Veltroni, non si svolgeva più tra laici e cattolici ma tra liberali e conservatori.
Ma era volontà comune, come si era anche espresso Gianfranco Fini, porre fine al vacuum legislativo e di arrivare a promulgare al più presto una legge definitiva che regolasse adeguatamente la materia.
Chiaramente il punto cruciale sul quale si basava la divisione era quale legge fosse quella adeguata.
Dalla parte delle forze politiche che si avevano votato a favore degli emendamenti si registrarono vari commenti di soddisfazione per la bocciatura dell'eterologa, perché in questo modo si tutelava l'assetto tradizionale della famiglia, base essenziale dell'intera società, come anche si era espresso Antonello Soro, capogruppo PPI.
E una tale preoccupazione fu viva anche quando fu respinto l'emendamento che intendeva escludere dall'accesso alle nuove tecniche procreative le coppie di fatto (votazione del 24/02/1999); l'Osservatore Romano definì la decisione un voto contro "la famiglia. [...] Contro quelle famiglie normali la cui tessitura costituisce ancora il nerbo del popolo italiano" e ben presto si unirono alla protesta i rappresentanti dell'episcopato italiano, come Antonio Riboldi, vescovo di Acerra e Antonio Nuzzi, arcivescovo di Teramo.
III Embrioni adottivi
La discussione della legge proseguì e le divergenze si rivelarono acute anche su altri punti. Il leghista Cè, nella seduta del 24/03/1999, propose alla Commissione Affari Sociali della Camera di rendere adottabili gli embrioni non utilizzati nel processo fecondativo assistito (embrioni soprannumerari); i centri per la fecondazione avrebbero dovuto fornire al Ministero della Sanità due elenchi: uno di tutti gli embrioni di cui era noto il nome dei genitori biologici; l'altro degli gli embrioni di cui non erano disponibili tali informazioni. Questi sarebbero stati dichiarati immediatamente adottabili dal giudice tutelare. Gli embrioni con genitori biologici identificabili sarebbero stati impiantabili entro tre anni, dopodiché sarebbero divenuti anch'essi adottabili. A questa proposta si aggiunse quella del deputato Fiori (PPI), che consisteva nella limitazione al numero di tre degli embrioni producibili e quindi impiantabili di volta in volta, per evitare così il congelamento degli stessi.
Dietro questo rifiuto della crioconservazione embrionale si celava la volontà di non rendere gli embrioni dei semplici oggetti conservabili, da poter sfruttare al momento più opportuno e di riconoscere loro invece una dignità e uno status morale che li elevassero al di sopra del mondo delle cose. L'adottabilità degli embrioni fu presentata come norma transitoria, valevole cioè fino all'esaurimento degli embrioni conservati, dato che la seconda proposta vieta esplicitamente la conservazione; inoltre l'adozione di embrioni è per sua natura una forma di procreazione eterologa, vietata espressamente dalla nuova legge. La Commissione approvò l'emendamento del leghista Cè (18 sì, 16 no) in una turbolenta riunione che fu abbandonata dai Popolari; successivamente, nella seduta del 20 Maggio 1999, la Camera dei deputati approvò l'emendamento sugli embrioni adottabili, presentato dal PPI congiuntamente con centrodestra (AN, Forza Italia, CCD, Lega) e l'UDR, e quello sul tetto massimo (fissato a 3) degli embrioni producibili e impiantabili in una volta.
Così si concluse il tormentato iter della legge alla Camera dei deputati. Oramai il testo era pronto per divenire oggetto di discussione e di votazione alla Camera del Senato.
IV Ò La legge al Senato
Ricapitolando, i cambiamenti del testo della legge sulla fecondazione medicalmente assistita rispetto alla sua formulazione originale furono particolarmente pesanti: veniva vietata la fecondazione eterologa, si consentiva l'adottabilità in via transitoria degli embrioni congelati, potevano venire prodotti soltanto 3 embrioni alla volta che dovevano poi essere tutti impiantati contemporaneamente nell'utero della donna, si proibiva il disconoscimento di paternità nei casi di fecondazione eterologa.
Con questi punti fermi è stata presentata al Senato.
E'stato subito modificato il comma 2 dell'articolo 1, che da "il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora i metodi terapeutici non risultino idonei" è divenuto "il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora altri metodi terapeutici non risultino idonei" (corsivo nostro; da notare che la seconda formulazione è identica a quella del testo originale licenziato dalla Commissione Affari Sociali).
L'aggiunta di un semplice termine rende la procreazione medicalmente assistita uno dei tanti metodi terapeutici contro la sterilità e l'infertilità. Anche a questo proposito le polemiche sono fioccate numerose: il presidente dell'UDEUR ha messo in luce l'alternativa a una simile interpretazione della finalità delle tecniche di procreazione assistita. Esse "rappresentano soltanto una possibilità della scienza medica per soddisfare un desiderio individuale, press'a poco come la chirurgia estetica", fatta salva la loro specificità morale, e la reintroduzione dell'aggettivo altri avrà l'effetto "di far ricadere surrettiziamente le tecniche sotto il diritto alla salute". Mentre la discussione in Senato proseguiva, i ginecologi italiani hanno rilasciato una dichiarazione pubblica, prospettando le difficoltà insite nel decreto: non solo le spese mediche per sostenere una fecondazione assistita sarebbero state superiori alla disponibilità economica di molte coppie ma si sarebbero rischiati casi di 'turismo procreativo' in quegli Stati che permottono la fecondazione eterologa (es. Svizzera, Francia, Gran Bretagna e Malta). Inoltre le direttive approvate rendevano ancora più bassa della norma la percentuale di successo degli interventi fecondativi. Si è dimostrato d'accordo con queste critiche anche il prof. Luigi Cioffi, presidente del Tra-forum (Forum delle tecniche di procreazione assistita). Pochi giorni dopo, la legge è andata incontro ad una nuova mutazione sostanziale. Nella seduta del mattino del 7/08/2000, la senatrice DS Ersilia Salvato ha presentato un emendamento che prevedeva l'annullamento dell'intero articolo 1: in questo modo le tecniche di riproduzione assistita non costituivano più l'ultima spiaggia nella lotta alla sterilità ma potevano venire scelte come prima via verso la procreazione. Successivamente è seguita una serie di modifiche impressionanti. E'stata accettata la proposta dei Verdi di rendere legale la fecondazione eterologa, sovvertendo in questo modo, nel contenuto e nei motivi ispiratori, il testo della legge così come è stato approvato dalla Camera dei Deputati; si è estesa la libertà d'accesso alle tecniche di fecondazione artificiale anche alle coppie di conviventi e alle donne non più in età fertile; infine è stato inserita nell'articolo 6 la possibilità per le coppie che ricorrono alla procreazione in vitro di poter bloccare la pratica anche dopo la fecondazione dell'ovulo (ma non dopo l'impianto dell'embrione nell'utero).
Questi emendamenti sono stati possibili per l'assenza al momento della votazione di molti esponenti del mondo cattolico; una riprova è il fatto non è passata la modifica all'articolo 6, poiché al momento della votazione i cattolici erano presenti a pieni ranghi.
A quel punto le forze laiche hanno proposto di andare avanti, giudicando di non eccessiva importanza l'articolo 6, mentre le forze cattoliche esprimevano un parere contrario. Salomonica la decisione del presidente del Senato Nicola Mancino: votazione sospesa e rinvio della legge alla commissione, con la motivazione secondo cui "l'articolo 6 non lo possiamo liquidare in base alle convenienze momentanee come un articolo marginale".
Ma il 21 giugno è stato un altro giorno di fuoco per la legge.
In mattinata il Polo e il Ppi hanno presentato un emendamento che introduceva nel testo di legge il riconoscimento dei diritti del nascituro all'embrione.
L'emendamento è passato e il presidente del Senato Mancino ha giudicato valida l'applicabilità del provvedimento (con non poche polemiche).
Le forze laiche sono insorte, soprattutto dopo che è stato ripristinato nel pomeriggio il divieto sulla fecondazione eterologa, abolito nei giorni precendenti.
Ma a questo punto il caos normativo si è fatto evidente e sconcertante: il testo di legge oramai era divenuto un campo di battaglia, devastato dai continui e fra loro contraddittori emendamenti. Era pertanto necessaria la decisione presa dal Senato di sospendere la discussione e rimandarla sine die, prospettando anche un riesame del testo di legge in Commissione Sanità.
Con questi termini si è chiuso, seppur momentaneamente, il dibattito politico sulla procreazione medicalmente assistita.
V Conclusioni
Si è cercato di dare un resoconto breve dell'iter della legge e molte questioni sono state escluse; tra queste, non certo poco importante, è quella riguardante l'aborto, più volte sollevata dai politici durante il dibattito sulla legge della procreazione assistita.
Ma dal riassunto qui proposto si possono desumere alcuni interrogativi le cui risposte hanno guidato (e guidano tuttora) la discussione: fino a quali limiti si può estendere la tutela del nascituro? L'embrione ha diritto ad una tutela di questo tipo? Le tecniche di procreazione assistita sono una risposta terapeutica a problemi di natura fisiologica o sono invece un metodo per soddisfare alcuni desideri personali? Fino a che punto ha importanza morale la distinzione tra ciò che è naturale e ciò che è artificiale? E'davvero funzionale una legge che si occupi di tali questioni in dettaglio oppure è preferibile una blanda legislazione, che dia spazio all'iniziativa e alla libertà individuali?
Vorrei fare un'ultima considerazione. Soprattutto in Italia il dibattito bioetico è stato notoriamente caratterizzato dalla contrapposizione tra laici e cattolici; più volte si è tentato di operare una sintesi tra i valori espressi da una parte e dall'altra, cercando così un terreno comune d'intesa oppure di spostare la discussione su un altro piano, dove venisse meno l'opposizione laici/cattolici. La vicenda della legge che abbiamo esaminato mostra che, almeno a livello politico, questa opposizione è difficilmente trascendibile.
Matteo Galletti