
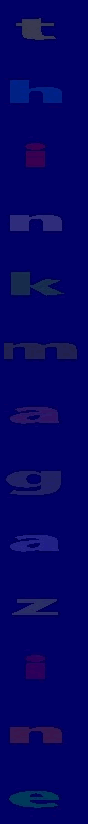
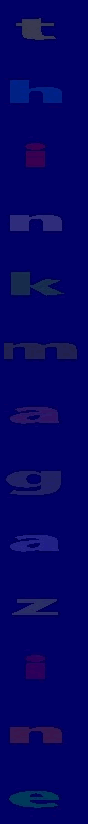
Identità, differenze, conflitti:
il problema del relativismo dal punto di vista morale
di Francesco Allegri
1. Premessa
A livello morale la polarizzazione tra identità e diversità di culture ha uno dei suoi risvolti più interessanti nella questione del conflitto tra codici morali opposti. Porsi questo quesito significa porsi il problema del relativismo, una questione quanto mai complicata, a partire proprio dal termine così semanticamente vago ed ambiguo. Ed infatti riguardo al relativismo non si danno idee chiare su che cosa consista ancor prima che sulla sua plausibilità o meno. Nei paragrafi successivi tenterò allora di fare un po' di chiarezza. Proverò a differenziare varie forme di relativismo in ambito morale, cercando di valorizzare le accezioni più rilevanti e meno banali (secondo paragrafo). Farò poi un excursus storico (sull'età moderna) per individuare possibili esemplificazioni degli schemi delineati (terzo paragrafo) e infine azzarderò alcune considerazioni sulla correttezza o meno di due delle tre forme di relativismo distinte, quelle tra loro connesse in quanto concernenti il discorso sull'etica e non il discorso propriamente etico (quarto paragrafo). Il tutto senza alcuna pretesa di esaustività o di completezza, essendo lo scopo di questo saggio più esplicativo che risolutivo, avendo cioe' di mira più la chiarificazione dei termini della questione (stabilire le condizioni che si devono dare affinche' risulti vero il relativismo etico, eliminando alcuni fraintendimenti tipici della mentalità prefilosofica) che non la loro soluzione (estremamente difficile, come d'altra parte per tutte le grandi questioni filosofiche).
2. Tipi e forme di relativismo nella sfera etica
In un articolo di risposta al vescovo di Como, Mons. Maggiolini, Eugenio Scalfari qualche anno fa sostenne che il relativismo morale e' un dato di fatto incontrovertibile e che sulla varietà dei costumi non era possibile una discussione seria essendo essa un elemento ormai appurato.1 Alla lettera, Scalfari scriveva:
Se (...) lei [Maggiolini] vuol dire che i canoni morali sono immutabili, afferma un principio che e' smentito da tutta l'esperienza storica. I comportamenti morali infatti sono variabilissimi in funzione dei tempi e dei luoghi, ciò che e' ritenuto delitto qui ed ora fu ritenuto lecito altrove e allora e potrà tornare ad esser lecito o addirittura raccomandabile in altri luoghi del futuro. Il relativismo morale non e' dunque una scelta arbitraria di certi intelletti ma un dato. Spero che su questo punto non vi sia discussione perche' non può esservi.
Mi propongo di far vedere che le cose non stanno esattamente così: il relativismo in ambito morale e' lungi dall'essere una verità scontata (si può anzi dubitare che sia una verità). La strada da percorrere per dimostrarne la plausibilità e' molto più complessa di quanto pensa Scalfari, che pone la questione in termini troppo semplici (vorrei dire semplicistici) e mescola insieme livelli eterogenei del discorso che e' merito dell'etica di lingua inglese (leggi: analitica) aver distinto. Nella letteratura etica contemporanea, la tripartizione di tipi di indagine in ambito morale (etica descrittiva, metaetica, etica normativa 2) si e' estesa (inevitabilmente) anche al problema del relativismo, seppur solo di recente. Si e' così arrivati a distinguere tre tipi diversi di relativismo: un relativismo descrittivo, un relativismo metaetico ed un relativismo normativo. Sulle specifiche definizioni non c'e' un accordo completo, si danno alcune differenziazioni, inevitabili quando si ha a che fare con termini indeterminati ed equivoci dal punto di vista semantico. In alcune definizioni, ad esempio, si fa riferimento a sistemi morali, in altre a principi etici basilari. Comunque, pur non essendoci unanimità, in linea di massima c'e' un'ampia convergenza nel definire relativismo etico-descrittivo (o relativismo etico-culturale), la tesi di natura antropologico-sociologica per cui ci sono almeno alcune credenze etiche fondamentali (principi etici basilari o sistemi morali) contrapposte. (L'almeno indica la condizione minimale. Poi ce ne possono essere alcune, molte o addirittura tutte). Che si faccia riferimento a credenze etiche fondamentali (si potrebbe dire principi etici basilari o principi morali ultimi) e non semplicemente a giudizi etici (a norme concrete), significa che non e' sufficiente, per parlare di relativismo in questo senso, che si dimostri la sussistenza di opinioni o pratiche dissimili ed anche contrapposte tra società diverse o tra epoche diverse. Perche' queste differenziazioni a livello di comportamento pratico possono tuttavia rimandare a principi ultimi comuni. Ad esempio, il fatto che io ritenga ingiusto maltrattare gli animali e che un cartesiano del Seicento non vi trovasse nulla da ridire, non prova ancora la verità del relativismo antropologico-descrittivo. Perche' il cartesiano del Seicento aveva delle convinzioni fattuali sulla natura degli animali diverse dalle mie (che sono quelle in voga tra gli etologi contemporanei). Per esempio, da buon seguace del maestro e di Malebranche, sosteneva la tesi che gli animali dal punto di vista ontologico non si differenziano dalle macchine, e come quest'ultime non hanno stati di coscienza. E può darsi benissimo che sia soltanto questo elemento di natura extramorale a determinare la nostra differenziazione nella valutazione specifica; tanto che una volta risolto il dilemma descrittivo, io convincendo lui che gli animali sono coscienti o lui convincendo me che non lo sono, la nostra contrapposizione sulla moralità o meno di quel gesto scomparirebbe, condividendo entrambi il principio generale che non si devono procurare sofferenze gratuite. Un altro esempio dello stesso genere, che viene costantemente riproposto nella letteratura analitica anglo-americana tanto da divenire un vero e proprio cliche', e' quello relativo ad un evento che già colpiva molto i pensatori dell'età moderna, e che e' reperibile in quasi tutti coloro che si sono occupati direttamente o indirettamente delle popolazioni extraeuropee emerse con la scoperta dell'America e con i viaggi successivi (da Voltaire, a Hutcheson, a Price ecc.): la soppressione dei genitori, una volta che abbiano raggiunto un'età avanzata, in voga in talune società extraeuropee. E' un esempio molto noto, ma vale la pena riproporlo perche', come il precedente, ben si adatta a mettere in luce forme di pseudo-relativismo descrittivo, fraintendimenti possibili riguardo a questo concetto; oltre ad essere, come vedremo, il modello di un'eccellente via d'uscita per i critici del relativismo, per quanti vogliono ricondurre un'apparente diversità ad una reale uniformità. L'esempio e' il seguente: se una popolazione extraeuropea non ha le nostre stesse convinzioni riguardo al destino post mortem dell'uomo, perche' non e' atea e materialista (o agnostica) o perche' non crede alla risurrezione dei corpi nelle modalità della tradizione giudaica (che e' incurante dello stato del corpo al momento della morte) o all'immortalità dell'anima di origine greca ed orientale (ne' ad una soluzione di compromesso tra le due come quella avvallata dal Cristianesimo), ma crede ad un aldilà in cui gli esseri umani si ritroveranno nelle stesse sembianze (stato di salute o di malattia) in cui erano al momento del decesso, la decisione dei figli di sopprimere i genitori prima che abbiano raggiunto la vecchiaia non può essere concepita come una prova che esistono credenze etiche basilari contrapposte. Perche' un tal fatto, pur essendo una condizione necessaria, non e' una condizione sufficiente. Infatti, proprio in virtù delle credenze escatologiche di tale popolazione, e' possibile che gli anziani vengano soppressi per dar loro la possibilità di ritrovarsi nello stato dopo la morte in perfette condizioni di salute (difficilmente conservabili in vecchiaia). E quindi ciò che comanda il loro gesto e' un principio condiviso anche dagli europei: quello di fare il meglio possibile per i propri genitori. Se fosse così, allora quello in questione non sarebbe un caso di relativismo etico-descrittivo, ma semmai sarebbe un elemento a favore di una concezione non relativistica, perche' accomunerebbe gli europei e suddetta popolazione su un principio morale generale. Lo stesso principio comanderebbe due azioni contrapposte. Per questo motivo, per valutare il relativismo etico-descrittivo e' necessario risalire deduttivamente dai giudizi etici particolari ai principi etici che li comandano ed individuare a tale livello se sussiste il conflitto.3 Si definisce invece relativismo metaetico, la tesi di natura epistemologica per cui non si dà un metodo valido per stabilire quale tra due o più sistemi morali (o principi etici basilari o teorie etiche normative) in conflitto sia quello corretto (per cui tutti i sistemi morali sono da porre sullo stesso piano dal punto di vista della validità; sono tutti ugualmente corretti o scorretti). O se un siffatto metodo si dà (versione più moderata) non riesce a risolvere tutti i conflitti, ovvero lascia la possibilità che ci siano principi o sistemi morali ugualmente validi (anche se non tutti i principi o i sistemi in conflitto sono ugualmente validi). Che si parli di correttezza o di validità invece che di verità, e' un segno di flessibilità di questa definizione, che risulta trasversale rispetto all'atteggiamento che le teorie metaetiche hanno nei confronti della nozione di verità applicata in ambito morale, e quindi rende possibile che siano relativistiche anche le teorie che negano abbia senso applicare i predicati 'vero' e 'falso' ai giudizi morali (le teorie non cognitiviste). Che si parli di principi in conflitto o in contrasto e non in contraddizione consente, allo stesso modo, di ampliare l'applicazione anche a quelle teorie che negano la sussistenza di rapporti logici tra giudizi morali. E' quindi un ulteriore segno di flessibilità. Il relativismo normativo non e' invece una tesi di natura antropologico-sociologica, ne' di natura epistemologica, ma di natura morale. Non asserisce che e' relativo ciò che e' ritenuto giusto (e/o buono) da diverse persone o nelle diverse società o in differenti epoche, ne' che e' relativa la verità o la validità dei sistemi etici o dei principi morali, ma che e' relativo proprio ciò che e' giusto (e/o ciò che e' buono). Vale a dire che ciò che e' giusto (e/o buono) per una persona o per una società non e' giusto per un'altra persona o un'altra società, nonostante che le condizioni della situazione siano analoghe sotto il profilo morale. Nel senso che lo stesso tipo di azione che e' prescrivibile ad una persona non lo e' per un'altra persona. Se e' giusto che Alice abortisca nelle condizioni X, Y e Z, non e' giusto che abortisca Claudia in condizioni analoghe sotto il profilo morale. Questa esemplificazione e' importante perche' ci consente di distinguere il relativismo normativo da una tesi simile ma pseudo-relativistica. Mi riferisco alla tesi per cui uno stesso tipo di azione, giusto in certe circostanze, e' ingiusto in altre, per cui due azioni di una medesima classe, compiute in circostanze differenti, possono essere l'una giusta e l'altra ingiusta. Ecco, una persona che sostenesse essere giusto per Alice che si trova nelle condizioni X, Y, e Z, abortire, ma sostenesse essere ingiusto fare la stessa cosa per Patrizia, che si trova nelle condizioni (, ( e (, non sarebbe un relativista normativo, se le condizioni in questione fossero tali da differenziare in maniera moralmente rilevante questa situazione dalla precedente (ad esempio se Patrizia, al contrario di Alice, non fosse rimasta incinta in seguito ad un atto di violenza sessuale).4
3. Relativisti e non tra Cinquecento e Settecento: un breve excursus storico
Lasciamo da parte il relativismo normativo, la cui plausibilità, perlomeno in questa formulazione, suscita forti dubbi (come dice Frankena 5, esso pare violare il fondamentale principio di universalizzazione per il quale casi simili vanno trattati in maniera simile, un principio che tutti sembrano accettare anche se con giustificazioni diverse - c'e' chi lo concepisce un principio logico, chi un principio morale, chi un principio di natura metafisica ) 6. Occupiamoci invece del relativismo descrittivo e di quello metaetico, direttamente coinvolti nella questione posta da Scalfari nella polemica con Maggiolini. Alla luce delle precedenti definizioni, possiamo dire che di fronte al conflitto tra pratiche morali contrapposte sono aperte quattro possibilità alternative: 1) Sostenere una congiunzione delle prime due forme di relativismo, ovvero che si danno (di fatto) principi etici basilari contrastanti e non si dà un metodo razionale per stabilire chi ha ragione e chi ha torto (qual e' il principio o il sistema vero o valido); oppure anche se il metodo si dà rimangono comunque casi di conflitto che esso non riesce a risolvere. 2) Accettare l'idea che ci siano credenze etiche ultime contrapposte, ma asserire l'esistenza di un metodo in grado di risolvere tutti i conflitti (ossia accettare il relativismo descrittivo, ma rifiutare, negare, quello metaetico). 3) Sminuire il valore del contrasto, asserendo che esso non tocca i principi etici basilari ma solo i comportamenti pratici, pur ammettendo che (nel caso che si dessero conflitti a livello di principi etici basilari) non esiste un metodo razionale per scegliere un principio (o un sistema) etico contro un altro, o se esiste non riesce a risolvere tutti i casi di conflitto etico (ovvero negare il relativismo etico-descrittivo e sottoscrivere quello metaetico). 4) Negare entrambe le forme di relativismo, cioe' rifiutare sia che ci siano credenze etiche basilari in contrasto, sia che non esista un metodo adeguato in etica per stabilire chi ha ragione e chi torto, quali principi sono validi e quali no. Proverò adesso ad 'incasellare', a puro titolo esemplificativo, alcuni dei filosofi tra '500 e '700 in queste quattro opzioni. Ovviamente, data la mancanza della distinzione esplicita tra queste forme di relativismo nel periodo in questione, l'operazione si presenta alquanto problematica e difficoltosa (non si possono che avanzare delle congetture); ma, lo ripeto, farò qualche nome solamente a titolo indicativo e senza alcuna pretesa esaustiva. La ragione di questa scelta e' duplice: in primo luogo perche' quello indicato e' il periodo successivo alla scoperta dell'America e quindi e' particolarmente adatto a mettere in luce l'atteggiamento della filosofia europea di fronte al panorama di multiforme varietà (a livello di codici morali, di culti religiosi ecc.) che i viaggi nel nuovo continente avevano prospettato; in secondo luogo perche' quello tra Cinquecento e Settecento e' il periodo che sul piano storico-filosofico conosco meglio.7 Sicuramente Montaigne e molti pensatori libertini erano relativisti, ma a quale livello lo fossero e' difficile stabilirlo. La linea che pare predominare e' quella di chi trae conseguenze nichilistiche, sia a livello metodologico che a livello ontologico, dalla grande varietà di costumi e di istituzioni riscontrata presso popoli in epoche diverse e in luoghi diversi. Ad esempio, sembra prevalente nei Saggi di Montaigne l'atteggiamento di chi non si limita a constatare (a registrare) le difformità e le contrapposizioni di usi e di costumi delle popolazioni del nuovo mondo rispetto a quelli europei, ma nega che esista un metodo imparziale per risolvere siffatti conflitti, un criterio per discriminare i principi che sono validi da quelli che non lo sono.8 La presa d'atto di Montaigne era conseguente all'atteggiamento epistemologico adottato sin allora nell'ambito dello studio del mondo umano. Un atteggiamento induttivista e connesso al criterio del consensus gentium (tutti i popoli in tutte le epoche hanno sostenuto T1 ... Tn , dunque T1 ... Tn sono veri). Se su tali basi era stato possibile fondare le leggi morali naturali, poggiando sui medesimi presupposti induttivisti adesso, con la caduta del consensus gentium, diveniva plausibile concludere che non vi sono leggi morali naturali, che la natura detta le cose più disparate e non gli stessi modelli di comportamento a tutti. Se passiamo alla seconda opzione, e' possibile individuare però un filone di pensatori che accetta il fenomeno della diversità portato alla luce dalla scoperta dell'America e dai successivi viaggi, non cerca di eliminarla o di ridurla e nonostante ciò rivendica la superiorità dei costumi europei fondandola (o avendo la pretesa di fondarla) non su basi etnocentriche, ma su basi razionali. E' il caso del giusnaturalismo moderno. Il quale, a differenza di quello antico, scinde l'idea di legge naturale dal criterio del consensus gentium e dal rozzo modello induttivistico ad esso connesso, dandole un fondamento puramente razionale. Ad esempio, Pufendorf e' pienamente convinto dell'esistenza del disaccordo etico sulle più svariate questioni e non cerca affatto di sminuirne il valore o la portata. Ma lo ritiene superabile tramite l'uso corretto della ragione. Se anche gli extraeuropei usassero correttamente la ragione approderebbero a quell'unico sistema di norme che e' vero.9 Un altro nome incasellabile in questa alternativa potrebbe essere quello di Locke. Ma sulla sua teoria della morale vi sono molti dubbi interpretativi. Di certo storicamente le sue idee in questo ambito non furono giudicate difformi da quelle di Montaigne e degli altri scettici relativisti. Ma se e' indubbia la sua posizione riguardo all'esistenza di un'effettiva varietas morum, non altrettanto certo e' l'impianto della sua filosofia morale. E dal fatto che fosse un relativista a livello antropologico non deriva che lo fosse anche a livello epistemologico-morale. Che Hutcheson e Hume siano molto vicini alla terza opzione non e' del tutto fuori luogo. Anche se per i due moralisti in questione (soprattutto per il secondo) non sembra darsi un metodo in grado di risolvere tutti i conflitti etici, e quindi una sola morale (pur rimanendo vero per loro il fatto che non tutte le opinioni etiche siano ugualmente corrette, da porsi sullo stesso piano), essi non sono disposti a dar credito al panorama di infinita varietà e contrapposizione descritto dai viaggiatori. E ribadiscono l'uniformità della natura umana: i sentimenti degli uomini sono sempre e ovunque gli stessi.10 Alla quarta opzione (fra coloro che ebbero un occhio di riguardo per le relazioni di viaggio concernenti i popoli del nuovo mondo) sembra appartenere talvolta Voltaire (dico 'talvolta' perche' le sue opinioni sull'etica variano da testo a testo). Perlomeno il Voltaire che asserisce che "la morale e' la medesima in tutti gli uomini che fanno uso della ragione", che "esiste una sola morale (...) come esiste una sola geometria";11 che critica le relazioni di viaggio sulle popolazioni americane e Locke per avervi creduto ciecamente, e che sottolinea più volte come la varietà (la difformità) di costumi sia solo superficiale e non intacchi nel profondo la natura umana, che nelle sue radici e' sempre la stessa.12 Alla quarta prospettiva appartiene sicuramente Richard Price. Di fronte alla diversità il filosofo gallese rifiuta la prima opzione. Per Price la difformità non implica conclusioni relativistiche o scettiche. Sarebbe sbagliato pensare che gli uomini "have no powers of moral perception, or that there is no fixed standard of morality, because of the diversity in men's opinions, concerning the fitness or unfitness, lawfulness or unlawfulness of particular practices".13 Ma anche la seconda non gli si attaglia perche' non sembra trovare appigli nella Review. Infatti Price non e' affatto disposto ad accettare che si diano differenziazioni a livello di credenze etiche basilari. Al contrario del giusnaturalismo seicentesco non accetta il terreno di scontro della diversità. D'altra parte e' incompatibile con l'epistemologia priceana l'idea che non vi siano strumenti razionali per compiere scelte morali (e che tutte le opinioni etiche siano da porre sullo stesso piano), invocata dalla terza strada. Non rimane che la quarta possibilità, che e' quella che congiunge l'idea (giusnaturalistico-moderna) di una metodologia della recta ratio per approdare alle verità morali (se tutti gli uomini usassero correttamente la ragione approderebbero al medesimo sistema morale) con un ridimensionamento delle difformità a livello di costumi tra società diverse e tra epoche diverse. L'autore della Review adotta una strada tipica dell'anti-relativismo settecentesco (rispetto a quello seicentesco), e tutt'oggi praticata come abbiamo visto (e come vedremo): quella di non accettare il contrasto. Il disaccordo c'e' ma a livello di pratiche concrete. Perche' a livello di principi etici generali non c'e' epoca ne' società che non condivida sempre gli stessi.14 La difformità si spiega quindi col fatto che per passare dai principi ultimi alle regole concrete sono necessarie delle premesse empirico-descrittive. E' la diversità di tali premesse, ovvero le differenze a livello di credenze descrittive, a far sì che da principi ultimi comuni si passi a regole concrete contrapposte.15 Oltre a ciò, a spiegare le difformità di valutazione morale, vi sono le difficoltà interne alla sfera etica. Anche se tutti gli uomini avessero le medesime credenze descrittive, secondo Price una parte del disaccordo permarrebbe, perche' legato alla stessa applicazione di un principio morale (ossia legato alla difficoltà di sapere cosa realizza effettivamente la conformità a quel principio). L'autoevidenza dei principi non implica una loro facile applicazione alle situazioni concrete. L'essere convinto della doverosità di fare il bene altrui lascia ancora indeterminato come realizzare tale bene, lascia nell'incertezza di sapere se un'azione lo produrrà o meno. Inoltre le difficoltà sono accentuate, secondo Price, dal fatto che per lui come per molti altri moralisti i principi ultimi (gli heads of virtue, per usare il suo linguaggio) sono più di uno, sono una pluralità (quindi non si tratta solo di risolvere le difficoltà legate all'applicazione del principio che ingiunge di produrre il massimo bene generale, ma anche quelle legate all'applicazione del principio che ci obbliga alla giustizia e così via). E sono accresciute dal fatto che i principi morali ultimi possono entrare in conflitto tra loro.16 Quel che e' interessante notare e' che sotto il profilo strettamente descrittivo la posizione di Price non e' dissimile da quella dei suoi avversari Hume ed Hutcheson. E' anzi più vicina alla loro non solo, com'e' ovvio, rispetto a quella dei libertini, che credevano ciecamente alle relazioni di viaggio e vi trovavano una conferma delle proprie congetture, celate alla massa, ma anche più simile rispetto a quella dei giusnaturalisti seicenteschi, che come i libertini accettavano la diversità (pur non traendo da essa, come costoro facevano, conclusioni scettiche). Certo la natura del consenso di tutti gli uomini e' diversa in Price rispetto a Hume e ad Hutcheson. Per Price e' l'evidenza razionale che ha fatto sì e che fa sì che tutti si accordino sui principi etici basilari. Per Hume e per Hutcheson e' invece la natura umana sotto un altro punto di vista, sotto il punto di vista sentimentale. Gli uomini sotto il profilo delle reazioni emotive sono rimasti sempre gli stessi. O, per dirla con Hutcheson, hanno sempre posseduto il senso morale. Rimane il fatto che la risposta di Price di fronte alla diversità e' (parzialmente) difforme rispetto a quella del giusnaturalismo seicentesco che era più propenso ad accettare la difformità tra società diverse e non cercava di ricondurla a principi unitari, quanto di prospettare l'uso della recta ratio come modello per risolvere la contrapposizione.
4. Si danno credenze etiche basilari in conflitto e ugualmente valide?
A questo punto, credo che emerga in maniera abbastanza chiara dal quadro delineato in che senso le affermazioni di Scalfari (e le opinioni di tanta parte del senso comune) sull'ovvietà del relativismo non risultino convincenti, o siano perlomeno superficiali. Innanzitutto Scalfari non si preoccupa minimamente di differenziare le norme concrete dai principi e quindi si limita a constatare la differenza a livello delle prime senza chiedersi se essa si dia anche a livello dei secondi. Inoltre, non distinguendo il relativismo descrittivo dal relativismo metaetico (conseguenza del non aver differenziato i tre ambiti che oggigiorno caratterizzano la riflessione etica), Scalfari sembra dare per scontato che il primo implichi il secondo. In realtà, come abbiamo visto, la semplice diversità di opinioni tra persone e società in tempi e in luoghi diversi non e' sufficiente ad avvalorare concezioni di relativismo etico (altrimenti il numero dei relativisti si accrescerebbe a dismisura). Perche' la diversità rilevante per il relativismo riguarda i principi etici basilari e non le norme concrete da essi derivate. La scontata variabilità di cui parla Scalfari concerne solo quest'ultime. Ma si può considerare vero il relativismo semplicemente perche' cambiano i comportamenti specifici, anche se i principi sono i medesimi? Sembra implausibile. E' più serio filosoficamente pensare che il relativismo e' vero se sono mutevoli i principi morali che dettano i comportamenti e non i comportamenti stessi. Inoltre, anche se, for the sake of argument, dessimo per accertato il carattere relativo di alcuni principi etici basilari, questo ancora non proverebbe l'uguale correttezza o validità delle posizioni in conflitto, che e' ciò in cui più propriamente consiste il relativismo per i filosofi morali (che vi siano principi in contrasto e' un mero relativismo antropologico). Non basta che non vi sia accordo a livello di credenze etiche basilari. E' necessario che non si dia un metodo razionale per stabilire chi ha ragione e chi ha torto (o che se si dà lasci alcuni conflitti irrisolti). Come il fatto che un popolo ritenga la terra piatta ed un altro gli attribuisca una forma approssimativamente sferica non e' sufficiente ad avvalorare il relativismo astronomico, perche' noi riteniamo che il secondo popolo abbia ragione e il primo abbia torto (e riteniamo di avere un metodo per provarlo). Quindi per dimostrare la verità di una concezione relativistica in ambito etico ci sono due passi da compiere e Scalfari non ne compie neanche uno. Si danno giudizi morali in effettivo conflitto (relativismo antropologico)? E se sì, sono ugualmente validi (relativismo metaetico)? E' vera la congiunzione tra le prime due forme di relativismo che ho distinto? Come abbiamo visto, non e' facile stabilire se si diano codici morali realmente in conflitto (ovvero conflitti a livello di principi morali e non a livello di norme concrete). Le informazioni al riguardo non possiamo che ricavarle dalle scienze umane e sociali, e in proposito i pareri sono alquanto discordi (e questo consente ai relativisti e ai loro critici di mantenere ciascuno le proprie posizioni). Lo schema già più volte esemplificato, comunque, trova molte conferme nelle accurate indagini dei sociologi e degli antropologi contemporanei. Si dà un'estrema varietà per quanto riguarda le norme concrete, ma se risaliamo ai principi che le comandano troviamo un'uniformità altrettanto grande. Si dà uniformità su tutti i principi morali? Sicuramente si danno molti tipi di comportamento su cui pare esistere un accordo universale. In ogni società, ad esempio, i genitori hanno il compito di allevare ed educare i figli e a questi ultimi a loro volta e' richiesto di essere ubbidienti e di contraccambiare le attenzioni ricevute. Il tabù dell'incesto ed altri tipi di regolamentazione sessuale sono altrettanto universali. Così come il divieto di mentire in talune circostanze, la disapprovazione per lo stupro, la consapevolezza che gli interessi del singolo individuo sono subordinati a quelli della comunità ecc.17 Ci sono però anche alcuni tipi di comportamento su cui lo schema delineato non dà le risposte aspettate. Ad esempio, proprio riguardo al maltrattamento degli animali, non sembra che molte popolazioni extraeuropee cosiddette 'primitive'(ad esempio la tribù indiana Hopi) abbiano credenze diverse dalle nostre riguardo alla capacità degli animali di provare piacere e dolore. Pur essendo consapevoli del fatto che essi sono soggetti di esperienza (provano sensazioni di dolore nel caso in cui vengano percossi o uccisi in maniera violenta), non si pongono scrupoli ad infliggere loro sofferenze gratuite.18 Ma non c'e' bisogno di far riferimento alle tribù extraeuropee per trovare prove della sussistenza di genuini conflitti etici riguardo all'atteggiamento da tenere nei confronti degli animali. E' sufficiente rimanere all'interno della nostra comunità e constatare i diversi atteggiamenti sulla questione dei vegetariani o delle associazioni animaliste da una parte e dei cacciatori dall'altra. Non si può legittimamente pensare che questi ultimi, alla maniera dei cartesiani del Seicento, siano del tutto all'oscuro sulla capacità degli animali di provare piacere e dolore. Anch'essi sono consapevoli che perlomeno alcune specie animali hanno stati psicologici. Il relativismo descrittivo dunque e' vero. Magari in misura minimale, ma e' vero (ci sono solo alcune credenze etiche basilari in conflitto; in molti casi funziona lo schema 'difformità a livello di norme concrete, uniformità a livello di principi'). Si danno indubbi casi di conflitti realmente etici. Visto che si danno (seppur in misura notevolmente inferiore a quanto si e' soliti pensare) principi o codici morali in reale conflitto, sono essi ugualmente validi? Si dà un metodo per stabilire chi ha ragione e chi ha torto? E se sì, funziona in tutti i casi? Risolve tutte le controversie morali? Qui si entra nella difficile disputa metaetica tra riduzionisti, intuizionisti e non cognitivisti. Una disputa che ci porterebbe molto (troppo) lontano. Per ragioni di spazio, me la caverò prendendo in esame le proposte di due filosofi morali americani (già richiamati più volte nelle pagine precedenti) che adottano un criterio per la validità dei principi morali abbastanza simile, ma che poi da esso traggono conclusioni opposte riguardo al tema del relativismo: R. B. Brandt e W. K. Frankena.19 Entrambi, pur avversando o non appoggiando del tutto la tesi per cui i giudizi morali sono riducibili senza alcuna perdita di significato a giudizi empirici, non condividono le posizioni del non cognitivismo più radicale (ben esemplificato dagli emotivisti come Ayer, per il quale la nozione di validità e' bandita dall'etica 20). Ritengono che si dia un metodo di giustificazione in ambito morale, con il quale discriminare le credenze corrette da quelle scorrette. Esso consta del soddisfacimento di una serie di clausole. Un principio morale e' valido se soddisfa tutte le clausole del metodo. Affinche' lo possiamo giudicare giustificato, un principio deve essere scelto (approvato) assumendo il punto di vista morale, in condizioni di calma, libertà, lucidità mentale, di completa informazione e chiarezza concettuale su tutti i fatti rilevanti per la questione in gioco, imparzialità ecc. Ebbene, per Brandt, una volta soddisfatte tutte le condizioni, e' ancora possibile che sussista il disaccordo etico tra due persone; per Frankena no. Ovvero, per Brandt e' possibile trovare due persone che sono informate su tutti gli aspetti di una particolare questione morale, sono lucide, calme, riflessive, imparziali (vale a dire disposte ad universalizzare le proprie posizioni) e nonostante ciò assumono posizioni opposte riguardo al problema morale in questione. Al contrario, per Frankena non si dà il caso che due persone siano nelle suddette condizioni e possano trovarsi in disaccordo: devono necessariamente convergere, altrimenti ciò significa che una delle due non soddisfa a pieno le clausole del metodo di giustificazione (o non e' sufficientemente informata, o non e' abbastanza lucida e riflessiva ecc.). L'uno (Brandt) dunque e' disposto ad abbracciare una forma di relativismo, seppur moderata (perche' accetta che ci sia un metodo razionale per stabilire chi ha ragione e chi ha torto, anche se non dirime tutti i casi controversi), l'altro (Frankena) no.21 Anche Brandt, però, riconosce che vi e' una serie di questioni fondamentali per la stessa sussistenza di una convivenza civile su cui non possono darsi principi contrastanti ugualmente validi:
some values, or some institutions with their supporting values, are so inevitable, given human nature and the human situation in society as they are, that we can hardly anticipate serious questioning of them by anybody -much less any conflitting "qualified attitudes", that is, conflicting attitudes that are informed (and so on). Thus, ethical relativism may be true, in the sense that there are some cases of conflicting ethical judgement that are equally valid; but it would be a mistake to take it as a truth with pervasive scope. Relativism as an emphasis is misleading, because it draws our attention away from the central identities, from widespead agreement on the items we care most about. Furthermore, the actual agreement on the central things suggests the possibility that, with better understanding of the facts, the scope of agreement would be much wider. 22
1 Mi riferisco all'articolo intitolato Caro vescovo, io parlo dal mondo dei non credenti, in risposta all'articolo di Alessandro Maggiolini dal titolo Caro direttore, se Dio non c'e' tutto e' permesso, comparsi entrambi sulle pagine culturali de "La Repubblica" di Mercoledì 24 gennaio 1996.
2 Cfr. F. Allegri, L'etica analitica e il concetto di dovere, "Kyke'ion", n. 1, 1999, pp. 113-115. Come già sottolineavo in quel contesto, e' sufficiente un'esemplificazione per delineare la differenza fra i tre ambiti di indagine che caratterizzano la sfera etica: un conto e' dire che gli Spartani ritenevano moralmente lecito l'infanticidio (etica descrittiva), un altro che il giudizio 'l'infanticidio e' moralmente lecito' e' un giudizio empirico (metaetica) e un altro ancora che l'infanticidio e' moralmente lecito (etica normativa).
3 Ovviamente, questo nel caso in cui si adotti una prospettiva 'normativistica', ovvero si attribuisca centralità alle norme nel decretare ciò che e' giusto ed ingiusto e nell'elaborare una teoria dell'obbligo morale. Se invece, come ad esempio i cosiddetti deontologi dell'atto, si ritiene di poter fare a meno di norme (di principi) in ambito etico, o si attribuisce loro un ruolo secondario, allora non sarà necessario alcun regresso deduttivo: con i giudizi etici particolari avremo già toccato il fondo della sfera etica.
4 Ho tratto indicazioni per le precedenti definizioni di relativismo in ambito morale da una serie di testi: W. K. Frankena, Etica. Un'introduzione alla filosofia morale, a cura di Maurizio Mori, Milano, Edizioni di Comunità, 1981, pp. 207-210; R. B. Brandt, "Ethical Relativism" (capitolo undicesimo di Ethical Theory. The problems of Normative and Critical Ethics, Englewood Cliff, N.J., Prentice-Hall, 1959, pp. 271-294); Gilbert Harman, What is Moral Relativism? in A. Goldmam e J. Kim (a cura di), Values and Morals: Essays in Honor of William Frankena, Charles Stevenson and Richard Brandt, Dordrecht, Reidel, 1978, pp. 143-161; Geoffrey Harrison, Relativism and Tolerance, "Ethics", 86, 1976, pp. 122-135; M. Vacatello, Il relativismo metaetico da Moore a Brandt, "Iride. Filosofia e discussione pubblica", n. 7, 1991, pp. 51-67. Sono solo alcuni tra quelli che si potrebbero citare.
5 Cfr. W. K. Frankena, Etica, cit., p. 209.
6 Al di là delle apparenze (e di quanto sembra sostenere lo stesso Frankena, cfr. ivi, p. 80), anche gli esistenzialisti e i cosiddetti deontologi dell'atto lo accettano: quello che semmai negano e' la condizione empirica per la sua applicazione, ovvero il fatto che si diano casi simili (perche', a loro avviso, ogni situazione e' unica e irripetibile).
7 Sul problema del relativismo tra Cinque e Settecento e più in generale sull'influenza delle nuove scoperte geografiche nel dibattito filosofico europeo, rimane tuttora fondamentale l'eccellente studio di Sergio Landucci, I filosofi e i selvaggi: 1580-1780, Bari, Laterza, 1972, in particolar modo pp. 23-85 (il primo capitolo "L'esperienza della diversità"), da cui ho tratto importanti indicazioni per la messa a punto di questo paragrafo.
8 Cfr., ad esempio, il celebre passo tratto da "Dei cannibali", in Michel De Montaigne, Saggi, cap. XXXI, a cura di Fausta Garavini, Milano, Adelphi, 1966, 2 voll., vol. I, pp. 268-285, p. 272: "... ognuno chiama barbarie quello che non e' nei suoi usi; sembra infatti che noi non abbiamo altro punto di riferimento per la verità e la ragione che l'esempio e l'idea delle opinioni e degli usi del paese in cui siamo".
9 Cfr. Sergio Landucci, I filosofi e i selvaggi: 1580-1780, cit., p. 23 e seguenti, p. 52 e seguenti.
10 A riprova di ciò, si vedano ad esempio i seguenti passi di Hume: "Si riconosce universalmente che c'e' grande uniformità fra le azioni degli uomini, in tutte le nazioni e in tutte le età, e che la natura umana resta sempre la stessa nei suoi principi e nelle sue operazioni. (...) Vorreste conoscere i sentimenti, le inclinazioni e il modo di vivere dei greci e dei romani? Studiate bene il temperamento e le azioni dei francesi e degli inglesi; non potete ingannarvi molto nel trasferire ai primi la maggior parte delle osservazioni che avete fatto riguardo ai secondi. L'umanità e' tanto la stessa in tutti i tempi ed in tutti i luoghi, che la storia non ci informa di nulla di nuovo o di insolito a questo proposito" (D. Hume, Ricerca sull'intelletto umano, Opere, Bari, Laterza, 1971, 2 voll., vol. II, pp. 1-175, pp. 89-90); "... i principi in base ai quali gli uomini ragionano in campo morale sono sempre gli stessi, pur se le conclusioni che ne derivano sono spesso diverse" (D. Hume, Un dialogo, Opere, cit., vol. II, pp. 343-362, p. 355).
11 Voltaire, Dizionario filosofico (voce 'Morale'), in Voltaire, Scritti filosofici, a cura di Paolo Serini, Bari, Laterza, 1972, 2 voll., vol. II, pp. 3-534, p. 399 e p. 398. Il padre dell'Illuminismo si esprime in termini analoghi anche nella voce 'Giusto (del) e dell'ingiusto', ivi, pp. 294-295. Un modo di esprimersi del tutto antitetico a quello di Scalfari (e del tutto in sintonia con quello di Hume).
12 Cfr. Voltaire, Il filosofo ignorante, in Voltaire, Scritti filosofici, cit., vol. I, pp. 548-553. Per il contesto generale, si veda ancora Sergio Landucci, I filosofi e i selvaggi: 1580- 1780, cit., in particolar modo pp. 62-72.
13 R. Price, A Review of the Principal Questions in Morals, a cura di D. D. Raphael, Oxford, Clarendon Press, 19742, p. 172.
14 "The general principles all men at all times have agreed in. It cannot be shew that there have ever been any human beings who have had no ideas of property and justice, of the rectitude of veracity, gratitude, benevolence, prudence, and religious worship. All the difference has been about particular usages and practices, of which it is impossible but different person must have different ideas, according to the various opinions they entertain of their relation to the universally acknowledged moral principles, or of their ends, connexions, and tendencies" (ivi, pp. 170-171).
15 "... the pratical errors of men have arisen plainly from their speculative errors; from their mistaking facts, or not seeing the whole of a case; whence it cannot but often happen, that they will think those practices right, which, if they had juster opinions of facts and cases, they would unavoidably condemn. The rules of judging are universally the same. Those who approve, and those who disapprove, go upon the same principles. The disagreement is produced by different application of them. The error lies in imagining that to fall under a particular species of virtue, which does not"(ivi, pp. 171-172).
16 Su quest'ultimo punto cfr. F. Allegri, Deontologismo e assiologismo. La teoria dell'obbligo morale nella Review di Richard Price, "Annali del dipartimento di filosofia dell'Università di Firenze", nuova serie, 1998/99 (in corso di stampa).
17 Cfr. C. Kluckhohn, Ethical Relativity: Sic et Non, "Journal of Philosophy", LII, 1955, pp. 663-677.
18 Cfr. R. B. Brandt, Ethical Theory, cit., pp. 102-103.
19 I testi a cui faccio riferimento sono: R. B. Brandt, Ethical Theory, cit., nella fattispecie il decimo capitolo "The Justification of Ethical Beliefs", pp. 241-270 (specialmente pp. 249-251); W. K. Frankena, Etica, cit., in particolar modo pp. 210-214.
20 Cfr. A. J. Ayer, Linguaggio, verità e logica, a cura di G. De Toni, Milano, Feltrinelli, 1961, pp. 128-147, in particolar modo pp. 139-141.
21 La differenza principale (o una delle differenze principali) nella teoria della giustificazione dei due filosofi in questione, che ha un peso determinante nelle opposte implicazioni che da essa vengono tratte, consiste nel fatto che, mentre per Frankena un principio morale e' giustificato (e' valido, e' corretto, e' accettabile) se e' approvato da tutti, una volta che abbiano assunto il punto di vista morale, siano informati, disposti ad universalizzare ecc., per Brandt e' sufficiente che sia approvato da un qualsiasi singolo individuo che applichi correttamente le clausole del metodo (cfr. W. K. Frankena, Etica, cit., p. 213, e R. B. Brandt, Ethical Theory, cit., pp. 279-280).
22 R. B. Brandt, Ethical Theory, cit., pp. 287-288.