
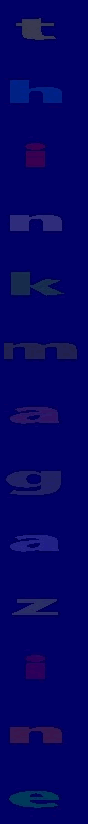
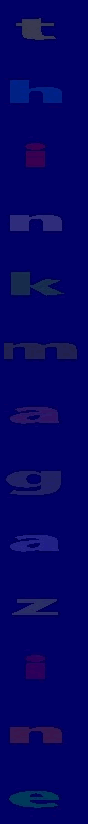
La miseria della bioetica italiana
Il titolo di questo contributo potra' sembrare ad alcuni eccessivamente polemico e offensivo, ad altri ingiustificato e ingeneroso nei confronti di una disciplina che negli ultimi venti anni ha conosciuto, anche in Italia, una certa fioritura e verso la quale si e' registrato un progressivo aumento di interesse. Se oggi si traccia un breve e sommario bilancio della bioetica italiana, si puo' constatare come essa goda di buona salute sotto diversi profili. Non si puo' certo affermare che le pubblicazioni di bioetica siano scarse, ne' per quanto riguarda le monografie e le antologie, ne' per quanto riguarda le riviste specialistiche. Abbondano le traduzioni di volumi stranieri (anche se con qualche fisiologica lacuna) e la schiera dei "bioeticisti" italiani e' ben nutrita, non solo dal punto di vista quantitativo ma anche dal punto di vista qualitativo. Intellettuali come Bartolommei, Battaglia, Berlinguer G., Cattorini, Cavalieri, Chiavacci, Defanti, Ferrando, Flamigni, Lecaldano, Lombardi Vallauri, Maffettone, Mori, Neri, Pessina, Reuchlin, Santosuosso, Scarpelli, Sgreccia, Spinsanti, Vegetti Finzi hanno elaborato interessanti e serie trattazioni dei temi principali della bioetica, partendo da prospettive differenti, ricorrendo ad approcci che godono di una sostanziale varieta' e muovendosi in diversi settori disciplinari. Si puo' dire che in generale lo standard scientifico non ha niente da invidiare alla letteratura che fino dagli anni '70 si e' occupata di questioni bioetiche, cioe' la letteratura di area anglosassone.
La bioetica ha anche avuto una certa diffusione nel mondo accademico italiano, tanto che si puo' oggi affermare che quasi ogni Ateneo possiede il suo insegnamento di bioetica. Non mancano inoltre i dibattiti tra gli studiosi per introdurre l'insegnamento della bioetica nei quadri didattici dell'istruzione italiana, in modo da creare per questa disciplina uno spazio anche nelle scuole medie superiori. Infine, il numero dei comitati etici presenti in ospedali, aziende sanitarie e istituzioni si sta moltiplicando e in alcuni casi essi risultano effettivamente funzionali nell'orientamento delle decisioni cliniche piu' spinose, senza contare i numerosi interventi del Comitato Nazionale di Bioetica, in attesa di nuova nomina e attualmente presieduto da G. Berlinguer.
Da questa breve e incompleta rassegna, si potrebbe dedurre che nel caso della bioetica italiana sia realmente inappropriato parlare di "miseria": dal punto di vista scientifico, editoriale, accademico e istituzionale sembra che non ci sia motivo per accusare la bioetica di casa nostra di carenze o insufficienze. Tuttavia, specularmente a questa situazione di "abbondanza", si registra a mio giudizio un basso profilo relativamente alla solidita' della disciplina nell'ambito della politica e della societa' civile. Come e' noto a chi si occupa di etica medica, non sono certo mancati nella storia italiana contemporanea momenti in cui la bioetica ha abbracciato un'ampia risonanza nell'opinione pubblica ed e' entrata nelle aule parlamentari e nelle sedi istituzionali. Sono indicativi su di un versante i grandi movimenti e l'alta coscienza del problema a livello di societa' civile che hanno accompagnato le leggi sull'aborto e sul divorzio e sull'altro le varie proposte di legge in materia di fecondazione assistita e disposizioni anticipate che si sono avute negli ultimi anni. Non solo ma si puo' registrare anche il lavoro autorevole di alcune commissioni, nominate da alte cariche istituzionali, come il dossier della Commissione Santosuosso sulla procreazione assistita (1984) o quello della Commissione Dulbecco (2000), sull'impiego delle cellule staminali a fini terapeutici. Nonostante questi successi, si ha sempre l'impressione che vi sia una scarsa "introiezione" dei problemi bioetici al livello della coscienza pubblica, che si ripercuote sulla "serieta'" con cui questi problemi vengono effettivamente trattati in sede politica.
Rimangono indicativi alcuni recenti episodi su cui vale la pena di soffermarsi. Ci si potrebbe chiedere cosa sia rimasto a livello della "coscienza pubblica" di tutti quei casi in cui e' stato risollevato il problema "eutanasia" (molto spesso senza curarsi troppo delle distinzioni terminologiche e della chiarezza concettuale che sono necessari per affrontare un tema vasto e sfaccettato come questo) e in cui e' stata paventata la possibilita' di una regolamentazione per legge della dolce morte. Il caso Englaro per esempio appassiono' e occupo' per qualche tempo l'attenzione dei mezzi mediatici, sollecitando (cosi' sembra) anche la costituzione della Commissione Oleari, istituita dal Ministro Veronesi nel 2000 con il compito di stabilire se fosse possibile sospendere l'alimentazione e l'idratazione artificiali nei pazienti in stato vegetativo permanente. Occorrerebbe capire in quale misura il documento della Commissione Oleari ha inciso sulle coscienze individuali che non appartengono al pur vasto circuito degli studiosi di bioetica e in quale misura ha contribuito ad un reale, esteso, incisivo dibattito pubblico. Dubitiamo che vi siano stati effetti positivi su larga scala, anche alla luce delle generali dichiarazioni che i nostri politici avevano rilasciato in merito alla condizione clinica di coma a cui era costretto l'esponente radicale Emilio Vesce (morto poi il 12/05/2001). Di fronte al rilancio della proposta di legittimare la sospensione delle cure nei casi dei pazienti in coma, di cui si sia accertato l'impossibilita' di un recupero della coscienza, i politici italiani si schierarono per lo piu' su due fronti: o ribadendo il principio di sacralita' della vita umana, per cui ogni uccisione derivante da atto o omissione e' vietata moralmente e, consequenter, giuridicamente, oppure relegando il problema eutanasia ad una scelta di coscienza individuale. La prima risposta e' ben comprensibile, sebbene opinabile, mentre la seconda costituisce una vera e propria elusione del problema, se non una fonte di fraintendimenti pericolosi. Cosa significa esattamente? Che la sfera pubblica dello Stato non puo' o non deve invadere la sfera privata del cittadino, anche riguardo alla propria morte? O forse che l'eutanasia costituisce un problema troppo scottante, troppo "politicamente" compromissorio perche' se ne solleciti un reale dibattito pubblico e se ne parli quindi seriamente nelle aule parlamentari? Propendiamo per questa versione, poiche' la prima costituirebbe gia' un'impegnativa e sostanziale presa di posizione in merito al problema.
Tuttavia dovrebbe essere evidente come sia fallimentare tentare di legiferare "dall'alto" su questioni bioetiche, laddove non esista una corretta e informata percezione del problema "dal basso". Il pasticcio della recente disciplina sulla fecondazione assistita e' esemplare, in quanto si e' partiti dalla proposta di legge "Bolognesi", gia' di per se' insoddisfacente e lacunosa, per giungere ad un'ipotesi legislativa anche peggiore di quella iniziale. Tutto questo, senza tenere conto del fatto se esistesse o meno una consapevolezza dei cittadini in merito alle opzioni scientifiche, etiche e giuridiche che il problema mette in gioco. Giungere in Parlamento con un background di questo tipo non e' sicuramente impresa facile ed esente da pericoli, poiche' richiede un faticoso e attento lavoro di divulgazione e spiegazione, ma e' sicuramente un atto necessario affinche' la condizione "pubblica" della bioetica italiana cambi radicalmente. Occorrerebbe forse ripensare anche il ruolo del CNB e fare in modo che i suoi pareri autorevoli non rimangano tra la stretta cerchia dei "tecnici" ma vengano largamente diffusi e discussi da tutta la societa' civile (un parere famoso e controverso del CNB, come quello sull'embrione, avrebbe sicuramente tratto giovamento da una discussione a piu' ampio raggio rispetto a quella di cui e' stato oggetto) e fare in modo che il Ministero della Sanita', oltre ad autorizzare o censurare pratiche, si occupi anche di fornire una corretta e pluralistica educazione bioetica alla cittadinanza, perche' altrimenti non si capisce come si possano qualificare le questioni bioetiche come problemi che toccano e coinvolgono in prima persona ognuno di noi. Per fare un esempio forse piu' noto, la legge sui trapianti d'organo, accolta con giusta soddisfazione, prescrive all'art. 2 che il Ministero della Sanita', d'intesa con i Ministeri della Pubblica Istruzione e dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, provveda a organizzare iniziative di informazione in merito alla normativa vigente e alle possibilita' scientifico-terapeutiche che i trapianti d'organo consentono. Non ci sembra che un'efficace campagna di questo tipo sia stata effettuata dalle istituzioni pubbliche italiane, ne' che altri soggetti sociali abbiano provveduto a informare i cittadini sulle possibili opzioni etiche che vi sono coinvolte: e' del resto auspicabile, come ha sottolineato Sebastiano Maffettone, che il silenzio-assenso previsto dalla legge sia una formula di carattere prudenziale, escogitata al momento per sopperire alle richieste di organi da trapianto, e che venga in futuro sostituita da un atteggiamento dei cittadini incline alla donazione spontanea ed esplicita dei propri organi. Questo risultato e' certamente irraggiungibile se non si palesano in modo chiaro le implicazioni morali della donazione d'organi e non si procede ad iniziative di sensibilizzazione dell'opinione pubblica. I dubbi si acutizzano quando ci si accorge dei modi e dei tempi in cui il Parlamento italiano ha ratificato la (discutibile) Convenzione europea sui diritti dell'uomo e la biomedicina (conosciuta anche come Convenzione di Oviedo): il documento e' stato frettolosamente approvato dalla Camera dei Deputati il 14 marzo 2001 (cioe' quando il Parlamento era ormai sciolto per le imminenti elezioni), senza un dibattito che possa definirsi tale e senza che fosse dato all'evento la giusta e dovuta visibilita'.
Quale spiegazione si puo' dare a questa situazione di stallo? Credo che lo stato di minorita' della bioetica in senso pubblico, rispetto alla bioetica in senso scientifico, sia dettato dal prevalere di posizioni conservatrici e scarsamente aperte verso il nuovo. Nell'ambito delle pubblicazioni tecniche si e' raggiunta effettivamente una condizione di pluralismo e anche autori di ispirazione religiosa hanno proposto argomenti e modelli di giustificazione di carattere laico nel difendere le loro posizioni, mentre esiste ancora, a livello politico, una sorta di sudditanza nei confronti del conservatorismo e della necessita' di imporre a tutti i cittadini un unico punto di vista etico, senza tenere conto della diversita' delle fedi e delle ideologie morali che oggi vengono professate. Questo atteggiamento traspare benissimo dall'iter della recente proposta di legge sulla fecondazione assistita, a cui abbiamo gia' accennato, nella quale si e' cercato di veicolare giuridicamente alcune tesi etiche proprie della cultura cattolica, come se dovessero essere valide per tutti i cittadini. Analogamente, e' sicuramente interpretabile secondo questo schema la decisione di Alfonso Pecoraro Scanio, allora Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, di ostacolare la ricerca scientifica sugli O.G.M., ricorrendo ad un'applicazione "oltranzista" del principio di precauzione, usato non come regola politico-procedurale in situazioni d'incertezza ma come divieto morale nei confronti delle nuove biotecnologie, che recide la possibilita' di informare e discutere pubblicamente sulle implicazioni etiche e scientifiche di una simile tipologia di ricerca. Il caso del principio di precauzione esemplifica del resto un atteggiamento generale, secondo cui ad un'etica del si', per cui vige solo l'imperativo tecnologico ("si deve fare tutto cio' che si puo' fare"), e' contrapponibile solo un'etica del no, che chiude ogni porta a cio' che e' "nuovo" in tutela di cio' che e' "vecchio" e quindi intrinsecamente "buono" (a maggior ragione se il "vecchio" e' anche "naturale"). Tendenze etiche e giuridiche di questo tipo costituiscono sicuramente un motivo per cui un largo dibattito in bioetica viene, in primis, bloccato (o comunque non promosso) "dall'alto". L'uscita della bioetica italiana dallo stato di "miseria" che si e' cercato di descrivere puo' venire conseguita soltanto grazie all'azione congiunta delle istituzioni politiche e dei centri di studio e di ricerca, che fino ad oggi sono riusciti a svolgere un lavoro preziosissimo riguardo alla promozione dello studio della disciplina. Senza questo impegno comune sembra arduo che la conoscenza bio-medica, che si fa sempre piu' complessa e percio' sempre piu' eticamente delicata, entri realmente nella "coscienza di tutti noi": in qualita' di cittadini dobbiamo protestare solennemente contro questa condizione, perche' non dobbiamo mai dimenticarci che, nel momento in cui aumentano le nostre capacita' di manipolare, allungare, migliorare la vita umana e non, aumentano anche le nostre responsabilita' verso le scelte che possiamo compiere.
Matteo Galletti