
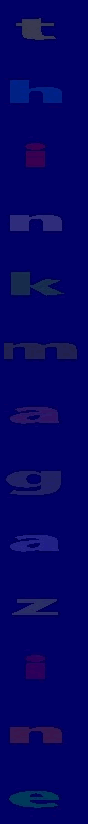
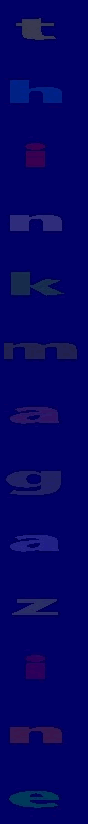
A PIG IN A CAGE ON ANTIBIOTICS
"Salta fuori dal letto cosi' presto da sentire la sveglia! Potresti trovare utile passare 5 minuti ogni mattina dicendo a te stesso: 'Ogni giorno, in qualunque modo, guadagnero' sempre meglio!' Probabilmente e' una buona idea iniziare un nuovo giorno con il giusto atteggiamento mentale."
Nel retrocopertina del libretto che accompagna Ok computer (1997), terzo album della rockband Radiohead troviamo questo invito: coglierne il senso significhera' chiedersi perche' l'invito (a proposito: perche' un invito?) venga formulato proprio in questo modo: perche' proporre un'abitudine? Perche' sottolinearne l'utilita'?
Per rispondere e' necessario chiedersi allora e innanzitutto a chi venga rivolto: la risposta si avra' scorrendo le altre pagine del libretto, soffermandosi sui testi delle canzoni. Probabilmente bastera' la settima, Fitter happier, a fornirci l'identikit dell'ideale destinatario.
Solamente un'abitudine (atto che non implica riflessione) puo' sperare di essere accolta da un uomo che deve o, peggio, vuole essere fitter, piu' adatto, alla societa': essa si rivela utile (relazione dettata, appunto, da interesse) [a] in se', in quanto estranea al dubbio (il grande assente nel nostro identikit) e [b] perche' in questo caso rivela il segreto (Soldi ! Soldi !), per ottenere questa adeguazione, per essere happier, piu' felice (no contestazioni!) ,e healthier, piu' sano, cosi' da risultare anche more productive... Che e' come dire: piu' funzionale al sistema.
I Radiohead hanno un'idea ben precisa di chi raccogliera' il loro invito: qualcuno che non vuole alarms ne' surprises ne' paranoia, specialmente a letto, prima di addormentarsi... A PIG IN A CAGE ON ANTIBIOTICS che, si augurano, venga soffocato dalle sue stesse regole e dalla sua saggezza.
Per inciso: si invita per mantenere viva la convinzione (irrinunciabile, oggi la convinzione intendo) di star scegliendo, e dunque di essere liberi. Ma forse dovremmo almeno a margine domandarci: posto che la liberta' si presenta come possibilita' e coscienza (convinzione?) di scegliere, le nostre scelte si equivalgono, o no? E se no: non potrebbe, la liberta' (come voleva Kant), essere possibilita' di scegliere se adeguarsi o meno ad una necessita'? Magari una necessita' che ci vuole, paradossalmente, maiali in gabbia sotto antibiotici?
Quella a cui siamo davanti e' una provocazione, un'affermazione (seria) volutamente esagerata allo scopo di suscitare una reazione; pro-vocare e', etimologicamente, una chiamata a farsi avanti; riconoscere una provocazione come tale significa, di conseguenza, pronunciarsi. E qui un altro problema: la nostra risposta [a] nascera' a seguito della provocazione, o [b] era gia' in noi ed e' stata semplicemente risvegliata, lasciata fuoriuscire? Che sia questo il senso del farsi avanti ?
Ovvero: l'essenza della conoscenza e' nel costruire soluzioni ai nostri problemi,oppure e' nel riconoscere una verita' che gia' da sempre e' in noi? La pretesa non e' di trovare risposte almeno non nell'immediato; la speranza, piuttosto, e' di imparare a porsi delle domande, anche perche' si e' gia' intuito che la sfera delle possibili risposte e' delimitata dal modo in cui la domanda viene posta. Senza dimenticare l'irriducibile diversita' degli interlocutori: ci potrebbe benissimo essere chi (e ce ne sono) non penserebbe affatto ad una provocazione, e non avrebbe nulla da rispondere.
Dunque: accettata l'ipotesi che siamo davanti ad una provocazione, dovremo (schematicamente):
[a] lasciarci provocare;
[b] rispondere alla provocazione interrogandoci sulla sua serieta';
[c] fare un passo indietro per scoprire in base a quali pregiudizi e' orientato il nostro domandare.
Per capire fino a che punto l'affermazione dei Radiohead e' seria e quando diventa una provocazione, si ragionera' per assurdo: la si assumera', almeno come ipotesi di lavoro, per vera.
Dunque: siamo dei MAIALI, IN UNA GABBIA, SOTTO ANTIBIOTICI.
Analizziamo da vicino: pig, maiale. Ritengo si voglia qui significare la perdita dell'essenza stessa dell'uomo: nel momento in cui l'uomo perde la propria umanita', puo' benissimo essere equiparato ad un animale. Anche un maiale, certo.
Domandiamoci:
[a] in cosa consiste l'umanita' dell'uomo?
[b] quando, come e perche' e' stata persa?
Cage, gabbia.
Una gabbia, ovvero delle sbarre: limiti che impediscono il nostro movimento; volendo: condizionamenti. Possiamo chiederci:
[a] in cosa consistono questi condizionamenti?
[b] li vediamo ? Vediamo le nostre sbarre? O forse no e per questo siamo convinti di essere liberi?
La mia prima, intuitiva sensazione, e' che finche' siamo dei maiali possiamo, tuttalpiu', percepire la costrizione: una sensazione - dicevo - intuitiva, animale nel senso puro del termine; una sensazione che potremmo percepire anche essendo dei maiali. Fare un passo in piu', dire che abbiamo coscienza di essere in una gabbia, significherebbe recuperare in buona parte la nostra umanita': basterebbe vedere le nostre sbarre; basterebbe. Realizzarla, la nostra umanita', potrebbe significare esser fuori dalla gabbia; o forse, semplicemente, imparare a muoverci dentro di essa. Ma andiamo con ordine.
Dicevamo: com'e' possibile vedere le sbarre ?
Possiamo ipotizzare che un passo importante, forse proprio il primo passo, sia di non prendere piu' antibiotics. Gli antibiotici, come si sa, sono altamente specifici: ognuno corrisponde ad un diverso disturbo; cio' che tutti hanno incomune e' la sensazione di stordimento e ottundimento mentale che producono nel paziente. Smettere di prendere gli antibiotici significhera' percio' [a] tornare lucidi, risvegliarsi da uno stato di torpore; significhera', inoltre, [b] sopportare dei dolori i singoli dolori specifici a cui quegli antibiotici erano diretti.
Non e' ancora possibile definire cosa sia l'umanita' dell'uomo, ma si puo' affermare che costitutiva di essa sia il dolore; anzi: la coscienza di esso, se e' vero che nel momento in cui ci viene restituita siamo un po' meno pig e un po' piu' uomo. Lo scarto decisivo, mi viene allora da pensare, avviene nel momento in cui ci chiediamo noi, e solo noi uomini siam capaci di farlo perche'? Perche' soffrire? Domande, non risposte si e' detto. Credo comunque che se ne abbia a sufficienza per modificare l'affermazione iniziale: ora siamo, semplicemente,uomini il concetto resta sempre da completare in gabbia. Un passo in avanti: non abbiamo piu' la coda (!), ma ancora non basta: ancora non le vediamo, le nostre sbarre; pero' vediamo qualcos'altro: qualcosa che forse c'era anche prima, ma che da maiali non sapevamo riconoscere: nella prima pagina del libretto dei testi dei Radiohead, proprio sotto l'invito da cui siamo partiti, c'e' il disegno di un uomo che indica una parete con la scritta Exit, ma non ci sono porte, solo una stretta fessura da cui si intravede del fuoco; non riusciamo a muoverci nelle altre direzioni (perche' le sbarre non si vedono, ma ci sono !), cosi' quella sembra davvero l'unica via d'uscita.
Non e' molto incoraggiante: probabilmente abbiamo bisogno di una guida. La mia guida, la stessa che ora propongo, e' Zenone, il protagonista de L'opera al nero di Marguerite Yourcenar. Zenone e' medico, filosofo e alchimista, e viaggia attraverso l'Europa ed il Vicino Oriente del sedicesimo secolo. E' un tipo un po' scorbutico, cosi' l'unico modo di seguirlo e' stare alle sue spalle, due passi indietro, lasciando che le sue esperienze e riflessioni siano il basso continuo che dettera' il ritmo della ricerca, sua come nostra, dell'uomo che ancora non siamo. E di quello che gia' siamo senza sospettare di esserlo.
ZENONE
Si e' detto: Zenone come guida alla scoperta dell'uomo [a] che ancora non siamo e di quello che [b] gia' siamo senza sospettare di esserlo.Queste due caratterizzazioni corrispondono, rispettivamente, alla prima ed alla seconda parte del romanzo: La vita errante e La vita immobile. Entrambe sono riassunte, programmaticamente, nella chiusa del primo capitolo.
[Zenone] "Un altro mi attende altrove. Io vado da lui."
E si rimise in cammino.
"Chi?" chiese Enrico-Massimiliano stupefatto. [...]
Zenone si volse: "Hic Zeno," disse. "Me stesso."
Il viaggio di Zenone e' un viaggio che avra' termine quando avra' incontrato se' stesso:ma dove cercare? La vita errante e' titolo significativo: e' fuori da se' che bisogna cercare; nel mondo, nei volti delle persone piu' che fra le parole dei libri. E Zenone e' questo che fara'. Ma non sara' sufficiente. Nell'ultimo capitolo di questa prima parte, si guarda in uno specchio, ma il vetro e' rotto, e non puo' riconoscersi. Riflette venti volti di Zenone, tutti uguali e tutti diversi. Lo specchio rotto.
"Un oggetto riportato dall'Italia pendeva al muro della stretta anticamera. Era uno specchio fiorentino su cornice di tartaruga, formato d'una ventina di specchietti convessi simili alle celle esagonali delle arnie, ognuno contenuto a sua volta nella sua stretta cornice che era stata un tempo la lorica d'una bestia viva. Al chiarore grigio d'un'alba parigina Zenone vi si miro'. Vi scorse venti facce compresse e rimpicciolite dalle leggi dell'ottica, venti immagini d'un uomo in copricapo di pelliccia, dalla carnagione smunta e giallastra, dagli occhi lustri che erano essi stessi specchi.Quest'uomo in fuga, rinchiuso in un mondo tutto a parte separato dai suoi simili che fuggivano anch'essi in mondi paralleli, gli ricordo' l'ipotesi del greco Democrito, una serie infinita di universi identici ove vivono e muoiono una serie di filosofi prigionieri. Questa fantasticheria lo fece sorridere amaramente. I venti piccoli personaggi dello specchio sorrisero anch'essi, ognuno per conto suo. Li vide poi volgere a meta' il capo e dirigersi verso la porta."
E se un riconoscimento mancato conclude La vita errante, uno vero apre la via alla Vita immobile. Dopo 35 anni Zenone e' ritornato, sotto falso nome, a Bruges, la sua citta' natale: si fa chiamare Sebastiano Theus ed esercita la professione di medico."Fu durante questo periodo senza avvenimenti che lo riconobbero per la prima volta. Si trovava solo nel laboratorio quando i due monaci erano gia' partiti; era giorno di mercato e la solita sfilata dei poveri era durata dall'ora nona. Qualcuno busso' alla porta; era una vecchia che veniva ogni sabato a vendere burro in citta' e che desiderava dal medico un rimedio per la sciatica. Zenone cerco' sullo scaffale un vaso pieno di un potente revulsivo. Le si avvicino' per spiegargliene l'uso. All'improvviso scorse in quegli occhi azzurri sbiaditi un'espressione di lieta sorpresa che gliela fecero a sua volta riconoscere. Quella donna aveva lavorato nelle cucine della casa Ligre,all'epoca in cui egli era ancora bambino. Greta (si ricordo' tutt'a un tratto il nome) era sposata ... [...]
Quest'incontro casuale avrebbe dovuto preoccuparlo, avendogli dimostrato che rischiava ogni giorno altri riconoscimenti dello stesso genere; al contrario ne provo' un piacere di cui fu egli stesso meravigliato. [...]
Quel bambino al quale non pensava piu', quell'essere puerile che era insieme ragionevole e in un certo senso assurdo assimilare allo Zenone di oggi, qualcuno lo ricordava abbastanza per riconoscerlo in lui, e il sentimento della sua propria esistenza ne era come fortificato."
Zenone decidera' di fermarsi a Bruges, e vi rimarra' per parecchio tempo. La vita immobile appunto. Ma la sua ricerca non sara' per questo interrotta, anzi: "Quell'esistenza benche' immobile ribolliva; il senso d'una attivita' quasi terribile rombava come un fiume sotterraneo [ ] L'atto del pensare lo interessava ora piu' degli incerti prodotti del pensiero" perche', rifletteva Zenone "I pensieri periscono come gli uomini: nel corso di mezzo secolo aveva visto diverse generazioni d'idee cadere in polvere." E ancora: "Le figure via via assunte dallo spirito subivano la stessa sorte di quelle grandi forme nate dall'acqua indifferenziata che si scagliano le une contro le altre o si susseguono alla superficie dell'abisso; ogni concetto ricadeva alla fine nel proprio contrario, come due marosi che urtandosi si annullano in una sola candida schiuma".
Pensieri mutevoli come le onde: e, come le onde, in fondo nient'altro che acqua. Acqua indifferenziata. La stessa che, nei suoi esercizi di meditazione, sentiva confluire in se': "Ora, rinunciando per qualche tempo all'osservazione che distingue e individualizza dall'esterno per darsi tutto alla visione interiore del filosofo ermetico, lasciava che l'acqua contenuta in tutte le cose gli invadesse la camera come l'onda del diluvio. Il baule e lo sgabello galleggiavano; i muri si squarciavano sotto la pressione dell'acqua; cedeva al flusso che sposta tutte le forme e rifiuta di farsi comprimere da esse; sperimentava il mutamento di stato della falda d'acqua che si fa vapore e della pioggia che si fa neve; faceva suoi l'immobilita' temporanea del gelo e lo scivolar della goccia limpida che scende inspiegabilmente di traverso sul vetro, fluida sfida alla scommessa del calcolatore. Rinunciava alle sensazioni di tepore e di freddo che sono legate al corpo; l'acqua lo trascinava via cadavere con altrettanta indifferenza che un ciuffo di alghe. Rientrato nella propria carne, vi ritrovava l'elemento acqueo, l'urina nella vescica, la saliva sulle labbra, l'acqua presente nel liquido del sangue. "Acqua su acqua. L'identico nelle sue molteplici versioni: ma comunque l'identico. Come se l'unica cosa degna di essere indagata non fosse piu' la differenza fra lo Zenone bambino e quello adulto, ma il sottile filo che consente di usare ancora uno stesso nome per due persone che piu' diverse non le sapresti dire. Due, ma uno.
A margine c'e' da dire che la terza parte del romanzo, la conclusione, ha per titolo La prigione. Gia': proprio una gabbia; come quella da cui stiamo tentando di fuggire...
A proposito: ormai non possiamo piu' tirarci indietro; Zenone e' li', oltre il fuoco: dobbiamo fare un salto anche noi, aver fiducia in lui; seguirlo, prima che scompaia.
LA SCORCIATOIA
Zenone ci viene presentato la prima volta attraverso gli occhi di suo cugino: Enrico-Massimiliano. Enrico-Massimiliano ha appena 16 anni quando lancia in aria una monetina,perche' e' "in dubbio se arruolarsi nelle truppe dell'Imperatore o in quelle del re di Francia; [...] perse l'Imperatore." E parte. (Decisamente non era italiano.)
"Dopo la tappa di La Fère, un pellegrino lo precedeva sulla strada, a una distanza di un centinaio di tese. Andava in fretta. Enrico-Massimiliano, annoiato di non avere con chi scambiare due parole, accelero' l'andatura. Pregate per me a Compostella,' disse il Fiammingo gioviale. Avete indovinato,' rispose l'altro. Vi sono diretto.'Volto' il capo di sotto il cappuccio di stoffa bruna, ed Enrico - Massimiliano riconobbe Zenone."
Dunque: Zenone e' un pellegrino, e viaggia da solo. Questa descrizione rimarra' valida per tutto il romanzo. E' per questo che siamo costretti a seguirlo a distanza, due passi indietro. Lo spiamo, e dobbiamo far attenzione che non ci scopra: anche noi dobbiamo essere soli. E' un viaggio da fare in solitudine, questo.
Zenone precede Massimiliano.
Lo scarto tra Zenone ed Enrico-Massimiliano e' qualcosa di piu' essenziale: sempre, in ogni tempo ed in ogni luogo, io credo, Zenone precedera' il cugino di "un centinaio di tese". E' sulla base di questa convinzione che, con uno sforzo d'immaginazione, penso a Zenone nel mio secolo: la sua inquietudine la direi allora l'inquietudine di chi ha conosciuto le nausee esistenzialiste del primo 900; se il mondo davvero non ha senso, allora posso essere io a decidere il mio; dall'inizio alla fine. E paradossalmente, un atto come quello di rimettersi ad una moneta, nasconde un'innata fiducia nelle cose del mondo, nel loro corso. Come dire: se un destino c'e' (gia' scritto), e' irrilevante la mia volonta'; dunque posso lasciare che sia una moneta a decidere.Sarebbe cosi' la fiducia nel mondo la discriminante tra la fretta di uno Zenone e la noia di un Enrico-Massimiliano postmoderni. E fra gli originali? "Eccoti travestito da pagliaccio," disse Enrico-Massimiliano, osservando con curiosita' l'abito del pellegrino. "E' vero," ammise Zenone. "Ma ero stufo delle ciance dei libri. Preferisco compitare un testo che si muove: mille cifre romane e arabe; caratteri che si rincorrono tanto da sinistra a destra, come quelli dei nostri scribi, quanto da destra a sinistra, come quelli dei manoscritti orientali: cancellature che sono la peste o la guerra. Rubriche vergate con sangue vermiglio. E ovunque segni, e, qua e la', macchie, piu' strane ancora dei segni... Quale abito piu' adatto a percorrere la mia strada inosservato?... I miei piedi si muovono per il mondo come insetti sulla costa di un salterio."
Preferisco compitare un testo che si muove.
Il mondo e' come una "foresta di simboli", un testo da "compitare": qualcosa viene detto, a noi non resta che leggere, interpretare. E qui, anche se la memoria e' corsa subito a Baudelaire, il referente storico piu' corretto e' l'alchimia di Lullo e Paracelso, la loro concezione della natura in particolare. Se il Rinascimento affermava il primato dell'uomo, lo faceva si pensi alla lettera sull'Umanismo di Heidegger in virtu' di una concezione strumentale della natura stessa; e' proprio in difesa della natura pensata, aristotelicamente, come fusis, come organismo vivente, che si erge l'alchimia. Non oggetti da piegare ad un fine, ma entita' viventi auto-significanti. C'e' da dire che vi corrispondono, oltre che due diverse filosofie della natura, due diverse concezioni del linguaggio: si pensi all'ermetismo e, anche se per altra origine, alla Cabala. Interessante sarebbe, partendo da questa divaricazione,seguire i due ceppi (che la radice e' unica) fino ad oggi: il Neoclassicismo di Goethe opposto all'occasionalismo romantico; la lettera sull'Umanesimo di Sartre e la risposta di Heidegger.
Interessante sarebbe.
Quale abito piu' adatto a percorrere il mondo inosservato? Zenone, come abbiamo detto, vuole leggere il mondo, non dominarlo. Dunque la discrezione dell'osservatore. Una discrezione figlia, in parte della cautela:siamo nell'epoca dell'Inquisizione, e Zenone e' alchimista nonche' come si vedra' eretico. Ma la sua non e' un'eresia pretestuosa, un atteggiamento: no. E' piuttosto un accidente di percorso: e' la ricerca della verita' il suo obiettivo,e se questa si scontra con il pensiero della sua epoca, che sia. Piu' avanti ritornera' questo accordo tra la discrezione e la fedelta' al proprio credo,laddove Zenone chiacchierando ancora con Enrico-Massimiliano affermera' che i pensieri davvero diversi son quelli che passano inosservati. "Al primo bivio si separarono. Enrico-Massimiliano scelse la strada maestra. Zenone prese una scorciatoia." Enrico-Massimiliano ha tutta la mia stima: a sedici anni se ne e' andato da casa, nonostante il padre come gli ebbe a dire Zenone fosse "abbastanza ricco per comperarti la migliore compagnia di lanzichenecchi dell'Imperatore Carlo"; non e' poco. Ma l'unicita' di Zenone risalta proprio perche' l'altro termine di paragone e' un personaggio affatto banale. E' importante, prima di procedere, chiarire il nostro rapporto con questi personaggi; lo faro' attraverso una storiella che viene raccontata nel film La moglie del soldato. Uno scorpione deve attraversare un fiume, ma non sa nuotare. Va dalla rana e le chiede di aiutarlo, di traghettarlo sul suo dorso. La rana e' diffidente: "Io ti conosco, scorpione. Tu mi pungerai con la tua coda."E lo scorpione: "Perche' dovrei? Non so nuotare, affogheremmo entrambi." Cosi' la rana si convince e lo fa salire sul suo dorso. Durante il tragitto la rana si senti' pizzicare: era stato lo scorpione. La rana senti' che le forze la stavanolasciando, e mormoro': "Perche' l'hai fatto? Ora moriremo. Entrambi." Lo scorpione rispose: "Non ci posso fare nulla: e' la mia natura." Non ci posso fare nulla: e' la mia natura. Come dire che siamo tutti diversi, ognuno dotato di un'intima essenza che come nella storia della rana ci chiude in un ruolo, in una gabbia. La rana e' buona: non poteva non traghettare lo scorpione. E lo scorpione e' cattivo: non poteva non pungere la rana. Allo stesso modo Zenone non poteva non prendere la scorciatoia, ed Enrico-Massimiliano non poteva non scegliere la strada maestra: ognuno secondo la propria natura. Le stesse caratterizzazioni dei personaggi, al pari della bonta' della rana e della cattiveria dello scorpione, sono puramente descrittive: mettono a nudo la loro essenza. L'obbiettivo non e' infatti metterli in una ipotetica scala di valore per cui uno sarebbe migliore dell'altro etc. Tutto questo per dire che noi ci lasceremo provocare dai personaggi: non e' intenzione il giudicarli.
Abbiamo fatto il fatidico salto e non e' stato poi cosi' terribile: il fuoco non bruciava, era un'illusione; un'illusione figlia dell'abitudine. Zenone e' lontano e la strada su cui stiamo camminando si biforca: cosa fare? Proseguire (lungo la strada maestra) o deviare a sinistra? Enrico-Massimiliano scelse la strada maestra. Certo: anche noi, ora, potremmo dire di scegliere la strada maestra, ma che tipo di scelta e'? Anche se non l'avessimo vista, la stradina, si potrebbe continuare a dire che in un certo senso abbiamo scelto la strada maestra. Ed anche se non sappiamo dove porti la stradina e giustamente continuiamo sulla strada maestra, si puo' dire che abbiamo scelto. La Yourcenar scrive che Enrico-Massimiliano scelse la strada maestra, ma Enrico-Massimiliano sapeva che l'altra era una scorciatoia? La risposta piu' sensata e' che cio' sia irrilevante: forse la stradina era una scorciatoia solo per Zenone, mentre per Enrico-Massimiliano avrebbe significato allungare il proprio cammino, essendo diverse le rispettive destinazioni. O forse, semplicemente, preferiva la strada maestra per l'opportunita' di incontrare altri viandanti e chiacchierare: era "annoiato" Enrico-Massimiliano. Saperlo o non saperlo non avrebbe cambiato il suo destino; e per questo che la Yourcenar non si preoccupa di specificarlo. Ma Enrico-Massimiliano e' il personaggio di un romanzo, ed in un romanzo scritto bene tutti i conti tornano;forse della vita non si puo' dire lo stesso. Per noi, in quel bivio come in questo bivio - sarebbe cruciale [a] innanzitutto riconoscerlo come tale (vedere la stradina oltre alla strada maestra, quella su cui stiamo viaggiando), [b] sapere che la stradina e' una scorciatoia (almeno rispetto ad una certa direzione). L'unico che puo' dirci qualcosa e' dunque Zenone.
Zenone prese una scorciatoia. Zenone sta compiendo il primo vero viaggio della sua vita. Per quello che ne sappiamo nessuno gli ha detto che quella era una scorciatoia, e pure lui l'ha riconosciuta per quello che e': una via alternativa (piu' breve) per giungere a destinazione. Il suo e' un viaggio faticoso e difficile: deve essere per questo che ho immaginato una salita. Il primo requisito per compiere questo viaggio,sembra voglia suggerirci, e' saper guardare, vedere cio' che gli altri non vedono o vedono senza riconoscerne l'essenza; o comunque: saper riconoscere cio' che e' essenziale per noi. Qualcosa che, prima caratteristica, non e' sempre nella strada maestra.
C'e' una storiella, un'altra, che rende bene l'idea. E' sera, la strada e' scarsamente illuminata, ma in salita (!), cosi' vi accorgete di un tizio chino su un bordo: e' intento a cercare qualcosa. Non sembra pericoloso, vi avvicinate. "Cosa cerca?" "La mia chiave." Siete incuriositi: "Qui, al buio?" "Certo, - vi risponde con noncuranza - li' c'e' la luce." E' proprio li' che Zenone cerca la sua chiave: tra un lampione e l'altro, sul ciglio della strada maestra. Lungo il confine dell'ombra.
Leonardo Stagliano'