
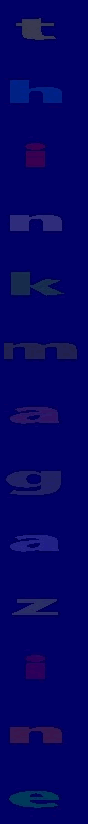
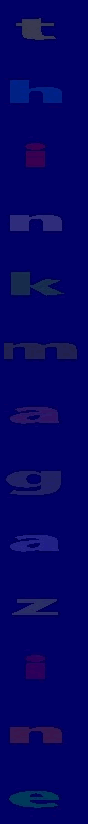
Razionalita' ed etica: Alcune osservazioni sulla is-ought question
Se ragionare significa trarre conclusioni da premesse, allora un'interessante interpretazione del tema della razionalita' in etica e' quella fornita dalla cosiddetta is-ought question: si possono trarre conclusioni normative o di valore da una serie di premesse che non contiene giudizi normativi o di valore? A questa domanda l'etica analitica nella sua fase classica ha risposto con un no categorico. Nelle pagine che seguono provero' brevemente ad esaminare la cogenza di due degli argomenti principali posti a sostegno di tale divieto, cercando di mettere in luce la loro erroneita', o perlomeno il loro carattere non conclusivo. Risultera' indirettamente che lo spazio per il ragionamento in ambito morale e' piu' ampio di quanto si e' pensato nel mondo anglo-americano per molti decenni. Dati i limiti di brevita' che mi sono imposto, lascero' volutamente fuori dalla mia disamina le argomentazioni peculiari del non cognitivismo etico a sostegno dell'inderivabilita' logica di ought-propositions da is-propositions.
Riservero' le mie considerazioni al solo ambito del cognitivismo etico.
1. I due dogmi dell'etica analitica
La filosofia morale di lingua inglese e' vissuta per molti decenni nella convinzione che fosse un errore di natura logica dedurre conseguenze morali da premesse puramente descrittive o ridurre, tramite definizioni, concetti morali in termini non morali. L'inderivabilita' ha addirittura assunto i connotati di una legge (la 'legge di Hume', la Hume's guillotine), la riducibilita' quelli di una fallacia (la fallacia naturalistica). Se la tesi dell'inderivabilita' porta scritto persino nell'etichetta il nome del suo antesignano, quella dell'indefinibilita' e' principalmente legata al nome di G. E. Moore, che la formulo' esplicitamente nei Principia Ethica (1903). Ma anch'essa risale al Settecento inglese ed e' articolata in maniera sufficientemente sistematica da Richard Price in A Review of the Principal Questions in Morals (1758), l'opera filosofico-morale piu' importante del XVIII secolo nel mondo anglosassone sul versante realista- razionalista (quello antitetico alla linea 'Hutcheson-Hume-Adam Smith', tanto per intenderci)1. Ovviamente e' abbastanza evidente la connessione tra le due tesi. La possibilita' di fondare l'etica su conoscenze di natura descrittiva non e' legata solo alla possibilita' di derivare direttamente valori da fatti.
Se un termine etico (es. 'buono') e' definibile in termini non etici (es.'desiderato da tutti') questo consente, rende possibile, il passaggio dall'essere al dover essere perfino se questo non fosse direttamente possibile. Infatti se 'x e' buono' significa 'x e' desiderato da tutti', allora dal fatto che il piacere e' desiderato da tutti posso derivare logicamente che il piacere e' buono, anche se risultasse impossibile la derivazione diretta di 'il piacere e' buono' da 'il piacere e' desiderato da tutti'. E quindi la tesi dell'indefinibilita' dei termini etici in termini non etici rappresenta un ulteriore puntello a sostegno della grande divisione tra essere e dover essere. Entrambi i divieti ('legge di Hume' e critica della fallacia naturalistica) hanno costituito una forte limitazione all'idea che la ragione abbia un ruolo rilevante nelle questioni morali.
Fra i tanti argomenti a favore della 'legge di Hume', quello risultato sicuramente prevalente consiste nell'appellarsi ad una regola generale delle inferenze corrette. In un argomento deduttivamente valido, si afferma, la conclusione non ha nulla di creativo, non fa altro che convalidare quanto e' espresso dalle premesse; non aggiunge nulla a quanto gia' asserito in esse; non e' altro che un prendere atto di quanto gia' asseriscono le premesse, secondo il modello consolidato della sillogistica antica: Tutti gli uomini sono mortali; Socrate e' un uomo; Socrate e' mortale. Se nelle premesse non compaiono affermazioni etiche o di valore, allora esse non possono comparire nella conclusione. Sarebbe un trucco, un gioco di prestigio. Come asseriva Arthur Pap piu' di trent'anni fa, "prodigarsi per una scienza normativa in cui si giunga a conclusioni normative a partire da premesse descrittive puramente fattuali e' come sforzarsi di estrarre un coniglio da un cappello di seta"2.
Quest'argomentazione e' reperibile in Hume 3 (seppur in maniera implicita e con molte ambiguita') e nella maggior parte dei fautori novecenteschi dell'inderivabilita' del dover essere dall'essere4. L'idea che definire i termini etici in termini descrittivi dia vita ad una fallacia e' legata principalmente ad un argomento detto della 'domanda aperta' (open question argument). Esso e' gia' presente ed e' applicato sistematicamente nella Review priceana e poiche' questo testo e' poco noto, soprattutto in Italia, intendo prenderlo come punto di riferimento nella trattazione dell'argomento nelle pagine che seguono5.
Per esporre l'open question argument, serviamoci di un esempio piuttosto celebre, il piu' adottato dallo stesso Price: applichiamolo alla cosiddetta teoria del comando divino (chiamata anche volontarismo teologico), per la quale i termini morali altro non esprimono se non i comandi (le prescrizioni, le direttive) e i divieti della divinita'. L'argomento afferma quanto segue: non si da' il fatto che il termine 'giusto' significhi 'comandato da Dio', perche' se cosi' fosse, allora non si potrebbe sensatamente affermare che 'cio' che e' comandato da Dio e' giusto', in quanto equivarrebbe ad affermare un truismo, sarebbe come dire che 'cio' che e' comandato da Dio e' comandato da Dio'. Ma per noi un'espressione del genere ('cio' che e' comandato da Dio e' giusto') e' tutt'altro che insensata. Quando una persona afferma che 'e' giusto cio' che e' comandato da Dio' non intende certo esprimere la banale tautologia 'cio' che e' comandato da Dio e' comandato da Dio'.
Lo stesso ragionamento vale per l'equisignificanza tra 'ingiusto' e 'vietato da Dio'; e dunque, per chiarezza espositiva, conviene tralasciarlo (cosa che faro' anche nei successivi esempi). Il medesimo argomento e' formulabile (e di fatto e' stato formulato) anche in una versione interrogativa (detta della 'self- answering question') e in una versione negativa (detta dell'autocontraddizione). Vediamole nell'ordine.
Non e' possibile che 'giusto' significhi 'comandato da Dio', perche' in tal caso (cioe' se la definizione fosse corretta) chiedersi 'cio' che e' comandato da Dio e' giusto?' (oppure: 'A e' comandato da Dio, ma e' giusto?') equivarrebbe a porsi l'insulsa domanda 'cio' che e' comandato da Dio e' comandato da Dio?' ('A e' comandato da Dio, ma e' comandato da Dio?'). Ma di certo noi non riteniamo futile il quesito in discussione; lo consideriamo tutt'altro che una domanda che ha gia' contenuta in se' la risposta (una self-answering question)6. Discorso analogo per la versione in negativo dello stesso argomento. Se 'giusto' fosse definibile con 'comandato da Dio' non potremmo dire in modo significante che 'cio' che e' comandato da Dio non e' giusto' (o: 'A e' comandato da Dio, ma non e' giusto'), perche' sarebbe come formulare il giudizio autocontraddittorio 'cio' che e' comandato da Dio non e' comandato da Dio (oppure: 'A e' comandato da Dio, ma non e' comandato da Dio'). Ma noi non pensiamo affatto che un'affermazione del genere ('cio' che e' comandato da Dio non e' giusto') esprima una contraddizione, e quindi la definizione proposta e' sbagliata (perche' se fosse corretta, la negazione della congiunzione tra il definiens e il definiendum dovrebbe suonarci come autocontraddittoria).
Lo stesso genere di procedimento confutatorio varrebbe, per Price (come per Moore e per gli altri critici del riduzionismo etico), anche nel caso che a 'comandato da Dio' sostituissimo qualsiasi altra espressione non etica (come 'conforme alle leggi positive' o 'vantaggioso', tanto per citare altre due teorie con cui Price esemplifica la sua critica). Non c'e' alcun valore descrittivo che possa essere assegnato al definiens tale da rendere la proposizione affermativa formata dalla congiunzione fra il definiens e il definiendum un'insignificante tautologia, quella interrogativa una self-answering question, quella negativa un'affermazione che suona come autocontraddittoria.
Tutte e tre le versioni dell'argomento hanno in comune la struttura logica, il modus tollens, ovvero la forma della dimostrazione per assurdo: se p allora q; ma non q, dunque non p 7. In tutti e tre i casi, cioe', si afferma qualcosa di questo genere: se il termine 'giusto' (e i suoi svariati sinonimi etici) fosse definibile con un termine descrittivo ('comandato', 'approvato', 'vantaggioso' ecc.), allora scaturirebbe una certa conseguenza q; ma q, per una ragione o per l'altra, non si da'; dunque 'giusto' non e' definibile con un termine descrittivo. Dove la conseguenza q che non risulta e' che una certa proposizione, quella composta dall'unione del definiens col definiendum, sarebbe, a seconda della versione che prendiamo in considerazione (affermativa, interrogativa o negativa), rispettivamente, una banale tautologia, una domanda insignificante, un'affermazione autocontraddittoria. Ovviamente disponendo della struttura logica del modus tollens l'argomento, in tutte e tre le versioni, e' formalmente valido.
2. Alcuni dubbi sulla 'legge di Hume'
L'argomento della conclusione che ratifica semplicemente quant'e' contenuto nelle premesse, abbozzato da Hume ed esplicitamente asserito da Nowell-Smith, Oppenheim ecc., oggigiorno mostra la corda, e si e' affermato paradossalmente in un'epoca, il XX secolo, in cui la logica ha abbandonato questa pretesa, tipica della logica aristotelica. Tanto e' vero che bastano semplicissimi controesempi per smentirlo. Mi limitero' a farne tre. Dalla premessa p e' derivabile logicamente la conclusione p(q (ad esempio, da 'l'erba e' verde' deriva logicamente 'l'erba e' verde o il cielo e' blu'). Ma non si puo' certo dire che in tal caso la conclusione e' contenuta nella premessa. Un altro possibile controesempio e' il seguente: da q e' derivabile p®q, che da' vita al cosiddetto principio dell'a fortiori (dalla premessa 'Giovanni passeggia' e' derivabile logicamente, nella logica ordinaria, la conclusione 'posto che Carlo corra, Giovanni passeggia'). Ancora: dalla premessa 'Carlo passeggia' deriva logicamente (in senso formale) la conclusione 'qualcuno passeggia'. Anche in questo caso il termine 'qualcuno' non e' contenuto nella premessa. E di qui quanti ancora se ne vuole. Il principio in questione e' inadeguato perche' non riesce a comprendere sotto di se' tutte le inferenze logiche, nella loro totalita'. Se funziona per il sillogismo aristotelico non va gia' piu' bene per le semplici inferenze della logica contemporanea. Con questo non intendo sostenere che la tesi dell'indeducibilita' dei valori dai fatti (tanto per darle una formulazione celebre seppur imprecisa) sia ingiustificata. Ma piu' semplicemente mettere in luce come l'argomento principale con cui e' stata sostenuta nel nostro secolo sia destituito di qualsiasi fondamento. L'idea che la 'legge di Hume' sia banalmente vera in quanto si fonda sulla regola generale delle inferenze corrette e' sbagliata, proprio perche' la regola in questione e' tutt'altro che generale, tutt'altro che comprensiva di ogni inferenza corretta. La scarsa utilizzabilita' di questi controesempi sul piano morale non toglie che essi rappresentano una confutazione dell'argomento principale portato a sostegno della 'legge di Hume'8.
Piu' complessa e' l'analisi della validita' o meno dell'open question argument.
Ad essa va riservato uno spazio maggiore.
3. Alcuni dubbi sull'idea di fallacia naturalistica
Non e' facile capire perche' Price (e con lui i sostenitori dell'open question argument, i suoi seguaci consapevoli ed inconsapevoli) ritenga che un termine etico (nel suo caso 'giusto') sia irriducibile a dei termini descrittivi (quali 'approvato', 'comandato', 'vantaggioso' ecc.), pena l'insensatezza della proposizione a cui da' vita la loro congiunzione. L'idea che sembra soggiacere a questo tipo di ragionamento e' che se una definizione, una definizione qualsivoglia, e' valida, allora la proposizione che congiunge definiens e definiendum risulta identica ad una tautologia, ovvero, tanto per servirsi del solito esempio, allora dire 'cio' che e' comandato da Dio e' giusto' sarebbe la stessa cosa di dire che 'cio' che e' comandato da Dio e' comandato da Dio'; chiedersi 'cio' che e' comandato da Dio e' giusto?' sarebbe come chiedersi 'cio' che e' comandato da Dio e' comandato da Dio?'; asserire che 'cio' che e' comandato da Dio non e' giusto' sarebbe come affermare che 'cio' che e' comandato da Dio non e' comandato da Dio'. Se cio' non risulta la definizione e' scorretta. Questo vale in particolare per le definizioni dei termini etici in termini non etici.
E' corretto questo presupposto? E' vero che se una definizione e' valida allora dire 'cio' che e' comandato da Dio e' giusto' e' come dire che 'cio' che e' comandato da Dio e' comandato da Dio'? Si tratta di capire che cosa significa quel 'e' come dire che'. E' evidente che delle differenze ci sono. Nelle due affermazioni compaiono termini diversi. Ma mi pare ovvio che Price e i sostenitori dell'open question argument non intendono riferirsi ad un'equivalenza di tipo morfologico. Sarebbe davvero insensato pretendere che una definizione valida permettesse di conservare tra le due proposizioni in questione anche un'identita' morfologica. Quindi Price non puo' che riferirsi ad altri due sensi di equivalenza: l'equivalenza in un senso che potremmo chiamare logico e l'equivalenza in un senso psicologico-pragmatico.
Cominciamo ad esaminarle partendo da quest'ultima opzione.
Se dico: 'quest'uomo non e' sposato, ma e' scapolo?' subito i miei interlocutori avvertono un senso di stranezza e di insulsaggine nella mia domanda. La ritengono insensata poiche' le due parole denotano la medesima proprieta' e dunque se l'individuo in questione possiede l'una non si vede perche' non dovrebbe possedere anche l'altra. Invece se dico: 'questa cosa e' desiderata; ma e' buona?' Noi non avvertiamo la stessa sensazione. La domanda pare tutt'altro che insensata. E cio' ci fa dunque pensare che 'buono' e 'desiderato', al contrario di 'scapolo' e di 'non sposato', non denotino la medesima proprieta'. Lo stesso vale per le corrispondenti affermazioni negative. 'Quest'uomo non e' sposato, ma non e' scapolo' ci risulta autocontraddittoria. Invece 'questa cosa e' desiderata, ma non e' buona' non ci appare tale. E proprio perche' non ci appare autocontraddittoria siamo propensi a pensare che 'desiderato' non costituisca l'adeguato definiens per il definiendum 'buono'. Poiche' quando c'e' un adeguato rapporto tra definiens e definiendum, ovvero quando il secondo costituisce un'adeguata definizione del primo, allora la negazione della loro congiunzione risulta autocontraddittoria, come per 'scapolo' e 'non sposato'. L'idea dei fautori dell'argomento della 'domanda aperta' e' che questo effetto psicologico valga per tutte le definizioni corrette.
C'e' un'altra possibilita'. Quella di sostenere che se un termine morale, ad esempio 'buono', fosse riducibile ad un termine descrittivo, ad esempio 'desiderato', allora dire che 'cio' che e' desiderato e' buono' sarebbe equivalente o identico logicamente ad una tautologia. Ora, Price nel Settecento non ha presente la distinzione tra tautologia e giudizio analitico, ma si puo' ben pensare che non ritenesse 'cio' che e' desiderato e' buono' la stessa cosa di 'cio' che e' desiderato e' desiderato', che anche lui ne cogliesse la differenza (nel caso ipotizzato che 'buono' fosse definibile con 'desiderato'). Infatti, sotto il profilo logico, la tautologicita' formale spetta solo al secondo giudizio. Solo quest'ultimo e' un asserto la cui verita' dipende esclusivamente dalla struttura logica della proposizione.
La verita' del primo giudizio dipende invece anche dal significato dei termini descrittivi che vi compaiono. Un giudizio del genere oggigiorno si chiama giudizio analitico. Ebbene sicuramente, una volta fatti alcuni aggiustamenti, c'e' del vero nell'ipotetico ragionamento di Price. E' vero che se 'buono' significasse 'desiderato' allora il giudizio 'cio' che e'desiderato e' buono' risulterebbe essere un giudizio analitico. E si puo'presumere che il suo ragionamento proseguirebbe cosi': ma 'cio' che e'desiderato e' buono' non e' un giudizio analitico (essendo tutti i giudizi morali rilevanti sintetici), dunque la definizione e' sbagliata. Il problema adesso e' capire se la tesi secondo cui i giudizi morali rilevanti non possono essere analitici e' sensata oppure no. Su che cosa si fonda? Sull'idea che i giudizi analitici sono vuoti di contenuto. Mentre i giudizi morali rilevanti non appaiono tali.
L'argomento, in tutte le sue sfaccettature, negli ultimi decenni e' stato sottoposto ad una serie di critiche particolarmente acuta. Il testo che nel panorama filosofico italiano (ma non solo in esso) le ha sapute raccogliere adeguatamente e' lo studio di Gaetano Carcaterra Il problema della fallacia naturalistica 9. Un poderoso volume (piu' di seicento pagine) di trent'anni fa che appare tutt'altro che datato. Emerge anzi per rigore logico e profondita' analitica. Semplificando e sintetizzando, Carcaterra muove tre critiche all'argomento della 'questione aperta'. Una di carattere generale, una alla versione psicologico-pragmatica, una a quella logica.
1) A livello generale, Carcaterra rileva come un siffatto argomento rischi di cadere nel 'paradosso dell'analisi', rendendo impossibile (in quanto scorretta), qualsiasi definizione. Infatti, se tutte le definizioni corrette ('A = B') hanno come conseguenza quella di rendere la congiunzione tra definiens e definiendum ('cio' che e' B e' A') del tutto identica ad una tautologia ('cio' che e' B e' B'), allora nessuna definizione risulta piu' vera, perche' in nessun caso dire che 'B e' A' e' la stessa cosa (in tutti i sensi) di dire che 'B e' B'. Il difetto dei sostenitori di tale argomento sta nel non aver colto i limiti delle caratteristiche che anche una definizione valida trasmette dal definiendum al definiens. Il fatto che due termini siano identici non significa che allora si possa sostituire in qualsiasi contesto l'uno con l'altro senza creare problemi, ne' che la sostituzione non modifichi le caratteristiche logiche o quelle psicologiche e pragmatiche possedute dai due termini 10. La interdefinibilita' non garantisce una totale equivalenza tra definiens e definiendum. Se la correttezza di una definizione conserva, nel passaggio dal definiendum al definiens, alcune proprieta' non e' cosi' per tutte le proprieta'. E questo vale in particolar modo sotto il profilo psicologico-pragmatico e sul piano logico. Di qui le critiche successive.
2) A livello psicologico-pragmatico, Carcaterra sottolinea come l'open question argument cessi di funzionare non appena passiamo da termini di uso quotidiano a termini di natura scientifica o filosofica (in ogni caso a termini meno frequenti nel linguaggio ordinario)11. Il test che l'argomento propone, se avesse valore universale metterebbe fuori gioco tutte le definizioni scientifiche, eccetto quelle di largo dominio. Richiamando un esempio di Hempel, Carcaterra rileva come la definizione hutchinsoniana di "essere vivente" con "che ha una massa limitata ed e' dotato di proprieta' metaboliche e riproduttive", risulterebbe falsa, perche' l'affermazione che congiunge definiens e definiendum non risulta affatto banale, la domanda corrispondente e' tutt'altro che una self-answering question, ne' la negazione appare contraddittoria12. Ovvero, se il test funziona per 'scapolo' e 'non sposato' (una definizione sicuramente vera rende strana la congiunzione tra definiens e definiendum) non funziona piu' per 'essere vivente' (una definizione vera non rende affatto insensate l'affermazione, l'interrogazione e la negazione create dal congiungimento tra definiens e definiendum).
3) Sul piano logico, se e' vero che dalla validita' della definizione di un termine etico con un termine non etico discende il carattere analitico del giudizio che collega definiens e definiendum (e quindi se la definizione non trasmette la tautologicita' trasmette perlomeno l'analiticita'), questo non comporta la confutazione della definizione, perche' e' tutt'altro che dimostrata l'impossibilita' che i giudizi morali (e non solo quelli banali del tipo 'cio' che e' ingiusto e' iniquo') possano essere analitici. Essa si fonda su un'idea ormai superata dei giudizi analitici come giudizi vuoti, privi di contenuto. In realta' si possono dare giudizi analitici nei quali il predicato non e' affatto una mera riformulazione del soggetto (come nell'esempio appena proposto). E Carcaterra li esemplifica con la proposizione 'tutti i triangoli equilateri sono equiangoli (e viceversa)', che e' tutt'altro che un'asserzione vuota di contenuto. Tanto e' vero che i metodi di verifica e di risoluzione del soggetto (il triangolo in questione e' equilatero?) e del predicato (il triangolo in questione e' equiangolo?) possono essere diversi13.
Ma ammettiamo pure che il meccanismo messo in moto dall'open question funzioni, e che quindi una definizione se corretta renda la proposizione interrogativa formata dalla congiunzione tra definiens e definiendum una self-answering question e quella negativa un'affermazione autocontraddittoria. Chi ci assicura che non sia possibile reperire definizioni di termini etici o di valore in termini descrittivi che danno vita a domande 'chiuse' e a negazioni autocontraddittorie (le quali, percio', convaliderebbero le definizioni)? A questa domanda i sostenitori della critica della fallacia naturalistica non hanno mai fornito risposte convincenti. Anche accettando la struttura dell'argomento, non si puo' asserire sulla base di esempi particolari, generalizzati per induzione, che esso funzioni per tutti i tentativi di riduzione di un concetto etico ad un concetto non etico.
4. Conclusione
C'e' un aspetto comune ad entrambi le strutture argomentative principali a sostegno della 'legge di Hume' e della critica alla fallacia naturalistica.
Sia l'argomento dell'inclusione della conclusione nelle premesse, sia l'open question argument pretendono di dettare, rispettivamente, le linee universali dell'inferenza e della definizione corretta. Nel primo caso l'idea e' quella che in tutte le inferenze valide la conclusione e' gia' contenuta nelle premesse. Nel secondo caso l'idea e' che in tutte le definizioni corrette la congiunzione tra definiens e definiendum da' vita ad una self-answering question o ad una affermazione autocontraddittoria.
L'errore comune sta in questa pretesa all'universalita'. Non e' vero che in tutte le inferenze corrette la conclusione non fa altro che ratificare quanto e' contenuto nelle premesse. Non e' vero che per tutte le definizioni corrette si viene a creare il meccanismo della self-answering question e dell'autocontraddizione.
L'inefficacia di due dei principali argomenti a sostegno della 'legge di Hume' e della critica alla fallacia naturalistica rende sempre piu' ingiustificati i divieti ad essi connessi ed apre la strada ad una fondazione dell'etica su asserti concernenti fatti di natura non etica.
Viene cosi' meno una forte limitazione all'idea che la ragione abbia un ruolo rilevante nelle faccende morali.
L'etica analitica e il concetto di dovere, recensione a Luca Fonnesu, Dovere, Scandicci (Firenze), La Nuova Italia, 1998, pp. 145.
E' ormai una consuetudine consolidata suddividere l'etica o filosofia morale in tre tipi d'indagine distinti: la metaetica, l'etica descrittiva e l'etica normativa. Cio' che accomuna l'etica descrittiva e la metaetica e' il fatto che entrambe costituiscono indagini di secondo livello, ovvero mettono a punto teorie che non sono propriamente etiche ma vertono sull'etica, hanno l'etica come proprio oggetto di riflessione. Ma mentre l'etica descrittiva costituisce la riflessione non filosofica (ma sociologica, antropologica, psicologica ecc.) sulla morale, la metaetica rappresenta invece la riflessione filosofica sulla morale. Grosso modo fare un discorso non filosofico sulla morale significa mettere a punto una teoria causale sull'origine di determinati codici morali, in relazione a fattori sociali, etnologici, psicologici ecc., che e' appunto cio' di cui si occupano la sociologia, la psicologia, l'antropologia culturale. Mentre l'etica descrittiva e' prevalentemente oggetto delle scienze umane e sociali, gli altri due tipi di indagine costituiscono piu' propriamente il nucleo del lavoro filosofico. La metaetica si occupa di questioni ontologiche, epistemologiche e logico- semantiche concernenti l'etica. Tenta cioe' di rispondere a domande del tipo 'qual e' la natura delle idee morali?', 'si danno valori oggettivi o meno?', 'e' possibile giustificare (dimostrare, provare, verificare) i giudizi morali, e se si' con che metodo?' ecc. L'etica normativa invece ha per oggetto il criterio dell'azione giusta e il canone delle buone motivazioni e delle disposizioni virtuose. Essa puo' essere suddivisa ulteriormente, come per lo piu' si fa oggigiorno, in etica teorica ed etica pratica (o etica applicata). Mentre l'etica teorica e' volta a mettere a punto sistemi generali, principi etici basilari (quindi ad individuare i principi ultimi della condotta moralmente corretta, delle motivazioni moralmente buone, dei tratti del carattere virtuosi), l'etica pratica e' invece interessata ad applicare questi schemi alle situazioni morali concrete. Se l'etica teorica ha a che fare con le teorie deontologiche, con l'utilitarismo, con le teorie dei diritti ecc., l'etica pratica ha prevalentemente per oggetto le questioni della bioetica, seppur non sia riducibile ad essa (vi sono anche ambiti, sorti di recente, come ad esempio quello dell'etica degli affari, che fanno parte dell'etica applicata pur non essendo direttamente coinvolti con le questioni bioetiche). In una battuta, un conto e' dire che gli antichi Romani ritenevano giusto l'aborto (etica descrittiva), un altro che l'aborto e' giusto (etica normativa), un altro ancora dire che 'l'aborto e' giusto' e' un giudizio sintetico a priori (metaetica). Tutte queste distinzioni e ripartizioni si debbono, per la grande totalita', alla filosofia morale di lingua inglese, e in particolar modo all'etica di stampo analitico, la cui origine, a torto o a ragione, si fa risalire ai Principia Ethica di G. E. Moore (1903).
Sebbene molto piu' diffusa rispetto agli anni Sessanta e Settanta, l'etica di stampo analitico non ha ancora il ruolo che le spetta nel nostro paese, ne' a livello accademico ne' a livello editoriale. E' il retaggio della forte influenza che in Italia hanno esercitato la cultura cattolica e quella marxista. La prima connettendo l'etica necessariamente ad una fondazione teologica, la seconda riducendola a mera ideologia (e non solo a livello di contenuto, ma pure a livello di forma: non sono ideologiche solo la morale borghese, la morale cristiana ecc.; e' ideologico il solo fatto che si usi il linguaggio morale, che si giustifichi un atto o uno stato di cose dicendo che e' giusto o buono). Per questo un libro come quello di Fonnesu non puo' che essere accolto con gioia da chi e' interessato al fiorire di etiche laiche anche nel nostro paese. Il testo ha la struttura di un manuale introduttivo al concetto di dovere, ma la sua esposizione si rivela sufficientemente articolata. Sotto questo profilo il lavoro di Fonnesu costituisce un buon viatico alle questioni etiche di primo e di secondo livello. Il concetto di dovere viene esaminato sul piano terminologico, nelle sue origini storiche, relativamente alle principali questioni metaetiche e normative. Ma viene anche adeguatamente distinto dalla nozione di obbligo giuridico, viene affrontato in relazione ai difficili problemi che pone il conflitto tra norme e in relazione alle teorie motivazionali (per le quali rimane centrale la dicotomia tra esternalismo ed internalismo). Fonnesu molto opportunamente non limita la sua disamina all'area anglo- americana (anche se nel XX secolo l'etica ha avuto uno sviluppo sistematico prevalentemente nel mondo di lingua inglese), fa alcune interessanti incursioni anche nella filosofia morale di stampo continentale, mettendo a confronto le conclusioni dell'etica analitica con quelle di pensatori come Weber, Scheler, Hartmann ecc. L'autore sottolinea come la riflessione filosofico- morale dei paesi di lingua inglese abbia subi'to un forte mutamento a partire dagli anni Settanta (simbolicamente inaugurato da Una teoria della giustizia di J. Rawls, opera del 1971). Se fino ad allora il compito principale, se non esclusivo, del filosofo morale risiedeva nell'analisi del linguaggio (nell'analisi di termini come 'buono', 'giusto', 'dovere'), a partire da allora diviene preminente l'etica normativa, che pone in secondo piano tutta la riflessione e il lavoro logico-semantico messo a punto nei decenni precedenti. In realta' cio' di cui e' carente la fase precedente non e' tanto l'etica normativa in toto, quanto l'etica pratica, perche' la presenza dell'etica teorica e' invece massiccia, sia nelle opere di Moore che in quelle degli anni trenta (si vedano per tutti le opere di W. D. Ross). Non e' vero che prima degli anni Settanta non si fa etica normativa, o se ne fa poca, e' vero invece che prima degli anni Settanta la riflessione filosofica concentra la sua attenzione prevalentemente sulle questioni metaetiche e sui grandi schemi teorici dell'etica normativa, trascurando o mettendo in secondo piano l'applicazione di questi parametri alle questioni pratiche. Nel mutato quadro di riferimento Fonnesu sottolinea giustamente come, a differenza dei decenni passati (negli anni di predominio dell'empirismo logico e delle sue propaggini), la metaetica non e' piu' limitata alla sola analisi del linguaggio. Prova ne e' il fatto che la principale dicotomia a questo livello non e' piu' quella tra cognitivismo etico e non cognitivismo (una contrapposizione di stampo epistemologico), ma quella tra realismo etico e non realismo (o antirealismo), ovvero una contrapposizione di natura ontologica. Nonostante cio', in Dovere Fonnesu ripropone l'ormai classica tripartizione delle teorie metaetiche in intuizioniste, naturaliste e non cognitiviste. Se gli intuizionisti e i non cognitivisti sono accomunati dall'adesione alla 'legge di Hume', dissentono pero' radicalmente sullo status di verita' concernente i giudizi morali.
Mentre per gli intuizionisti ha senso ascrivere i predicati 'vero' e 'falso' ai giudizi morali, per i non cognitivisti non si danno verita' in etica, perche' i giudizi morali hanno funzioni diverse da quelle delle asserzioni (non descrivono, ma impartiscono direttive ed esprimono atteggiamenti). I naturalisti invece hanno in comune con l'intuizionismo il fatto di essere cognitivisti, ovvero la tesi per cui le valutazioni morali sono predicabili di verita' e falsita', ma dissentono dagli intuizionisti in quanto negano la validita' della 'legge di Hume'. Nell'eterna disputa tra teorie deontologiche e teorie teleologiche l'autore da' il giusto risalto ad una prospettiva che in qualche modo puo' essere considerata una terza via tra le versioni piu' estreme delle due famiglie di teorie in questione. Mi riferisco alla teoria dell'obbligo morale messa a punto da W. D. Ross in The Right and the Good (1930) e in Foundations of Ethics (1939). La teoria di Ross, pur rimanendo deontologica (e non interamente conseguenzialista) possiede alcune specificita' che le fanno assumere i connotati di flessibilita' che da sempre costituiscono il tratto attraente delle teorie utilitariste. Concependo gli obblighi basilari non come assoluti ma come relativi (o prima facie, per usare la locuzione da lui adottata), la teoria di Ross 1) da un lato evita l'incoerenza che caratterizza le teorie deontologiche con una pluralita' di principi assoluti; 2) dall'altro evita l'impoverimento di quelle teorie che non riconoscono una pluralita' di istanze nella moralita'.
Francesco Allegri
Pontara e l'utilitarismo, recensione a Giuliano Pontara, Breviario per un'etica quotidiana. Bene individuale, utilita' collettiva, Milano, Nuova Pratiche, 1998, pp. 222.
L'utilitarismo e' la teoria dell'obbligo morale piu' discussa degli ultimi due secoli. Essa afferma che si da' un solo principio etico basilare (nel senso di ultimo, non derivabile logicamente da altri principi morali), il quale prescrive di massimizzare le conseguenze benefiche e minimizzare le conseguenze dannose delle azioni rispetto a tutti gli esseri senzienti.
Detto in termini piu' specifici, dal punto di vista utilitarista quello che conta per stabilire se un atto e' moralmente giustificato, doveroso o sbagliato e' soltanto il bilancio di tutte le sue conseguenze benefiche e malefiche comparato con quello delle azioni alternative che l'agente avrebbe potuto compiere al suo posto se solo l'avesse scelte. L'azione che presenta il bilancio migliore e' quella che deve essere mandata ad effetto. Se risulta che le azioni piu' benefiche o meno dannose sono due a pari punteggio, allora e' indifferente optare per l'una o per l'altra, purche' si opti per una delle due. L'appellarsi esclusivamente alle conseguenze delle azioni in termini di beni e mali distingue l'utilitarismo dalle teorie deontologiche, per le quali o le conseguenze non sono rilevanti per lo status deontico di un'azione (deontologismo puro), oppure non sono l'unico fattore rilevante, perche' conta anche la natura dell'azione ecc. (deontologismo impuro). Il riferimento alla generalita' degli esseri senzienti lo distingue invece da un'altra teoria di stampo conseguenzialista: l'egoismo etico (per il quale per stabilire se un'azione e' giusta o meno contano soltanto le conseguenze in termini di vantaggio personale). Quella appena delineata e' la struttura comune a tutte le teorie utilitariste. Le quali poi si differenziano: 1) per il fatto di applicare il principio in questione o alle azioni particolari (utilitarismo dell'atto), o a classi di azioni (utilitarismo generalizzato), o a norme (utilitarismo della norma); 2) per il fatto di limitarsi a calcolare le conseguenze delle opzioni alternative scegliendo quella che consegue la somma algebrica piu' elevata (utilitarismo del totale), oppure per il fatto di suddividere la somma algebrica totale di ciascuna alternativa per il numero di individui coinvolti (utilitarismo della media);
3) per il fatto di connettere la teoria dell'obbligo utilitarista ad una teoria del valore edonista, per la quale si da' una sola cosa che ha valore intrinseco, il piacere, ed una sola cosa che ha disvalore intrinseco, il dolore (utilitarismo edonista), oppure ad una teoria del valore pluralista, per la quale si da' una pluralita' di cose intrinsecamente buone (utilitarismo ideale), o, ancora, calcolare i beni e i mali in termini di interessi o preferenze (utilitarismo della preferenza). Ritenendo che la giustezza delle azioni dipende dalle conseguenze in termini di beni e di mali, l'utilitarismo e' una teoria assiologica, ovvero una teoria che ritiene cio' che e' giusto esclusivamente funzione di cio' che e' buono. Asserendo che i beni e i mali da calcolare vanno individuati nelle conseguenze, essa si differenzia da altre forme di assiologismo (per le quali o i beni e i mali sono reperibili nelle azioni in se stesse, ovvero si danno azioni fornite di valore intrinseco, oppure sono reperibili anche negli antecedenti causali delle azioni e segnatamente nei fattori intenzionali e motivazionali). In questo libro G. Pontara prova a difendere una particolare versione di utilitarismo: l'utilitarismo del totale, edonista e dell'atto. Questa teoria altro non e' che il cosiddetto utilitarismo classico, sostenuto, tra gli altri, da Bentham e da Sidgwick. Al di la' del tentativo di riproposizione dell'utilitarismo classico, il libro intende essere un'introduzione generale all'utilitarismo, di cui vengono opportunamente scandagliate tutte le sfaccettature (e che per questo motivo sarebbe stato piu' opportuno intitolare 'Breviario per un'etica utilitarista' invece che 'Breviario per un'etica quotidiana'). Il testo di Pontara possiede notevoli pregi, come d'altra parte tutta la produzione scientifica di questo filosofo trentino che ha insegnato per molti anni in Svezia e che oggigiorno puo' essere considerato una delle voci piu' autorevoli, se non la piu' autorevole, dell'etica analitica italiana. E' suddiviso in brevi capitoli, il che ne favorisce la lettura. Brilla per rigore logico e chiarezza semantica.
Pontara non e' per niente un filosofo impressionista. I suoi libri sono pieni di serrate argomentazioni e controargomentazioni. Evidenziano sempre una grande onesta' intellettuale. Pontara non si costruisce mai avversari facili, e' consapevole che le posizioni filosofiche vanno attaccate nei loro punti di forza e non nei loro punti di debolezza (semmai questi ultimi vanno eliminati venendo in aiuto all'avversario, emendando la posizione che si intende confutare). Questo volume non fa eccezione a suddetto stile filosofico. L'autore e' approdato all'etica teorica utilitarista negli anni Ottanta, in un altro testo, Filosofia pratica (1988), di cui molte parti del Breviario rappresentano una ripresa o un'esposizione piu' succinta. Nei libri precedenti (e segnatamente nell'eccellente Se il fine giustifichi i mezzi del 1974, uno dei pochi capolavori sfornati dall'etica analitica italiana) Pontara sosteneva invece una posizione antitetica a quella utilitarista: difendeva una forma di teoria deontologica non dissimile da quella elaborata da W. D. Ross (da cui se ne distingueva ammettendo la possibilita' di doveri assoluti). Sinceramente non ho mai trovato una giustificazione articolata ed argomentata a sufficienza da parte di Pontara per l'abbandono di quella prospettiva, che con la sua struttura di doveri relativi (o prima facie) garantiva a sufficienza le esigenze di flessibilita' tipiche della tradizione utilitarista.
Il compito che Pontara si propone nel Breviario e' assai arduo, perche' gia' e' difficile difendere l'utilitarismo (in qualsiasi forma esso si presenti), ancor piu' difenderne la versione originaria. Per ammissione dello stesso Pontara, l'utilitarismo classico ha molte implicazioni problematiche e i tentativi del filosofo trentino di evitarle non sempre vanno a segno. Per Pontara le principali obiezioni rivolte all'utilitarismo sono neutralizzabili distinguendo all'interno della teoria in questione l'etica teorica utilitarista dal metodo di deliberazione utilitarista. Cosi' facendo l'utilitarismo dell'atto, che Pontara intende difendere, acquisisce i pregi dell'utilitarismo della norma, divenendo compatibile con le regole non utilitariste della morale positiva. Se l'utilitarismo come metodo di deliberazione risulta inaccettabile, le critiche non risultano invece fatali per l'utilitarismo come teoria etica. Pontara e' comunque consapevole dei problemi che l'utilitarismo continua ad avere. Per questo, come gia' aveva fatto in Filosofia pratica, punta molto sul fatto che le teorie alternative, a suo avviso, presentano problemi ancora piu' grandi.
Se l'autore ha buon gioco nel difendere l'utilitarismo dell'atto nei confronti dell'utilitarismo della norma, maggiori perplessita' suscita la sua difesa ad oltranza dell'edonismo puramente quantitativo (non ci sono fattori qualitativi che differenziano uno stato di coscienza piacevole da un altro; gli unici tratti differenziali sono quantitativi: l'intensita' e la durata).
Essa giunge all'esito paradossale di giustificare l'entrata nella cosiddetta 'stanza della felicita''. Supponiamo che esista una stanza al cui interno vi e' una macchina prodigiosa la quale fornisce a chi entra nella stanza esperienze e sensazioni piacevoli, tali da rendere la vita di una persona che vi si stabilisce per il prosieguo dei suoi giorni un po' piu' felice che nel caso in cui non vi entri. "L'utilitarismo classico, puramente edonistico, implica che l'individuo deve entrare nella stanza: anche se cio' comporta una perdita di conoscenza, del contatto con gli altri, con il mondo, la perdita di una vita attiva, della propria identita' personale, del libero processo di realizzazione di se', della propria autonomia"(pp.135-136). Questo perche' la conoscenza, la liberta', l'autonomia ecc. Non hanno valore intrinseco. La conclusione non puo' che lasciare perplessi. Ma vi sono altri punti discutibili nell'utilitarismo e nella difesa ad oltranza che Pontara intende farne.
Credo che Pontara sbagli a ribadire la tesi (gia' espressa nel volume del 1974) per cui i fattori intenzionali e motivazionali non hanno alcun peso per stabilire se un'azione e' giustificata moralmente oppure no (un'idea non solo utilitaristica, ma comune anche a molte teorie non conseguenzialistiche). Permangono molti dubbi sul fatto che le intenzioni e i motivi non siano almeno una condizione necessaria per stabilire lo status deontico delle azioni (si vedano in proposito le acute considerazioni di un vecchio libro di Oliver A. Johnson, Rightness and Goodness. A Study in Contemporary Ethical Theory, The Hague, Netherlands, Martinus Nijhoff, 1959, passato quasi del tutto inosservato nel nostro paese). Inoltre, per quanto ingegnosi ed acuti, rimangono infruttuosi i tentativi di Pontara di difendere l'utilitarismo classico dalla cosiddetta 'conclusione ripugnante' (la terminologia risale a Reasons and Persons di D. Parfit). Se essa colpisce direttamente l'utilitarismo del totale (che Pontara intende difendere), ma e' superabile con l'utilitarismo della media, i problemi di giustizia distributiva e retributiva colpiscono invece ogni forma di utilitarismo. Mi limitero' ad esemplificarlo, per ragioni di spazio, con la giustizia distributiva. La critica che da sempre viene mossa all'utilitarismo e' di non tener in alcuna considerazione il modo in cui vengono distribuiti i beni (o i mali), interessato com'e' esclusivamente alla massimizzazione di essi. In particolar modo quando sono in gioco alternative di azione che producono la medesima utilita' generale. Ma due azioni alternative possono produrre la medesima utilita' generale e distribuirla in maniere molto diverse. Il modo in cui essa e' distribuita non pare essere indifferente per una teoria della condotta. Sotto questo profilo l'utilitarismo 1) non ci dice se, a parita' di utilita' prodotta, sia preferibile un'azione che la distribuisce allo stesso numero di individui in maniera (piu') uguale, o una che invece la distribuisce in maniera diseguale;
2) non ci dice se, a parita' di utilita' prodotta, sia preferibile un'azione che la distribuisce tra piu' persone o una che la distribuisce tra meno persone. In entrambi i casi il principio di utilita' e' muto. E' indifferente optare per un'alternativa o per l'altra. All'utilitarista interessa solo la quantita' totale dei beni prodotti. Poi tutti gli altri fattori non gli interessano. Se essa e' distribuita egualmente tra le persone, se essa e' distribuita tra piu' persone o tra meno persone, sono questioni su cui l'utilitarismo in quanto tale non ha nulla da dire. E questo non pare essere un difetto marginale.
Vediamo di esemplificare graficamente i due problemi distributivi dell'utilitarismo nei contesti in cui due linee di azione producono la medesima utilita' totale. Primo esempio: l'azione S1 e l'azione S2 hanno entrambe effetti su 5 individui (A1 ... A5), producendo entrambe su di essi un bilancio di beni e mali pari a 20 unita'. Ma mentre S1 distribuisce queste 20 unita' in maniera eguale sui 5 individui coinvolti (a tutti e 5 le stesse 4 unita'), S2 le distribuisce in maniera diseguale.
...............................................S1.........................S2
A1............................................4............................5
A2........................................... 4............................2
A3............................................4............................8
A4............................................4............................1
A5............................................4............................4
Somma algebrica........................20..........................20
Secondo esempio: l'azione T1 e l'azione T2 producono entrambe un bilancio comparato di beni e di mali pari a 20 unita'. Ma mentre T1 ha effetti su 6 individui (B1 ... B6), l'azione T2 ha effetti su due soli individui (B3 e B6).
...............................................T1.........................T2
B1........................................... 5 ...........................
B2............................................3 ...........................
B3............................................4...........................10
B4............................................5 ...........................
B5............................................2 ...........................
B6............................................1...........................10
Somma algebrica........................20.........................20
In entrambi i casi noi diremmo che sono rispettivamente S1 e T1 le due linee di azione da eseguire. Invece per l'utilitarismo e' del tutto indifferente mandare ad effetto la prima alternativa o la seconda in entrambi gli esempi, perche' l'utilita' da esse prodotte e' esattamente la stessa. Ed anzi nel caso in cui le linee di azione che distribuiscono i beni in maniera piu' equa (S1 e T1) producano una somma algebrica lievemente inferiore a quella prodotta dalle loro alternative (S2 e T2), ecco che l'utilitarista e' addirittura costretto a sostenere la doverosita' delle linee di azione disegualitarie. Ma risulta perlomeno dubbio che esse siano le azioni da mandare ad effetto. Mi pare che queste siano implicazioni inaccettabili dell'utilitarismo. Lo stesso tipo di problema non sussiste soltanto per l'utilitarismo consueto, cosiddetto del totale, ma anche per il piu' recente utilitarismo della media, che, come ho gia' rilevato, consiste nel dividere le singole somme algebriche delle conseguenze di ciascuna linea di azione per il numero di individui coinvolti dall'azione. L'utilitarismo della media ha si' a che fare con situazioni in cui due linee di azione investono un numero diverso di persone e le differenzia in maniera rilevante rispetto all'utilitarismo totale. Ma solo quando l'utilita' totale prodotta da due azioni e' diversa. Quando l'utilita' totale prodotta da due azioni e' la stessa allora la differenza dall'utilitarismo totale non si vede piu', o in ogni caso diminuisce notevolmente, si vede solo nei contesti di distribuzione di mali.
Che cosa replica Pontara rispetto a questo tipo di obiezioni? Due cose fondamentalmente:
1) che non esiste una misura della disuguaglianza; 2) che se aggiungiamo al valore dei benefici anche quello della loro distribuzione, non disponendo di un modello che ci dica quando ha la precedenza l'uno e quando ha la precedenza l'altro, la teoria dell'obbligo perde la sua completezza. Pontara fa vedere molto bene, con la lucidita' e la chiarezza che gli sono solite, quanto sia problematico individuare una misura della disuguaglianza. Per cui fra due distribuzioni disuguali degli stessi beni e' estremamente arduo, difficile, stabilire quale sia la piu' equa, la meno diseguale. Ma la replica non sfiora minimamente il caso in cui una delle due distribuzioni , a parita' di utilita' prodotta, e' ugualitaria.
Ovvero rimane il fatto che nel caso in cui due azioni A e B producano la medesima eccedenza di bene sul male (o, per dirla in termini piu' corretti, la medesima somma algebrica) e A la distribuisce in maniera uguale a tutti mentre B la distribuisce in maniera disuguale, l'utilitarismo ritiene soltanto lecito moralmente mandare ad effetto A e non obbligatorio, quando invece A e' sicuramente obbligatoria. E anche nel caso in cui l'utilita' prodotta da A sia lievemente inferiore a quella prodotta da B, ma al contrario che di essa sia distribuita ugualmente, e' A l'azione obbligatoria o perlomeno lecita, mentre per l'utilitarismo e' obbligatoria (e non solo lecita) l'azione alternativa B. Quanto al problema della completezza di una teoria dell'obbligo, Pontara sembra fare un vanto dell'utilitarismo classico il fatto che esso e' una teoria completa: per ciascuna circostanza e' in grado di dirci in via di principio qual e' l'azione da mandare ad effetto da un punto di vista morale. Una teoria che voglia tener di conto, oltre che della massimizzazione del benessere, anche della sua distribuzione ugualitaria si trova di fronte al difficile problema di quale delle due istanze far prevalere nel caso in cui esse si trovino in conflitto (ovvero nel caso in cui l'azione piu' benefica non sia anche quella piu' egualitaria). E poiche' non si danno risposte, metodi precisi, ecco che la teoria perde la sua completezza. A me pare che sia preferibile tenersi l'incertezza sul conflitto tra un principio di utilita' e un principio di distribuzione uguale piuttosto che disporre di un sistema completo che pero' sull'altare della completezza sacrifica le esigenze della giustizia.
Francesco Allegri
1 Al di la' della terminologia ('fallacia naturalistica'), che e' di Moore e non di Price, sia l'uno che l'altro non ritengono fallace solo la riduzione dei concetti morali in termini naturali, ma ogni sorta di negazione dell'autonomia dell'etica. E' erroneo, a loro avviso (come risultera' anche dalle esemplificazioni), pure ridurre i concetti morali in termini teologici.
2 A. Pap, Introduzione alla filosofia della scienza, Bologna, Il Mulino, 1967, p. 617.
3 Cfr. D. Hume, Trattato sulla natura umana, in Opere, a cura di E.Lecaldano e E. Mistretta, Bari, Laterza, 1971, 2 voll., vol. I, pp. 496-497.
4 Fra i sostenitori novecenteschi di un siffatto argomento si vedano tra gli altri, P. H. Nowell-Smith, Etica, Firenze, La Nuova Italia, 1974, pp.36-37; F. E. Oppenheim, Etica e filosofia politica, Bologna, Il Mulino, 1971, p. 120; W. C. Salmon, Logica elementare, Bologna, Il Mulino, 1979, pp.28-32, ma anche p. 138; B. Skirms, Introduzione alla logica induttiva, Bologna, Il Mulino, 1974, pp. 23-24; D. D. Raphael, The Moral Sense, London, Oxford University Press, 1947, p. 66; J. Hospers, An Introduction to Philosophical Analysis, London, Routledge, 1990, pp. 106-107.
5 Per un'analisi approfondita del contributo di Price alle questioni ontologiche, epistemologiche e logico-semantiche concernenti l'etica, mi sia consentito rinviare a F. Allegri, La "Review" di Price e il fondamento della virtu', "Studi settecenteschi", n. 18, 1998, pp. 65-87.
6 E' a questa forma, quella della domanda, che si deve l'attribuzione del nome open question argument ad un tal modo di procedere. Infatti si dice: e' impossibile che 'buono' (ad esempio) significhi 'desiderato', perche' altrimenti chiedersi 'il piacere e' desiderato, ma e' buono?' non sarebbe una questione aperta come di fatto e'. Sarebbe una domanda sciocca, inutile, perche' avrebbe gia' incorporata in se' la risposta.
7 In termini formali: ((p ® q) ( (q( ® (p.
8 L'argomento in questione, comunque, e' stato sostanzialmente riproposto anche di recente. Cfr. Sandro Nannini, Filosofia analitica e linguaggio morale. Una difesa della 'legge di Hume', "Annali dell'Istituto di filosofia di Urbino", 3/4/5, 1988/89/90, pp. 265- 280 (ora in S. Nannini, Il Fanatico e l'Arcangelo. Saggi di filosofia analitica pratica, Siena, Protagon, 1998, pp. 61-74, p. 71). E' singolare che Nannini non abbia dedicato neppure una riga alle critiche, numerose ed acute, rivolte ormai da molti decenni a questo principio.
9 Cfr. G. Carcaterra, Il problema della fallacia naturalistica. La derivazione del dover essere dall'essere, Milano, Giuffre', 1969. Il capitolo specifico sul tema del riduzionismo etico (la presunta fallacia di definire i termini etici interamente in termini non etici) e' il V, "Moore e il problema delle definizioni", pp. 207-420.
10 I problemi suscitati dalla sostituzione del definiendum col definiens nei contesti virgolettati si vedono molto bene nell'antinomia della relazione di denominazione, di cui Carcaterra (ivi, p. 323) riporta un celebre esempio di B. Russell: "quando a e' identico a b, noi possiamo sostituire in ogni proposizione a con b senza alterare la verita' o la falsita' della proposizione stessa; ora, indubbiamente Scott e' (si identifica con) l'autore di Waverley, e percio' ovunque compaia il nome 'Scott' poi potremo sostituirlo con la frase descrittiva 'l'autore di Waverley'; ma se facciamo l'esperimento ci troviamo di fronte a risultati inaccettabili: p. e. Consideriamo la frase 'Giorgio IV desiderava sapere se Scott fosse l'autore di Waverley', e operiamo la sostituzione; avremo: 'Giorgio IV desiderava sapere se Scott fosse Scott': ma e' difficile attribuire al primo gentiluomo d'Europa, nota Russell con arguzia, un effettivo interesse per la legge di identita'."
11 Ma anche rimanendo all'interno del linguaggio ordinario, gia' una definizione intricata come quella di 'zio' (e se ne potrebbero fare molte altre) non rende la congiunzione tra definiens e definiendum una self-answering question.
12 G. Carcaterra, Il problema della fallacia naturalistica, cit., p. 328 e seguenti.
13 Ivi, p. 393 e seguenti. Ma e' da vedere tutto il contesto. Nel nostro secolo le correnti non cognitivistiche hanno cercato di riproporre la tesi dell'indefinibilita' dei giudizi etici, fondandola sul tema della diversa funzione pratica che questi eserciterebbero rispetto ai giudizi in cui vengono ascritte proprieta' alle cose e non piu' sull'open question argument; anche se la forma che il nuovo argomento assume non e' dissimile dal test della questione aperta (si veda per tutti R. M. Hare, Il linguaggio della morale, Roma, Ubaldini, 1968). Una siffatta versione dell'anti-definizionismo non e' adottabile da Price e da Moore che attribuiscono al linguaggio morale una funzione denotativa. E poi in ogni caso non e' detto che possa avere miglior sorte. Proprio Carcaterra fa alcune considerazioni estremamente acute sulla nuova versione della critica alla fallacia naturalistica (si veda il capitolo VI). Ma tutto cio' esula dai limiti che mi sono posto scrivendo questo saggio.