
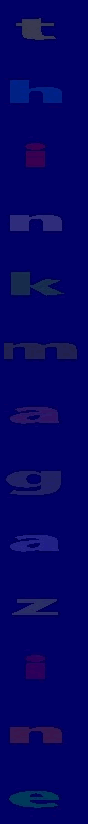
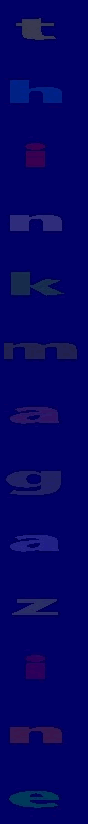
La fede come fenomeno virale cognitivo in Richard Dawkins
Il biologo inglese Richard Dawkins, in un saggio intitolato Viruses of the Mind, i ha tentato di attaccare la religione su basi scientifiche. La posizione di Dawkins e' provocatoria: secondo lui quella peculiare modalita' del credere che e' il 'credere per fede' sarebbe una sorta di meccanismo di difesa per un 'virus della mente', un modo di pensare pericoloso, perche' esporrebbe a delle vere e proprie malattie, che sarebbero le religioni. La fede e' uno dei tanti temi religiosi, ma certamente ha una grande rilevanza nel dibattito filosofico sulla religione e sul rapporto tra religione e scienza. Percio' mi pare che valga la pena di prendere in esame, con lucidita', le argomentazioni di Dawkins.
Dawkins e' una figura importante nella biologia degli ultimi anni, ed e' noto anche ai non specialisti per due idee: osservare la selezione naturale dal punto di vista dei geni, applicare la spiegazione biologica allo studio della trasmissione culturale. La prima idea ha dato origine a un filone di interpretazione dell'evoluzione, che potremmo etichettare come 'visione del gene egoista'.ii Volendo tradurla in uno slogan senza tradirla troppo, potremmo dire: secondo Dawkins gli interessi fondamentali per la spiegazione biologica sarebbero quelli dei geni, iii e la riproduzione degli organismi (per capire il meccanismo dell'evoluzione) andrebbe interpretata come un mezzo per la propagazione dei geni. La seconda idea ha dato origine alla memetica, che potremmo definire come il metodo della spiegazione 'darwiniana' applicato alla storia delle idee, o piu' esattamente all'analisi dei fenomeni della trasmissione culturale. Come risulta da quanto anticipato sopra, l'analisi della fede proposta da Dawkins in Viruses of the Mind, rientra nella 'memetica', non nella biologia.
Per poter capire l'argomentazione di Dawkins dovremo dunque cercare di comprendere, con le indispensabili semplificazioni, le idee che ne costituiscono il contesto teorico. Una esposizione veramente ridotta all'osso e strettamente funzionale al tema di questo articolo, e' fornita nel paragrafo seguente. Essa non puo' costituire in alcun modo un'introduzione ai metodi e soprattutto ai problemi della memetica, ne' si puo' prendere per una "iniziazione" dogmatica. Le idee di Dawkins sulla trasmissione culturale non sono un luogo comune scientifico. Anzi sono molto discusse, solo che questa e' un'altra storia. iv Semplicemente, Dawkins fa della memetica in questo saggio, e nel paragrafo seguente cerco di dare un'idea di che cosa intende fare.
Memetica
La biologia contemporanea deve a Charles Darwin, tra le altre cose (ma e' la piu' importante), un modo di spiegare le caratteristiche degli esseri viventi: la teoria della selezione naturale.vLa biologia dopo Darwin e' diventata 'darwiniana' perche' ha utilizzato in lungo e in largo spiegazioni 'darwiniane' delle proprieta' degli esseri viventi. In estrema sintesi spiegare una caratteristica di un organismo in modo 'darwiniano', cioe' in base alla selezione naturale, significa far risalire il fatto che essa si e' diffusa ai suoi effetti sulla capacita' di riprodursi degli organismi che ne sono portatori.
Per questo si considera una spiegazione dell'affermazione (diffusione) di un certo carattere la prova che esso rende i suoi portatori adatti all'ambiente: perche' l'adattamento all'ambiente favorisce la riproduzione, e i figli assomigliano ai genitori.
Rimanendo a questo livello di altissima semplificazione, si puo' indicare nel DNA la grande differenza tra la biologia contemporanea e quella di Darwin. Darwin notoriamente ignoro' la teoria dei geni di Mendel, che in qualche modo si puo' considerare un'anticipazione della genetica attuale. La scoperta del DNA e il conseguente avvio di uno straordinario lavoro di analisi e di interpretazione del 'codice genetico' hanno introdotto una grande novita' epistemologica nella biologia: la possibilita' di un approccio 'informazionale'. I geni determinano molte caratteristiche dell'organismo, e questa correlazione ci permette di 'leggere' i geni, cioe' di attribuire loro un 'significato', nei termini dei loro effetti sull'organismo. Essi vengono 'letti' come istruzioni per costruire un corpo, quelle che vengono eseguite con la crescita. Questo suggerisce molte analogie affascinanti. Una delle piu' immediate e' quella tra il corredo genetico degli organismi e i programmi per computer (che sono appunto delle serie di istruzioni).
Il 'darwinismo' si basa essenzialmente su una condizione: la 'discendenza con modificazioni'. vi Oggi potremmo dire (con Monod vii e Dawkins viii) che la condizione e' l'esistenza di una replicazione imperfetta, cioe' di oggetti che vengono replicati con (rari) errori. Il DNA produce copie di se stesso, che solo di rado sono (lievemente) diverse dall'originale. I geni non sono altro che configurazioni di parte del DNA di un organismo, configurazioni che vengono 'ereditate' nella riproduzione. I figli nascono con geni presi da quelli dei loro genitori e cosi' dipendono da loro per le caratteristiche determinate genicamente. ix
Questo permette di dare una formulazione astrattax alla teoria della selezione naturale: dovunque c'e' un processo automatico di copiatura con variazioni relativamente piccole, si possono tentare 'spiegazioni darwiniane'.
La 'memetica' e' il tentativo di spiegare la diffusione delle idee e quindi la storia delle idee in modo darwiniano, come un adattamento delle idee stesse alle menti delle persone (i loro ambienti, costituiti da altre idee) in competizione per l'attenzione e la memoria dei soggetti pensanti. Presupposto di questo tentativo e' che la trasmissione culturale (e in particolare l'insegnamento) sia una copiatura (lievemente imperfetta) delle idee. Nella teoria di Dawkins i 'memi' sono la controparte culturale dei 'geni', le unita' dell'eredita' biologica: egli definisce i 'memi' come le unita' dell'imitazione nel comportamento umano. xi
Virus della mente
Se il DNA, il computer e il cervello sono veicoli di informazioni, l'approccio 'informazionale' puo' permetterci, estendendo l'analogia tra 'codice genetico', programma per computer e idee, di fare un po' di epidemiologia astratta o di epidemiologia comparativa, confrontando processi di replicazione diversi: la duplicazione del DNA, la duplicazione dei programmi e la trasmissione culturale.
Tutti gli utenti di personal computer hanno sentito parlare dei virus informatici. xii Un virus e' un programma che produce copie di se stesso, automaticamente: esso contiene l'istruzione 'duplicami' e la esegue autonomamente, senza informare l'utente. xiii In questo modo, se una copia del virus viene eseguita, essa provvedera' a registrare una sua copia nel disco del computer, all'insaputa dell'utente. Altra caratteristica dei virus e' quella di inserire le loro copie in altri programmi, in modo che, una volta registrate, esse vengono anche inconsapevolmente eseguite. Tutti gli utenti di personal computer sanno che i virus procurano danni. Ma questo non vale in tutti i casi, ne' tanto meno vale di necessita': un virus puo' benissimo essere innocuo o addirittura benefico, cosi' come puo' essere un vaccino anti-virus.xiv
Se si accetta il punto di vista astratto sulla selezione naturale, si puo' considerare letterale l'impiego del termine 'virus' in informatica. Al livello astratto, il meccanismo di trasmissione dei virus dei computer presenta forti somiglianze con quello dei virus che infettano il DNA. Piu' importante per le nostre questioni e' il fatto che la diffusione dei virus per computer puo' essere considerata come un adattamento dei virus stessi ai computer. Essi infatti entrano in lotta per la sopravvivenza con i programmi anti-virus con i quali l'utente difende il suo computer dalle infezioni. Gli 'anti-virus' scoprono i virus e li cancellano. Queste caratteristiche del loro 'ambiente' (cioe' dei computer che essi infettano) favoriranno i virus che sono in grado di difendersi abbastanza da potersi replicare ancora.xv Cosi' le strategie di difesa dei virus, che sono in primo luogo strategie di occultamento, sono di importanza decisiva per le loro chances di diffondersi tra i computer in funzione nel mondo (insieme ovviamente alla frequenza di scambi di programmi e dati tra i computer).
Dawkins pensa che le religioni siano 'virus della mente', cioe' idee o memi che si diffondono nelle menti delle persone attraverso il contagio. Questa tesi presuppone che la causa del fatto che una persona ha una certa credenza religiosa sia la tradizione. Secondo Dawkins nella stragrande maggioranza dei casi un credente accetta una certa dottrina religiosa perche' essa e' quella che prevale nel suo ambiente (la famiglia o piu' ampiamente il suo contesto sociale). Se non e' cosi' allora la sua tesi (le religioni sono 'virus della mente') non vale. Su questo presupposto si basa anche la sua contrapposizione tra religione e scienza: anche la scienza e' una tradizione culturale che viene trasmessa da una generazione all'altra attraverso l'insegnamento, pero' la causa del fatto che una persona ha una certa credenza scientifica e' secondo Dawkins non il mero contagio, ma la sostenibilita' della credenza (misurata rispetto a certi canoni di razionalita'xvi). Insomma secondo Dawkins le persone (nella grande maggioranza dei casi) crederebbero in certe dottrine religiose solo perche' gliele hanno insegnate, la loro accettazione sarebbe priva di giustificazioni, di ragioni. Dawkins non porta alcuna prova a sostegno di questa tesi; sembra considerarla una verita' risaputa, un luogo comune vero.xvii Ma il punto che ci interessa e' un altro, l'analisi di un fenomeno cognitivo peculiare di alcune dottrine religiose, il 'credere per fede'.. Vedremo quanto esso sia importante per l'argomentazione di Dawkins.
La fede e l'epidemiologia informazionale della religione
Dawkins da' una definizione della fede: "qualche profonda, intima convinzione che qualcosa e' vero, o giusto, o virtuoso: una convinzione che non sembra dover nulla alle prove o alla ragione, ma che, cio' non ostante, egli [il credente - F.C.] sente come totalmente stringente e convincente". xviii
Rifacendosi a citazioni varie, da Tertulliano a Anthony Kenny xix, Dawkins cerca di suggerire (piu' che provare) che la fonte di persuasione della credenza religiosa e' spesso l'assenza di ragione. Dawkins ci raffigura i religiosi come degli atleti della credenza, che cercano di andare sempre oltre il limite, di ottenere una prestazione estrema, o se si vuole come degli artisti della credenza, che esercitano il virtuosismo del credere. xx Secondo Dawkins il vanto del religioso e' riuscire a credere in cio' che per il profano e' piu' incredibile, rifacendosi a una morale che potremmo riassumere nel seguente principio: piu' il tuo credere e' privo di giustificazione e piu' grande e' il tuo merito. Questo principio e' etichettato da Dawkins come "lack of evidence is a virtue", cioe' "la mancanza di prove e' una virtu' ". La forza della fede verrebbe misurata dal riuscire a credere in cio' in cui gli altri non possono credere. Qui Dawkins vede una grande contrapposizione tra religione e scienza: mentre la mentalita' scientifica attribuirebbe alle credenze un valore commisurato alla loro giustificazione o 'fondatezza', la mentalita' religiosa attribuirebbe a esse un valore commisurato alla loro non-giustificazione o 'infondatezza'. Collegata a questo aspetto della fede e' la valorizzazione del mistero, un principio che Dawkins formula come "il mistero e' una virtu' ".
Fermiamoci qui. I punti centrali dell'analisi epidemiologico-informazionale della fede di Dawkins sono questi due.
Abbiamo visto che per l'epidemiologia dell'informazione, e piu' in generale per la memetica, sono di importanza essenziale le difese delle idee (dei 'memi'). Dawkins interpreta il principio "la mancanza di prove e' una virtu'" come un meccanismo di difesa delle dottrine. Esso e' un trucco adattivo, cioe' una strategia che favorisce l'adattamento delle idee alle menti delle persone, perche' le difende dalla confutazione.xxi La confutazione e' una minaccia per la sopravvivenza delle idee nelle menti, ma il rovesciamento del valore cognitivo della giustificazione (fondatezza, supporto di prove) e' un trucco con il quale un'idea puo' rafforzarsi se attaccata razionalmente. Come dice Dawkins: "Una volta che la proposizione e' creduta, essa scardina automaticamente l'opposizione a se stessa". xxii
L'altro virus, al quale fa riferimento Dawkins, che rinforzerebbe la fede e ne favorirebbe la sopravvivenza e la diffusione nelle menti delle persone e' il principio "il mistero e'una virtu' ": cioe' l'idea anti-razionalista che ci sono dei misteri che e' meglio non risolvere, anzi che devono restare insoluti. Anche questo principio e' una difesa della fede dalla confutazione, anzi alla auto-confutazione: xxiii se la dottrina dovesse contenere delle apparenti assurdita', queste dovrebbero essere ritenute degne di fede e anzi di un particolare prestigio, proprio perche' 'misteriose'. I fenomeni del virtuosismo ovvero dell'atletica della credenza sono visti da Dawkins come casi estremi di questa valorizzazione del mistero. xxiv
Queste strategie di difesa sono importantissime per la teoria di Dawkins, perche' in fondo la tesi che la religione e' un virus si basa proprio su di esse, oltre che sulla fede. Analizzate dal punto di vista della memetica, le idee religiose si caratterizzerebbero per la diffusione epidemica, cioe' per il fatto di dovere la loro diffusione al contagio. Una tradizione che e' tramandata per mezzo della discussione critica non sarebbe considerata da Dawkins un virus, perche' in essa la causa dell'affermazione di una certa idea non sarebbe la mera trasmissione, ma la trasmissione accompagnata da una giustificazione razionale delle credenze trasmesse.xxv Una credenza puo' essere autosufficiente (quindi indipendente dalla giustificazione razionale) nella misura in cui la nuova generazione di credenti e' disposta ad accogliere le dottrine indipendentemente dalla loro giustificazione razionale. Cosi' e' proprio perche' sono "credute per fede", che Dawkins pensa di poter considerare le dottrine religiose come virus. Inoltre i due principi di cui abbiamo discusso non sono altro che l'apologia della fede, intesa come credere senza ragione; essi non fanno altro che attribuire alla "fede cieca" (cioe' alla credenza priva di ragione) un valore superiore rispetto alla credenza razionale (razionalmente giustificata).
Per quanto riguarda il tema piu' ampio della critica della religione, Dawkins, al massimo, se e' riuscito a provare che la fede e' diametralmente opposta alla ragione e incompatibile con essa, puo' concludere che essa deve necessariamente entrare in conflitto con la scienza. Ma da qui a mostrare che la religione e' dannosa ce ne corre. Cosi' come virale non vuol dire necessariamente nocivo. Dawkins e' al massimo riuscito a mostrare che i valori (cognitivi) della religione entrano in conflitto con i valori (cognitivi) della scienza, ma la sua tesi e' che i secondi sono migliori dei primi, per gli interessi degli esseri umani, e questo punto resta fuori della portata della sua argomentazione (come peraltro ha subito osservato Dennett, xxvi che pure e' d'accordo con Dawkins sull'opposizione tra la mentalita' della scienza moderna e quelle delle religioni).
Un'altra contrapposizione tra scienza e religione serpeggia per tutto Viruses of the Mind, curiosamente senza venire mai in superficie: quella tra dipendenza e indipendenza delle persone rispetto alle idee. Dawkins ci suggerisce che chi e' persuaso da un'argomentazione o da una prova 'scientifica' a favore di una determinata tesi, nell'accettarla agisce per conto suo, mentre colui che abbraccia una credenza religiosa piuttosto la subisce, diventa un veicolo di una sorta di parassita (Dawkins pensa tra l'altro ai dogmi, come la transustanziazione e la trinita'). Secondo questa visione della questione, la religione propagherebbe se stessa in forza della sua attitudine all'auto- propagazione, mentre la scienza propagherebbe se stessa in forza dell'interesse dell'individuo che viene a contatto con essa. Parafrasando la piu' fortunata delle metafore di Dawkins, mentre la religione sarebbe un meme egoista, la scienza sarebbe un meme altruista. Avremmo cosi' idee che si diffondono in un modo che prescinde dagli interessi e dalla volonta' dei loro portatori ('memi egoisti'), e altre che invece si diffondono in virtu' delle scelte dei loro portatori e quindi in funzione dei loro interessi ('memi altruisti'). xxvii
Questa, benche' come ho gia' rilevato stranamente resti implicita, e' forse la tesi piu' interessante di Viruses of the Mind, perche' promette di soddisfare la maggiore ambizione della critica della religione di Dawkins: fondarsi su una spiegazione 'epidemiologica' della tradizione religiosa. L'"altruismo" e l'"egoismo" dei "memi", sia pure nei sensi non letterali che questi termini assumono nel discorso di Dawkins, sono proprieta' che hanno una rilevanza etica. Cosi' Dawkins potrebbe tentare di giustificare la sua opposizione alla religione fondandola su una valutazione di questo tipo: le persone devono avere il controllo sulle loro idee, e non essere controllate da esse. Questo mi pare lo sfondo etico dell'opposizione razionalistica di Dawkins contro la fede: un appello alla dignita' della natura umana, che meriterebbe il controllo sui "memi". Secondo questa tesi etica (per nulla innovativa) che si puo' tentare di estrapolare dai suoi testi, Dawkins riterrebbe pericolosa la fede perche' vi vedrebbe una minaccia per l'indipendenza dell'intelletto.
Naturalmente a tutto cio' si puo' opporre che le religioni di solito attribuiscono alle loro tradizioni un'origine divina, xxviii attribuiscono a enti soprannaturali almeno l'ispirazione degli autori dei testi sacri, quando non affermano addirittura che l'autore e' una divinita', e quindi la mancanza di controllo su certe idee puo' essere interpretata (dai religiosi) come una conseguenza dei limiti dell'intelligenza umana.
Ma c'e' dell'altro. L'intero discorso di Dawkins su fede e religione presuppone che quest'ultima non comporti dei vantaggi pratici e non abbia un valore di adattamento (per gli uomini intendo), e questa tesi, tutt'altro che "autoevidente", e' data da Dawkins per scontata.
A cosa servono le novita' introdotte da Dawkins, cioe' l'uso dei virus dei computer come modello, e l'adozione del metodo "darwiniano" della spiegazione adattiva? I virus sono programmi giustamente temuti e combattuti da tutti gli utenti di computer (e i loro autori sono giustamente odiati), cosi' i virus delle malattie, che alterano il funzionamento normale dell'organismo, sono temuti e combattuti da tutti. Ma attenendosi al punto di vista memetico, allo studio delle modalita' della trasmissione culturale, Dawkins deve definire il virus della mente semplicemente come un'idea che replica se stessa senza giustificazione razionale, e questo a prescindere dal fatto che gli effetti di tale idea siano benefici o nocivi (esclusi gli effetti derivanti dal modo di trasmissione stesso): l'accostamento dei virus della mente ai virus nocivi, che sono quelli a cui subito si pensa sia nel caso genico che in quello informatico, e' semplicemente un momento di cattiva retorica di Viruses of the Mind.
Altra cosa sarebbe trovare della patologicita' nel fatto stesso della trasmissione virale. E qualcosa del genere ci potrebbe effettivamente essere, nella sua concezione della religione, ma Dawkins non lo esplicita mai. Per cogliere il punto bisogna fare un salto dall'evoluzione culturale a quella biologica: il funzionamento normale del cervello, potrebbe sostenere Dawkins, e' la razionalita', cioe' l'accettazione delle credenze sulla base della loro giustificazione oggettiva, perche' e' questo che spiega l'evoluzione del cervello, quindi la fede altera il funzionamento normale del cervello (spingendo a rinunciare alla spiegazione e alla giustificazione). Dal punto di vista biologico, pero', la razionalita' viene dopo l'adattamento all'ambiente, e quindi questo argomento presuppone, ancora una volta, che la "credenza per fede" non sia funzionale all'adattamento. Cio' richiede una giustificazione, e a prima vista pare dubbio. Dopo tutto la religione stessa potrebbe essere, dal punto vista biologico, un adattamento dell'uomo all'ambiente naturale.
Ben piu' interessante del modello informatico e' certamente l'applicazione della selezione naturale allo studio della trasmissione culturale. La memetica, che ha ricevuto inizialmente un'accoglienza ostile, sembra che stia ottenendo un certo successo, o almeno un certo interesse in una parte della "comunita' scientifica". Dawkins qui pero' finisce per ammettere un'eccezione importante quanto la scienza. La sua argomentazione e' un'arma a doppio taglio, perche', se la ragione e' un "meme altruista", la memetica (posto che si voglia riconoscere un peso consistente alle motivazioni razionali) risulta inutile per lo studio della scienza e di buona parte dei fenomeni culturali. La ragione infatti sarebbe, per Dawkins stesso, un'alternativa alla selezione naturale come motore della "evoluzione culturale". Alla memetica resterebbe solo una parte della cultura: la moda in senso ampio, e soprattutto quelli che si chiamano "fenomeni di costume", e le parti "virali" della religione (se veramente ce ne sono).
Da ultimo pero' bisogna ribadire che una cosa appare convincente nella trattazione di Dawkins, ed e' l'idea che il 'credere per fede' sia una potente strategia di difesa, potente in particolare perche' tende a rinforzarsi all'aumentare degli attacchi contro la tesi difesa. Se c'e' qualcosa di interessante nella sua critica alla religione, dipende dalla possibilita' che questo tratto di certe concezioni religiose sia spiegabile "darwinianamente"; detto in modo meno criptico: dipende dalla possibilita' che la ragion d'essere dell'idea che si possa o si debba credere in qualcosa "per pura fede" sia la sua funzionalita' alla difesa di certe credenze, quale che sia il loro contenuto. Comunque anche su questo punto Dawkins sembra trascurare certi aspetti della posizione dei suoi avversari: la fede incoraggiata dalla religione e' una fede settoriale, limitata a certe regioni dei campi di credenze dei fedeli, e Dawkins stesso dovrebbe riconoscere che molto spesso sono proprio i religiosi a combattere con accanimento la superstizione. E' tutto da dimostrare che l'introduzione della modalita' peculiare della fede nelle credenze delle persone porti sempre a un'estensione della credulita' anche al di fuori delle questioni oggetto di prescrizioni religiose. xxix
Francesco Cirri
i Richard Dawkins, Viruses of the Mind, in B. Dahlbom (a c. di), Dennett and His Critics, Blackwell, Oxford (U.K.) & Cambridge (U.S.A.), pp.13-27.. Le citazioni da questo saggio in italiano sono state tradotte da me, i miei interventi tra parentesi quadre nelle medesime citazioni sono contrassegnati con la sigla 'F.C.'.
ii Cfr. il classico R. Dawkins, The Selfish Gene, 2a edizione riveduta, Oxford University Press, Oxford, 1989; tr.it. di G. Corte e A. Serra, Il gene egoista, Mondadori, Milano, 1992, e l'altro notevole libro, R. Dawkins, The Extended Phenotype, W.H. Freeman, Oxford, 1982; tr.it. Il fenotipo esteso, Zanichelli, Bologna, 1983. Una delle virtu' di Dawkins e' saper scrivere: i suoi libri migliori non sono solo profondi e innovativi, ma anche brillanti e scorrevoli. Cosi' puo' essere considerato uno dei capiscuola di una (felice) tendenza della letteratura scientifica degli ultimi anni, al superamento della barriera tra saggio scientifico e saggio divulgativo.
iii Se l'antropomorfismo di questa formulazione suona provocatorio (ma che dire di 'gene egoista'?), potremmo esprimere la visione del gene egoista cosi': cio' che fa diffondere certe caratteristiche degli organismi piu' di altre, e' la loro capacita' di favorire la replicazione dei geni; la riproduzione degli individui e la connessa conservazione della specie sono anch'esse funzionali alla replicazione dei geni.
iv Va osservato che lo stesso Dawkins non pretende di aver gia' fatto fare un salto di qualita' alle 'scienze umane', anche se spera di aver dato un contributo in vista di questo fine. Ammette anzi di essersi fermato al livello del suggerimento, e non ha mai tentato un'articolazione sistematica della 'memetica', nella convinzione che dovranno essere gli specialisti della storia delle idee a dire se essa e' un metodo veramente utile per quella disciplina, e ad applicarla. Dawkins intende rimanere un biologo. Anche Dennett, che si presenta come un sostenitore della memetica piu' convinto dello stesso Dawkins, presenta quella della possibilita' di una scienza 'darwiniana' della cultura come una questione aperta (cfr. Darwin's Dangerous Idea, Simon & Schuster, New York, Allen Lane, The Penguin Press, London, 1995; tr.it. L'idea pericolosa di Darwin, Boringhieri, Torino, 1997, cap.12). Ci sono infine delle incongruenze negli interventi pubblicati da Dawkins a difesa della sua proposta, incongruenze che potrebbero anche far pensare a dei cambiamenti di posizione da parte sua, come ha fatto puntualmente notare ancora Dennett (v. ibidem).
v L'autore di questo articolo non e' un biologo e nemmeno vuole fare finta di esserlo. Queste poche battute sulla selezione naturale non sono una breve introduzione alla biologia (e sarebbe prodigiosamente breve). Si tratta di una premessa essenziale per l'esposizione dell'argomento di Dawkins. C'e' solo quello che e' funzionale al mio discorso (spero che ci sia tutto quello che serve).
vi Ricordo che 'descent with modification' e' l'espressione impiegata da Darwin.
vii J. Monod, Le hazard et la ne'cessite', Editions du Seuil, Paris, 1970; tr.it. di Anna Busi, Il caso e la necessita', Mondadori, Milano, 1970 e successive ristampe (dal 1997 in Oscar classici moderni).
viii R. Dawkins, The Selfish Gene, cit.
ix La riproduzione e' un processo complicato, specialmente la riproduzione sessuale, e non c'e' ne' modo ne' scopo di descriverlo qui.
x Gli appropriati modelli matematici per lo studio astratto del 'meccanismo' della selezione, sono forniti dalla cosiddetta 'teoria dei giochi' (che e' una branca della matematica). Cfr. R. Dawkins, The Selfish Gene, cit., in particolare le considerazioni sulle 'strategie evolutivamente stabili'. D. Dennett, Darwin's Dangerous Idea, cit., e' una specie di monumento all'astrattezza del meccanismo alla base della 'selezione naturale' e delle 'spiegazioni darwiniane': secondo Dennett l'idea geniale (e 'pericolosa') di Darwin e' che il livello migliore per spiegare l'evoluzione delle specie e' quello algoritmico, cioe' indipendente dal substrato.
xi Un approccio concorrente allo studio della cultura e' stato proposto dall'antropologo Dan Sperber sotto il nome di "epidemiologia delle credenze".. Gia' dal nome si puo' cogliere l'affinita' tra la propsettiva di Sperber e quella di Dawkins, ci sono pero' delle fondamentali differenze, alle quali posso solo accennare dicendo che la teoria di Sperber lascia un'autonomia maggiore all'individuo rispetto a quella di Dawkins. Un confronto tra le due teorie, anche in relazione ai temi del saggio di Dawkins che sto analizzando, avrebbe a mio avviso un notevole interesse. Di Sperber si puo' leggere in italiano Il contagio delle idee, Feltrinelli, Milano, 1999.
xii Nell'epoca di Internet nella quale stiamo vivendo c'e' da essere certi che tutti gli utenti di personal computer abbiano avuto esperienza dei virus informatici.
xiii R. Dawkins, Viruses of the Mind, cit., p.14.
xiv Il metodo di copiatura "infettiva" (all'insaputa dell'utente) puo' essere vantaggiosamente impiegato da programmi di utilita', p.e. per l'aggiornamento di archivi. Per questi virus benefici v. R. Dawkins, Viruses of the Mind, cit., e H. Thimbleby, Can Viruses Ever Be Useful?, "Computers and Security", 10, 1991, pp.111-114.
xv Con questa "spiegazione darwiniana" possiamo rendere ragione dello strano gioco che si e' creato tra virus e anti-virus nell'ambiente informatico: piu' si lavora agli anti-virus e migliori sono i virus che vengono diffusi, ovvero il progresso dei vaccini determina il progresso anche degli agenti virali. E' cosi' che il successo della lotta contro i virus informatici fa si' che i nostri computer siano attaccati da virus sempre piu' sofisticati, e il livello della competizione si alza.
xvi "Il metodo scientifico" preso in senso molto lato, cioe' la valorizzazione della controllabilita' intersoggettiva, della ripetibilita', della validita' generale, della giustificazione sperimentale e statistica, e cosi' via.
xvii Personalmente non credo che la questione sia cosi' semplice, ma ci tornero' alla fine, quando proporro' qualche considerazione critica sull'argomentazione di Dawkins.
xviii R. Dawkins, Viruses of the Mind, cit., p.20. La traduzione italiana e' mia, cosi' come la precisazione tra parentesi quadre.
xix Filosofo inglese, noto soprattutto come interprete di Wittgenstein e di Aristotele, presidente della 'British Academy', ed ex prete cattolico, Kenny ha riassunto la sua esperienza religiosa, dalla conversione all'abbandono della Chiesa, in A. Kenny, A Path from Rome, Oxford University Press, Oxford, 1986.
xx Cfr. Dawkins, Viruses of the Mind, cit., p.22.
xxi A chi ha un po' di familiarita' con la contemporanea filosofia della scienza non sfuggira' l'affinita' delle considerazioni di Dawkins sulle strategie di autodifesa dei 'virus della mente' con alcuni temi popperiani (mi riferisco in particolare alle note tesi di Popper sulla 'demarcazione' della scienza e alle sue critiche contro il marxismo e la psicoanalisi).
xxii Dawkins, Viruses of the Mind, cit., p.21, cfr. anche D. Hofstadter, Metamagical Themas, Penguin, Harmondsworth, 1985, ivi citato.
xxiii Dawkins, Viruses of the Mind, cit., p.21, che rimanda ancora a D. Hofstadter, Metamagical Themes, cit..
xxiv Dawkins, Viruses of the Mind, cit., pp.21-22.
xxv Dawkins, Viruses of the Mind, cit., 4.
xxvi D. Dennett, Back From the Drawing Board, in B. Dahlbom (a c. di), Dennett and His Critics, cit., pp.203-235, nella risposta a Dawkins, Viruses of the Mind, cit., pp.204-205
xxvii Si noti che la "memetica" a rigore si occupa solo dei "memi egoisti": la sua ragion d'essere e' infatti lo studio della storia della cultura dal punto di vista delle idee stesse (e del loro adattamento alle menti delle persone): quando i soggetti umani cessano di essere "meri" veicoli dei memi, e acquistano il controllo delle loro idee, il "cieco meccanismo" della selezione e di conseguenza la spiegazione darwiniana perdono di importanza, e diventano invece decisive le scelte e le prese di posizione deliberate delle persone.
xxviii La scrittura sotto dettatura divina si puo' considerare un caso limite dell'ispirazione.
xxix Desidero ringraziare le persone che mi hanno incoraggiato a portare questo lavoro fino alla pubblicazione, in ordine alfabetico: Beatrice Biagini, Erik Boni, Dario Iozzelli, Marino Rosso. Grazie anche a Federico Squarcini per avermi ricordato di Sperber e per avermi suggerito di modificare l'incipit.